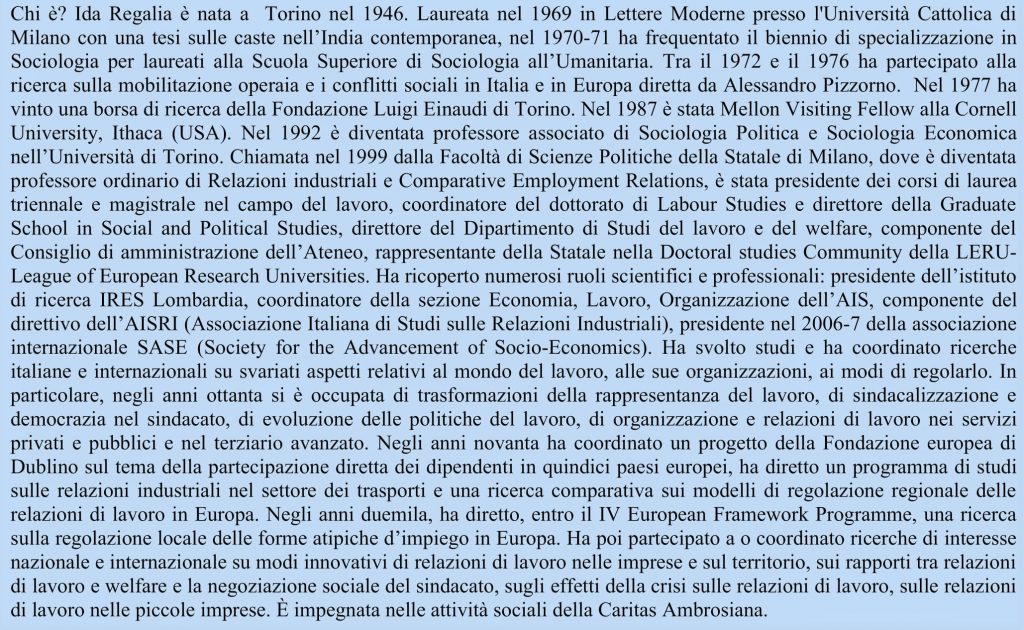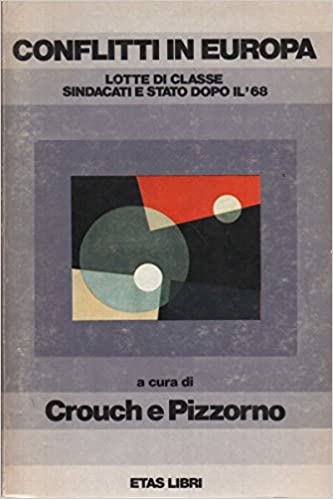In questa intervista raccolta da Sabrina Colombo, Ida Regalia ripercorre il suo percorso da studiosa, dall’avvicinamento fortuito alla sociologia nelle aule della Cattolica, durante i movimenti studenteschi, alla maturazione di una grande passione per la ricerca sociale, rafforzata dall’incontro con esponenti importanti della sociologia economica italiana come Guido Baglioni, Bianca Beccalli e Marino Regini e un grande maestro come Alessandro Pizzorno. Lungo l’intervista emerge con forza come la propria biografia personale e il proprio vissuto (come l’esperienza in India da bambina, il rapporto con il marito, la fede e l’impegno nell’associazionismo cattolico e nel sociale) abbiano arricchito il modo di fare ricerca e reso possibile una profondità di sguardo. È così che, ad esempio, il “ritrovarsi” donna in un contesto di ricerca maschile, come quello sindacale, permette di maturare una prospettiva privilegiata per l’analisi, attraverso la quale indagare le trasformazioni sindacali da un punto di vista pragmatico, andando oltre il sindacato di “fabbrica” per evidenziare il ruolo trasversale delle relazioni sindacali nella società e nel mondo dei servizi. L’attenzione alle persone e l’esigenza di ascoltarle non rappresentano soltanto il punto di partenza indispensabile per la ricerca sociale, ma esprimono un modo di vita in cui ricerca e impegno sociale si compenetrano e si rafforzano.
Cara Ida, sono stata una tua allieva fin dall’inizio della mia carriera e mi sembra ora doveroso farti ripercorrere la tua carriera accademica e la tua formazione scientifica. La tua storia per come la conosco è di sicuro rilievo per noi sociologi economici. Direi di partire dalla tua formazione accademica perché hai un percorso molto interessante.
Sì, penso che sia importante, e possa far riflettere altri, perché è stato tutto tranne che un percorso lineare: quello che mi è capitato di diventare è stato inizialmente l’esito di vicende ravvicinate impreviste e di vicende lontane quasi dimenticate. A diciotto anni mi ero iscritta a Lettere moderne in Cattolica, con l’idea che mi sarei occupata di letteratura e che avrei fatto la critica letteraria. Ma mi ero appena iscritta al quarto anno che, nell’autunno del 1967, sulla questione dell’aumento delle tasse universitarie deciso dalle autorità accademiche nacque un vasto fronte di protesta che in breve tempo divenne un movimento: il Movimento Studentesco della Cattolica. Non mi ero mai occupata di “politica” – né, diciamolo, ero particolarmente sensibile a un aumento delle tasse che personalmente non mi toccava… – ma mi sembrò da subito odiosa una decisione che avrebbe penalizzato molti altri, con meno possibilità, tanto più che la decisione era stata presa dalle autorità di un’istituzione cattolica. Ero credente, come sarei stata poi sempre, e la cosa ancor più mi feriva. Partecipai da subito alla protesta, e fin dalla prima occupazione, nel novembre 1967, entrai nel Comitato di agitazione: c’erano Mario Capanna, Michelangelo Spada, Luciano Pero, Claudio Rinaldi Tufi… Mi viene ora in mente in proposito un episodio importante. Un giorno come comitato di agitazione ricevemmo una lettera dall’autorità ecclesiastica in cui si chiedeva conto delle ragioni di un comportamento critico se non di opposizione alla Chiesa. Ci riunimmo e preparammo una risposta in cui cercavamo di spiegare che ci sembrava un’opera di giustizia. Quando arrivammo alla firma della lettera, pensammo che potesse essere utile specificare brevemente chi fosse ciascuno di noi e scoprimmo in quel momento, con una certa sorpresa, che tutti, nessuno escluso, avevamo o avevamo avuto incarichi o comunque responsabilità in ambiti della Chiesa: nell’azione cattolica, in parrocchia o in oratorio, o in movimenti ecclesiali – io ero allora nella presidenza di Gioventù Studentesca. Oltre che per i suoi aspetti intrinseci, di cronaca, l’episodio è importante perché mette in luce un elemento importante per la teoria dei movimenti e della mobilitazione sociale: vale a dire che non è mai vero che i leader dei movimenti nelle fasi iniziali siano persone sprovvedute, senza una precedente storia, anche se non se ne rendono conto: hanno tutti dietro invece una socializzazione ai problemi di cui si stanno occupando. Al di là di ogni retorica e alle credenze di senso comune, i movimenti non nascono mai spontaneamente. L’avrei di lì a poco scoperto studiando l’origine dei delegati di reparto e l’avremmo scoperto studiando la nascita della mobilitazione operaia che stava incominciando a manifestarsi proprio in quel periodo e avrebbe avuto il culmine nell’autunno caldo del 1969, due anni più tardi. Tornando a ciò che stavamo dicendo, come comitato di agitazione ci si riuniva quotidianamente. Però io non mi ritrovavo nelle lunghe defatiganti discussioni di “elaborazione politica”: mi erano congeniali e mi sembravano più interessanti attività di tipo molto più pratico. Una era quella della comunicazione agli studenti: quotidianamente in Cattolica preparavamo durante la notte un bollettino con i principali eventi, i documenti, le iniziative, gli avvisi. Ci si trovava alla Libreria Sapere in via Molino delle Armi e lavoravamo insieme: i ragazzi che sapevano usare il ciclostile e io, che non ne ero capace, a coordinare il numero. Tutti i giorni per molto tempo è uscito questo bollettino che veniva distribuito agli studenti la mattina. Più avanti, nell’estate successiva, avrei coordinato le attività di ripetizione ai figli degli operai… Quando nel 1968 chiesi infine la tesi, a questo punto la tesi non fu più di letteratura, neppure sulla letteratura industriale – Volponi, Ottieri… – che pure avevo scoperto negli ultimi esami, ma fu una tesi di sociologia: una tesi sulle caste nell’India contemporanea. Il tema lo proposi a Francesco Alberoni, allora professore ordinario di Sociologia in Cattolica, ma che si sarebbe trasferito subito a Trento, dove avrebbe fondato la Facoltà di Sociologia; la tesi venne quindi seguita da Gian Enrico Rusconi e relatore fu Guido Baglioni. Ma perché il tema delle caste? Anche questo è importante e va spiegato. In realtà credo che il mio interesse per i problemi sociali fosse già nato in India, dove andai a quattordici anni, perché mio padre vi si era trasferito per lavoro. Vi rimasi per quasi due anni. Studiai in una scuola inglese, ma soprattutto ebbi la possibilità di fare lunghi giri, con degli indiani, negli stati del sud: ero un’adolescente curiosa, anche se molto introversa allora, e rimasi estremamente, dolorosamente, colpita da ciò che vedevo e dall’immediata impressione di diseguaglianza di tutto. Perché quella indiana è una società strutturalmente diseguale e gerarchica, e anche intrinsecamente violenta. Homo Hierarchicus, avrebbe poi detto Louis Dumont. Sul momento, quando tornai in Italia non ci pensai più di tanto; ma a poco a poco quelle impressioni mi tornarono in mente quando, durante la mobilitazione degli studenti, si cominciò a ragionare sulle prospettive della società e sul mondo del futuro. Feci una tesi perciò sulle caste, ma sulle caste nell’India contemporanea. Feci quindi i conti con quel mio passato. In un certo senso lo sistemai, lo misi a posto. Quando di lì a poco, appena mi laureai nel 1969 e il mio relatore, Guido Baglioni, mi chiese se fossi interessata a frequentare la Scuola Superiore di Sociologia per laureati che era allora all’Umanitaria, accettai con gioia. Ma non mi sarei più occupata di caste: mi sarei ritrovata – e ancora una volta uso questo termine – a occuparmi di lavoro.
Frequentai la scuola nel biennio 1970-1971 con borsa di studio del CNR. E fu un’esperienza molto ricca, soprattutto per chi come me si era avvicinato di recente alla sociologia e aveva bisogno di imparare praticamente tutto. Da lì come docenti o come allievi passava in quegli anni la maggior parte dei sociologi – o, meglio, degli scienziati sociali – italiani dell’epoca: quelli che già insegnavano o comunque lavoravano nel mondo della ricerca e quelli che prima o poi l’avrebbero fatto. Gli stimoli erano tantissimi e il clima straordinario, così diverso da quello che avevo conosciuto nelle aule universitarie, ma diverso anche dalle improvvisazioni volonterose ma ingenue che si respiravano nei tentativi di proporre qualcosa di nuovo da parte del movimento degli studenti. Si leggeva e ci si misurava soprattutto con autori inglesi e americani che erano al centro del dibattito internazionale. Qualcuno venne anche a trovarci passando per Milano. Ricordo che mi faceva molta impressione vedere dal vivo personaggi di cui si leggevano e discutevano le ricerche quasi fossero mostri sacri, e scoprirne invece la normale umanità, come la volta in cui un famosissimo studioso americano delle classi sociali si presentò non propriamente sobrio quando una mattina venne a parlarci… Avevo un’idea molto alta del mestiere e della figura dello studioso, in particolare del sociologo. Non ho difficoltà a ammettere che all’epoca non immaginavo che io stessa sarei poi diventata una studiosa e entrata in università. Ero mossa da una forte passione conoscitiva e ero molto affascinata dai problemi sociali, ma non pensavo che ne sarebbe nata la mia professione – non mi sentivo all’altezza. Un fatto che si sarebbe però rivelato decisivo fu la partecipazione allo studio sui delegati di reparto coordinato da Bianca Beccalli nell’ambito delle attività di ricerca sul campo previste dal percorso della Scuola. Bianca era mio tutor e, pur non sapendone io in realtà quasi nulla all’inizio, avevo accettato con entusiasmo la sua proposta di studiare queste nuove forme peculiari di rappresentanza, in cui echeggiavano idee e sollecitazioni che giravano nel mondo degli studenti. O almeno così si pensava. Facemmo quindi questa ricerca che fu la prima sul tema a essere impostata con un approccio conoscitivo serio: non si basava semplicemente su interviste a attivisti disponibili e facili da avvicinare sui luoghi di lavoro, ma era basata su questionari costruiti secondo criteri rigorosi e somministrati a campioni piuttosto ampi di delegati. Nell’elaborazione quantitativa ci aveva aiutato Stefano Draghi. I risultati erano molto interessanti perché non confermavano le idee correnti che si erano diffuse nel mondo sindacale e nella pubblicistica corrente sul tema: questi delegati di reparto non erano affatto giovani, per lo più emigrati dal sud, senza un precedente rapporto con la politica o con l’azione organizzata, non erano ragazzini di un movimento mossi da entusiasmo spontaneo. Erano persone con un background politico e di impegno almeno in parte già strutturato e collegato a istituzioni politiche o sindacali… Molto diverso da quello che si diceva. Fu però una ricerca che non venne mai realmente pubblicata. Massimo Paci vi fece riferimento nell’intervento che fece a un convegno sul sindacato ad Ancona. Bianca scoprì poi dopo molto tempo che era stata in parte pubblicata a nostra totale insaputa in Germania su una rivista della sinistra radicale tedesca. Per me si sarebbe rivelata comunque un’esperienza importante, come divenne chiaro non molto dopo.
Nel 1971 terminai il corso biennale alla Scuola Superiore di Sociologia. L’anno prima mi ero sposata. Mi ero anche iscritta al megaconcorso per insegnanti nella scuola secondaria. Passai e mi assegnarono l’insegnamento delle materie letterarie in una scuola media fuori Milano. Nell’autunno del 1971 iniziai a insegnare. Ma dopo neppure un mese – sarà stato fine ottobre o novembre – capitarono un paio di eventi che diedero una svolta definitiva alla mia vita. Da un lato scoprii di aspettare il mio primo figlio, e ne fui immensamente felice, dall’altro Alessandro Pizzorno – che era all’estero quando frequentavo la Scuola all’Umanitaria, non l’avevo ancora incontrato – tornò dagli Stati Uniti e incominciò a chiedere in giro se qualcuno avesse delle competenze sui delegati di reparto: voleva inserirlo nel gruppo di ricerca che stava costituendo per studiare la mobilitazione operaia di quegli anni. Gli dissero che c’era questa Regalia… Pizzorno mi  chiamò e mi propose di partecipare alla sua ricerca, quella che appunto sarebbe diventata nota come Lotte operaie e sindacato. La cosa mi attirava tantissimo, ma mi sembrava fuori luogo: aspettavo un figlio e avevo iniziato a insegnare, non avrei potuto fare tutto… Ne parlai con mio marito, dicendo che pensavo di declinare la proposta. Il suo intervento fu decisivo. “Ma tu sei matta!”, ricordo che mi disse, “accetta subito! È una cosa adatta a te, a come sei fatta… Lascia subito invece la scuola!” Così feci. E poiché in quel momento non ce la passavamo proprio bene e era il caso che in casa ci fosse almeno un introito regolare, decise che sarebbe andato lui a insegnare a scuola: non era nei suoi piani, ma lo fece e fu un insegnante straordinario, né smise mai di coltivare insieme la sua grande passione e competenza per il mondo dell’arte. Da quel momento divenne il mio sponsor più accanito, incoraggiandomi sempre, anche quando ero incerta, a andare, a fare. Questa è una parentesi personale che pochissimi conoscono, ma fondamentale per me e che segna l’inizio di un percorso che proseguirà poi tappa per tappa secondo una logica forse più da donna che da uomo…
chiamò e mi propose di partecipare alla sua ricerca, quella che appunto sarebbe diventata nota come Lotte operaie e sindacato. La cosa mi attirava tantissimo, ma mi sembrava fuori luogo: aspettavo un figlio e avevo iniziato a insegnare, non avrei potuto fare tutto… Ne parlai con mio marito, dicendo che pensavo di declinare la proposta. Il suo intervento fu decisivo. “Ma tu sei matta!”, ricordo che mi disse, “accetta subito! È una cosa adatta a te, a come sei fatta… Lascia subito invece la scuola!” Così feci. E poiché in quel momento non ce la passavamo proprio bene e era il caso che in casa ci fosse almeno un introito regolare, decise che sarebbe andato lui a insegnare a scuola: non era nei suoi piani, ma lo fece e fu un insegnante straordinario, né smise mai di coltivare insieme la sua grande passione e competenza per il mondo dell’arte. Da quel momento divenne il mio sponsor più accanito, incoraggiandomi sempre, anche quando ero incerta, a andare, a fare. Questa è una parentesi personale che pochissimi conoscono, ma fondamentale per me e che segna l’inizio di un percorso che proseguirà poi tappa per tappa secondo una logica forse più da donna che da uomo…
Questo aspetto legato all’essere donna è rilevante, facci capire meglio cosa intendi?
Intendo un fare – cioè uno studiare, un impegnarsi professionalmente – che non nasce tanto dall’avere chiara in mente una meta, da una strategia abbastanza definita, come mi pare spesso abbiano gli uomini che tendono a farsi presto un’idea di dove vogliono arrivare e che cosa vogliono raggiungere. Io invece mi rendevo conto che avrei potuto fare e che l’avrei fatto con determinazione e passione, ma – come dire? – valorizzando quelle che mi sembravano le opportunità e le questioni – in termini di problemi conoscitivi – importanti in quel momento, indipendentemente da obiettivi di carriera. …In effetti partecipai con passione alla ricerca di Pizzorno e quella fu per me la vera introduzione alla sociologia e alla ricerca sociologica nel senso più ampio del termine. Ci occupavamo di problemi economici e del lavoro, di sindacati e di mobilitazione collettiva. Ma, anche se avrei finito per occuparmi poi sempre di quei temi, per me l’insegnamento fu soprattutto di tipo più generale, di metodo, di come ci si mette a far ricerca: sociologica e non solo. Pizzorno aveva un’incredibile capacità di insegnare senza insegnare, non faceva mai a noi lezioni formali. Non enunciava o teorizzava astrattamente, partiva dai dati di fatto: quelli  che si leggevano sui giornali o che raccoglievamo noi, vale a dire il gruppo di ricerca, ampio, composito, mutevole nel tempo, in cui oltre a Bianca Beccalli spiccavano Emilio Reyneri e soprattutto Marino Regini, che conobbi allora e sarebbero diventati e poi rimasti amici molto importanti per me, e lo sono tuttora. Ci si trovava di continuo e si conversava liberamente. Pizzorno ci interrogava sistematicamente sul senso di ciò che veniva detto: “Che cosa intendi per?…” o “Come definisci questo?…”. E l’interlocutore si trovava spiazzato e si accorgeva improvvisamente che quello che gli era sembrato ovvio, non lo era affatto e che occorreva pensarci bene prima di dare una definizione. Questa capacità di smontare ciò che appare naturale, autoevidente, di non dar nulla per scontato, di obbligarti a cambiar prospettiva e a capovolgere all’occorrenza il modo di guardare le cose per me è stato forse l’insegnamento più importante. E credo che mi sia servito moltissimo nel mio modo poi di fare ricerca, che, si potrebbe forse dire, ha quasi sempre privilegiato tematiche per un verso o un altro relativamente marginali, ma che permettevano di andare oltre l’ovvio per intravvedere sviluppi o potenzialità impreviste. Anche in questo, credo, secondo un orientamento, o un’attenzione più da donna…
che si leggevano sui giornali o che raccoglievamo noi, vale a dire il gruppo di ricerca, ampio, composito, mutevole nel tempo, in cui oltre a Bianca Beccalli spiccavano Emilio Reyneri e soprattutto Marino Regini, che conobbi allora e sarebbero diventati e poi rimasti amici molto importanti per me, e lo sono tuttora. Ci si trovava di continuo e si conversava liberamente. Pizzorno ci interrogava sistematicamente sul senso di ciò che veniva detto: “Che cosa intendi per?…” o “Come definisci questo?…”. E l’interlocutore si trovava spiazzato e si accorgeva improvvisamente che quello che gli era sembrato ovvio, non lo era affatto e che occorreva pensarci bene prima di dare una definizione. Questa capacità di smontare ciò che appare naturale, autoevidente, di non dar nulla per scontato, di obbligarti a cambiar prospettiva e a capovolgere all’occorrenza il modo di guardare le cose per me è stato forse l’insegnamento più importante. E credo che mi sia servito moltissimo nel mio modo poi di fare ricerca, che, si potrebbe forse dire, ha quasi sempre privilegiato tematiche per un verso o un altro relativamente marginali, ma che permettevano di andare oltre l’ovvio per intravvedere sviluppi o potenzialità impreviste. Anche in questo, credo, secondo un orientamento, o un’attenzione più da donna…
…Per associazione di idee, mi ritorna in mente un altro episodio, che ho prima citato di sfuggita, di quando militavo nel movimento studentesco. Nel 1968 anche le altre università dopo la Cattolica erano entrate in agitazione e si era costituito un coordinamento cittadino in Statale cui anche io, che ero nel comitato di agitazione della Cattolica, partecipavo. …Le riunioni però continuavano a sembrarmi poco appassionanti se non francamente fumose e inutili. Finché non ci fu un’idea che venne proposta da qualcuno, non ricordo da chi, che feci subito mia. Ispirandosi in senso lato alla Lettera a una professoressa di don Milani che più o meno tutti avevamo letto e discusso, l’idea era quella di costituire un gruppo di universitari delle diverse facoltà che andasse a far ripetizione ai figli degli operai delle medie che avevano esami di riparazione a settembre. Il progetto venne approvato e ne divenni la coordinatrice cittadina. …Ecco, credo che non fosse del tutto casuale che a assumersi la responsabilità di questa iniziativa di tipo operativo fosse appunto una donna: gli uomini preferivano le discussioni politiche. Per me fu un’esperienza straordinaria, una scuola di vita e poi di preparazione alla ricerca sul campo – ma allora non lo sapevo – che sarebbe stata preziosissima. Da un lato occorreva mettere in piedi il gruppo di universitari disponibili a dare le ripetizioni: con una certa mia sorpresa questo non fu difficile e per tutto il tempo – da giugno a fine agosto, con una interruzione solo la settimana di ferragosto – studenti provenienti da Lettere, Filosofia, Matematica, Lingue, dal Politecnico, si sarebbero impegnati ogni giorno come non avrei immaginato. Ma occorreva poi individuare i figli degli operai che potevano essere interessati. Come si faceva? Io ero totalmente inesperta. Sono figlia di un dirigente di industria, nella mia famiglia si parlava di fabbriche e di operai, però dall’altra parte. Non avevo nessun contatto, ero anzi di un’ignoranza assoluta: allora non sapevo neppure che in Italia ci fossero tre grandi sindacati… Qualcuno del gruppo che ne sapeva un po’ di più mi diede qualche dritta e si decise di fare la nostra proposta in tre diverse aree del milanese, cercando di appoggiarci a un sindacato locale anche per averne supporto logistico. Nell’area di Lambrate scegliemmo l’azienda Innocenti e il sindacalista con cui andai a parlare era Sandro Antoniazzi, che sarebbe poi diventato segretario cittadino della Cisl e che era allora segretario della Fim-Cisl locale. Lui ci mise a disposizione una sala della parrocchia. Poi a Sesto San Giovanni, dove avevamo scelto la Ercole Marelli, andai a parlare con Antonio Pizzinato, che sarebbe poi diventato segretario della Camera del lavoro di Milano, e più avanti segretario nazionale della Cgil, che mise a disposizione un locale nella sede della Fiom Cgil di Sesto di cui era allora segretario. E nella zona della Borletti in via Washington incontrai Piergiorgio Tiboni, che era sindacalista di provenienza Cisl, ma dissidente (avrebbe poi fondato la CUB – Confederazione Unitaria di Base), che ci offrì una sede sindacale. Incominciai così a scoprire che c’erano diverse realtà non solo dal punto di vista della produzione, ma anche del sindacato. Ricordo che con leggerezza e presunzione facevo qualche battuta sul sindacato con i sindacalisti, i quali mi prendevano in giro perché dicevano che non ne capivo niente… E era vero! Per poter iniziare, andammo a volantinare la mattina presto all’ingresso degli operai davanti alle fabbriche per proporre l’iniziativa e invitare gli eventuali interessati a degli incontri che si fecero nelle varie sedi a disposizione, e in cui illustrammo il progetto spiegando che la cosa era seria, che non avremmo detto o fatto stranezze… Poi incominciammo. A quell’epoca non c’erano telefonini…Riuscire a coordinare in modo che ci fossero insegnanti di lingua straniera, di italiano, di storia eccetera a seconda delle esigenze in tutti questi posti ogni giorno non fu molto semplice. Però la cosa funzionò. A volte mi chiedo come abbiamo fatto… Devo però onestamente ammettere che non ho mai saputo se le nostre lezioni siano poi servite. Ad ogni modo per me questo fu il primo contatto diretto, un po’ particolare, con il mondo del lavoro, con le problematiche del lavoro, con le sensibilità dei lavoratori. Scoprii che c’era molta diffidenza e resistenza da parte degli operai, che si chiedevano: “Ma questi studenti chi sono? possiamo fidarci di loro? Sono delle teste calde, possiamo affidargli i nostri figli?”. Ti accorgevi che la loro visione delle cose e percezione della realtà, la loro cultura non erano quelle che immaginavamo noi, erano proprio diverse. E più tardi avrei capito che tanti discorsi che si sono poi fatti sugli studenti che avrebbero mobilitato la classe operaia sono sostanzialmente fuori luogo.
La diffidenza degli operai nei confronti degli studenti è un aspetto poco noto di quel periodo. Come lo hai gestito?
Non ho più avuto modo di farvi i conti operativamente. Dopo un breve periodo nel 1969 in cui organizzai ancora incontri in diversi quartieri di Milano e nei dintorni per istituire dei doposcuola stabili per i figli dei lavoratori, lasciai l’impegno attivo per lo studio e la ricerca sociale. Quando poi incominciammo la ricerca con Pizzorno, a me venne assegnata come caso da approfondire una grande azienda vicina a casa che all’epoca si chiamava Sit-Siemens, e sarebbe poi diventata Italtel e poi ancora Telecom. Era un’azienda molto interessante, perché estremamente articolata e in cui avrei scoperto che erano presenti problemi diversi e culture diverse: c’erano gli operai di produzione che lavoravano a cottimo, c’erano gli attrezzisti che erano operai professionali, c’erano i tecnici di laboratorio, c’erano gli impiegati amministrativi della sede, c’erano i tecnici addetti ai servizi esterni… E c’erano uomini e donne. Feci tantissime interviste in cui si approfondivano i comportamenti durante la mobilitazione, la partecipazione al sindacato, l’assunzione di incarichi di rappresentanza. Mi colpì molto la varietà delle posizioni e degli orientamenti legati alla diversità delle condizioni strutturali legate all’organizzazione del lavoro. E mi colpirono molto le differenze di genere. Le donne lavoravano soprattutto singolarmente sulla propria macchina nei reparti a cottimo individuale; erano quindi molto condizionate e limitate nella possibilità di movimento, in quella che allora si chiamava l’agibilità politica. Ma quelle che erano diventate delegate di reparto avevano dei loro modi originali di cogliere i problemi e cercare di portarli avanti: notevole era in particolare la loro fantasia e capacità di trovare soluzioni per comunicare i problemi via via che emergevano attraverso sistemi di bigliettini che facevano circolare. Spesso accadeva però che dopo poco tempo a differenza dei delegati maschi esse davano le dimissioni. I responsabili sindacali e del consiglio di fabbrica tendevano a spiegare le differenze di comportamento in termini di differenze di interesse o di capacità di comprensione dei problemi: del resto, fino a poco tempo fa, in gran parte della letteratura sulla sindacalizzazione si è sempre considerato ovvio che le donne siano di per sé meno propense all’impegno e alla partecipazione politica e sindacale. Sfuggiva loro quanto diversa – e fonte di stress – fosse in questo caso la condizione strutturale delle donne sul lavoro, e, forse ancor più, quanto faticoso e talvolta irrealistico fosse per le donne impegnate sindacalmente partecipare alle riunioni del consiglio di fabbrica e del sindacato soprattutto per ragioni di orario. Dopo una prima fase di entusiasmo spesso maggiore di quello dei colleghi maschi, non potevano più reggere, salvo che non fossero ragazze ancora giovani senza una propria famiglia: si sentivano non sostenute e di fatto emarginate. Così che, qualche tempo dopo l’elezione a delegate, vi erano quelle, poche, che puntavano a fare la sindacalista a tempo pieno rinunciando a avere una famiglia, mentre altre, la maggioranza e talvolta le migliori, decidevano di smettere. Chi mi conosce sa che non ho mai posto la tematica di genere in quanto tale al centro della mia ricerca. Ma per me fu molto importante scoprire come certe differenze emergessero con grande evidenza dai fatti, e come d’altro lato fosse molto chiaro che le donne non sono di per sé meno interessate a impegnarsi nei problemi che riguardano il lavoro. …In realtà, ci fu un’occasione in cui mi occupai in modo esplicito delle donne. Fu quando nel 1977 o giù di lì partecipai come docente a un corso delle 150 ore coordinato da Bianca Beccalli. S’intitolava “La pratica politica delle donne” e ne venne poi ricavato un piccolo libro pubblicato da Mazzotta.  Ero molto perplessa, non mi ritrovavo molto nell’approccio delle altre colleghe del gruppo. Però Bianca mi aveva voluto perché, occupandomi di partecipazione al sindacato, voleva che ci fosse anche questo punto di vista. Se si dà un’occhiata al libro, la parte che ho scritto io è piuttosto diversa da quella delle altre, perché, sulla base dei risultati della ricerca precedente, cerca di parlare della partecipazione sindacale delle donne partendo da vincoli e comportamenti osservati e non da una visione degli orientamenti e dei problemi delle donne immaginati, per me, in modo un po’ astratto e a priori.
Ero molto perplessa, non mi ritrovavo molto nell’approccio delle altre colleghe del gruppo. Però Bianca mi aveva voluto perché, occupandomi di partecipazione al sindacato, voleva che ci fosse anche questo punto di vista. Se si dà un’occhiata al libro, la parte che ho scritto io è piuttosto diversa da quella delle altre, perché, sulla base dei risultati della ricerca precedente, cerca di parlare della partecipazione sindacale delle donne partendo da vincoli e comportamenti osservati e non da una visione degli orientamenti e dei problemi delle donne immaginati, per me, in modo un po’ astratto e a priori.
Approfondiamo questa cosa. Il movimento femminista aveva determinate idee e tu hai proposto una visione alternativa.
…Per prendermi un po’ in giro, ricordo un piccolo episodio divertente. Un paio d’anni dopo, o forse anche più tardi, ero mi pare a Washington a un convegno degli Europeanists. Eravamo tutti ospitati in uno stesso grande albergo. Capitò che ci trovammo tre o quattro sull’ascensore e una, un’americana, mi chiese chi fossi, come mi chiamassi. “Ida Regalia”, feci e quella quasi saltò, piena di entusiasmo: “Ida Regalia… Sei Ida Regalia! Sei una delle autrici del libro La pratica politica delle donne!”. Straordinario! La cosa che era per me più marginale, che non ho mai considerato importante, e oltretutto scritta in italiano, aveva entusiasmato una femminista americana…
In quel breve testo avevo sviluppato le intuizioni che erano emerse nell’analisi empirica, in particolare nello studio alla Siemens. Potevo contare su un piccolo campione di donne e di uomini analogamente impegnati come delegati nei reparti e potevo metterne a confronto giudizi e attese nei confronti del sindacato. Emergeva chiaramente come le neoelette donne si aspettassero di essere aiutate a fare l’attività sindacale, sia in termini di formazione al ruolo, sia in termini di attenzione fattiva alla loro condizione di madri di famiglia. Chiedevano quindi che ci fossero delle regole sulla dimensione temporale dell’impegno che, al di là di ogni atteggiamento paternalistico, tenessero conto delle loro esigenze di organizzazione della vita e dei tempi di vita. Su questo erano molto determinate; per il resto, sui contenuti del ruolo di rappresentante, l’attenzione e l’interesse era analogo. Se mai, le donne erano più capaci di cogliere questioni importanti di tipo immediato – i tempi di produzione troppo stretti, l’intervallo insufficiente a poter mangiare in modo adeguato – mentre gli uomini tendevano più a fare discorsi sul futuro – come cambiare l’organizzazione del lavoro in modo nuovo… Questo le donne non se lo ponevano come problema perché non lo vedevano come possibilità reale, ma come fuga in avanti che può riempirti la bocca e anche la mente, ti può gratificare, ma che alla fine non serve a molto. Diciamo che la parola “serve” qui funziona, perché nei confronti di quelli che rappresentavano esse tendevano a avere un orientamento al servizio, il che tende a essere più facile nelle donne; è una differenza nel modo di immaginare che cosa sia più opportuno o più necessario fare. È chiaro che il servizio è comunque fondamentale – come avrei poi capito nelle ricerche nel mondo dei servizi – così come è fondamentale che ci sia chi cerca di immaginare scenari alternativi. Ma allora era l’attenzione alle condizioni effettive dei rappresentati – operaie e operai, giacché non necessariamente esse rappresentavano solo donne – a avermi colpito.
E questa tua visione non trovava spazio nel gruppo femminista?
Nel gruppo femminista veniva tollerata; ma ero vista come una un po’ retro e riformista, molto tradizionale... Chi in fondo mi capiva era Bianca: Bianca mi aveva anche voluto per questo, perché facessi riferimenti concreti all’impegno delle donne nel sindacato… Per associazione di idee mi viene ora in mente un altro fatto. Un po’ più avanti, negli anni ottanta, più volte mi è capitato di conversare sulla situazione italiana con il politologo americano Sidney Tarrow, di Cornell, che era allora da noi poiché stava scrivendo un libro sulla mobilitazione collettiva e i movimenti in Italia. Una tesi che Sid aveva più volte ribadito e che mi aveva molto colpito era che nel caso italiano i movimenti in fondo non riescono a avere grande presa, diversamente da quanto è accaduto in altri paesi avanzati, perché da noi il ruolo che hanno assunto altrove movimenti giovanili e femminili è stato preso dal sindacato. Credo ci sia molto di vero in questo e mi sono sempre sembrati come una specie di forzatura gli argomenti di chi, partendo dai casi, dalle vicende di movimenti, per esempio femministi, di altri paesi, immagina che qui possa o debba avvenire lo stesso, quando, a ben vedere, ci si accorge invece che qui molti aspetti della condizione femminile, o, più avanti, della questione degli immigrati, sono in qualche modo, di fatto, già affrontati dal sindacato. Più avanti l’ho via via capito meglio: a dispetto di tante narrazioni sul suo indebolimento e la sua crisi, il sindacato è stato e continua anche oggi a essere molto diffuso in Italia, a essere capillarmente strutturato e radicato; ha una radice sociale molto più ampia di quella di altri paesi e bene o male ha cercato di fare i conti con le differenze. Gruppi di donne, per esempio, sono nati all’interno del sindacato, hanno contribuito a modificare orientamenti e comportamenti, hanno avuto su tante donne un appeal maggiore e più diffuso dei movimenti di tipo femminista al suo esterno. Ma lo stesso vale un po’ per tutto: per i lavoratori cosiddetti atipici, per cui si sono costituiti dei sindacati dedicati dentro le confederazioni maggiori, per gli immigrati, per i quali si sono immaginate anche forme di organizzazione originali come il sindacato di strada nelle campagne meridionali, e più di recente per i rider, per cui a Milano il sindacato ha organizzato uno sciopero. È una tendenza e una tensione continua, che ha la sua origine nella storia del sindacato in Italia e nelle condizioni politiche e di riconoscimento limitato, non istituzionalizzato, che l’hanno contraddistinta. Credo che molto ci sia ancora da capire e da approfondire, ma è indubbio che da noi – come abbiamo sostenuto con Marino Regini in un recente articolo scritto insieme nel 2018 per South European Society and Politics e come del resto traspariva anche in un articolo sullo European Journal of Industrial Relations scritto assieme a te, Sabrina, nel 2016 – il sindacato è più radicato socialmente e ha mostrato una molto maggiore resilienza che altrove. Questo non significa affatto che poi riesca a garantire alti salari, lo vediamo benissimo. Altri sindacati riescono a essere più efficaci da questo punto di vista; ma il nostro riesce di più a fare un discorso aperto alle caratteristiche diverse della società, sia di prima, sia di oggi.
La cosa che emerge da quello che stai dicendo è che a occuparti di sindacato ti sei ritrovata quasi casualmente, ma poi ti sei appassionata della tematica. Qual è la ricerca sul sindacato che più ti ha appassionata?
Ne ho fatte tantissime… Ma ce ne sono alcune che sono state particolarmente importanti. Subito dopo la ricerca con Pizzorno, che certamente è stata quella che più mi ha aperto al mondo della sociologia in generale – per me sarebbero rimasti memorabili i suoi modi di affrontare il problema della mobilitazione collettiva e della partecipazione politica, che nascevano dall’osservazione delle lotte operaie, ma che potevano andare bene per qualunque altra forma di mutamento sociale –, una ricerca che mi appassionò molto fu verso la fine degli anni settanta quella diretta da Guido Romagnoli sulla sindacalizzazione. Sarebbe poi stata pubblicata nei due  volumi Sindacalizzazione tra ideologia e pratica del 1980. Era una ricerca promossa dal Centro Studi della Cisl. Guido Romagnoli, un giovane studioso che ci ha purtroppo lasciati troppo presto, una persona molto intelligente con cui avevo un bel dialogo e con cui mi capivo al volo, aveva molto insistito perché partecipassi e mi aveva proposto di coordinare una parte della ricerca, quella che riguardava le politiche di reclutamento del sindacato. Io ero piuttosto perplessa, non per il tema, ma per motivi organizzativi di tipo familiare – era nato anche il mio secondo figlio – e per altre ragioni: perché ero giunta a sentirmi più in sintonia con la Cgil, cosa che del resto Guido sapeva benissimo e era anche uno dei motivi per cui aveva voluto la mia presenza, e perché ormai sentivo una forte esigenza di allargare il campo di osservazione empirica al di là della Lombardia. Capivo bene che non si può riuscire a andare oltre ciò che appare scontato senza fare confronti con situazioni molto diverse, ma mi rendevo conto che non mi sarebbe stato facile farlo. Allora ero una ricercatrice freelance, all’università facevo solo qualche esercitazione con gli studenti. Negoziammo i termini della mia partecipazione: a parte il coordinamento dei ricercatori impegnati nella rilevazione empirica di cui avrei avuto la responsabilità, avrei svolto la mia parte di ricerca sul campo in una provincia del Mezzogiorno, in Puglia, e per l’occasione mi sarebbe stato pagato il costo aggiuntivo di un baby-sitter… Accettai infine e a lavori avviati mi capitò di giungere a quella che per me era una prima riunione: c’erano sindacalisti e studiosi del sindacato vicini alla Cisl che stavano discutendo su come mai la sindacalizzazione, che era cresciuta impetuosamente a partire dal 1970, ora non cresceva più (si era nel 1978). Perché non ci si iscriveva al sindacato? Mi resi conto che la domanda era mal posta, che andava rovesciata. Ero fresca delle discussioni che in quegli anni Pizzorno era andato organizzando in una serie di seminari memorabili a Milano sugli autori allora al centro del dibattito internazionale nelle scienze sociali – Mancur Olson, Albert Hirschman, Anthony Downs, Ronald Dore… – ma che allora erano pressoché sconosciuti in Italia. E osservai, inizialmente un po’ intimidita, che in realtà era facile capire perché non ci si iscrivesse, che la domanda cruciale da porsi, il quesito cui trovare una risposta, era esattamente il contrario: come mai ci fossero molti che si iscrivevano pagandone i costi, nonostante che il principale bene offerto dal sindacato mediante la contrattazione collettiva andasse a vantaggio anche dei non iscritti. Ricordo che la reazione immediata fu di grandissimo sconcerto, stupore e fin indignazione, e ne nacque un vivacissimo dibattito, come del resto era avvenuto nel seminario su Olson e il suo The logic of collective action a Milano. Ma Guido Romagnoli comprese al volo e appoggiò la mia idea di impostare la rilevazione empirica di cui ero responsabile intorno all’ipotesi che occorreva comprendere quali fossero i beni, o incentivi selettivi di fatto esplicitamente o implicitamente, anche inconsapevolmente, offerti dal sindacato in cambio dell’iscrizione. E questa fu l’ipotesi di fondo che guidò la ricerca entro un disegno complesso di variabili strutturali di contesto, di variabili indipendenti, intervenienti e dipendenti. Studiammo quattro casi provinciali, uno ciascuno in Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia per tener conto della diversa articolazione socio-economica del paese su base territoriale. Io andai lontano, nell’estremità della Puglia. Fu un’esperienza particolarmente bella e fruttuosa: alla fine furono individuati tre modelli di sindacalizzazione, che sono quelli che anche Guido fece propri, e che sarebbero diventati una chiave di lettura per leggere le variazioni negli andamenti della sindacalizzazione più in generale (come nel saggio Ipotesi sulla sindacalizzazione negli anni Settanta che poi scrissi su richiesta di Mimmo Carrieri nel 1981). …Sul piano personale quella ricerca è anche legata a un episodio significativo nella mia esperienza di studiosa donna. Ma non so se ha importanza raccontarlo…
volumi Sindacalizzazione tra ideologia e pratica del 1980. Era una ricerca promossa dal Centro Studi della Cisl. Guido Romagnoli, un giovane studioso che ci ha purtroppo lasciati troppo presto, una persona molto intelligente con cui avevo un bel dialogo e con cui mi capivo al volo, aveva molto insistito perché partecipassi e mi aveva proposto di coordinare una parte della ricerca, quella che riguardava le politiche di reclutamento del sindacato. Io ero piuttosto perplessa, non per il tema, ma per motivi organizzativi di tipo familiare – era nato anche il mio secondo figlio – e per altre ragioni: perché ero giunta a sentirmi più in sintonia con la Cgil, cosa che del resto Guido sapeva benissimo e era anche uno dei motivi per cui aveva voluto la mia presenza, e perché ormai sentivo una forte esigenza di allargare il campo di osservazione empirica al di là della Lombardia. Capivo bene che non si può riuscire a andare oltre ciò che appare scontato senza fare confronti con situazioni molto diverse, ma mi rendevo conto che non mi sarebbe stato facile farlo. Allora ero una ricercatrice freelance, all’università facevo solo qualche esercitazione con gli studenti. Negoziammo i termini della mia partecipazione: a parte il coordinamento dei ricercatori impegnati nella rilevazione empirica di cui avrei avuto la responsabilità, avrei svolto la mia parte di ricerca sul campo in una provincia del Mezzogiorno, in Puglia, e per l’occasione mi sarebbe stato pagato il costo aggiuntivo di un baby-sitter… Accettai infine e a lavori avviati mi capitò di giungere a quella che per me era una prima riunione: c’erano sindacalisti e studiosi del sindacato vicini alla Cisl che stavano discutendo su come mai la sindacalizzazione, che era cresciuta impetuosamente a partire dal 1970, ora non cresceva più (si era nel 1978). Perché non ci si iscriveva al sindacato? Mi resi conto che la domanda era mal posta, che andava rovesciata. Ero fresca delle discussioni che in quegli anni Pizzorno era andato organizzando in una serie di seminari memorabili a Milano sugli autori allora al centro del dibattito internazionale nelle scienze sociali – Mancur Olson, Albert Hirschman, Anthony Downs, Ronald Dore… – ma che allora erano pressoché sconosciuti in Italia. E osservai, inizialmente un po’ intimidita, che in realtà era facile capire perché non ci si iscrivesse, che la domanda cruciale da porsi, il quesito cui trovare una risposta, era esattamente il contrario: come mai ci fossero molti che si iscrivevano pagandone i costi, nonostante che il principale bene offerto dal sindacato mediante la contrattazione collettiva andasse a vantaggio anche dei non iscritti. Ricordo che la reazione immediata fu di grandissimo sconcerto, stupore e fin indignazione, e ne nacque un vivacissimo dibattito, come del resto era avvenuto nel seminario su Olson e il suo The logic of collective action a Milano. Ma Guido Romagnoli comprese al volo e appoggiò la mia idea di impostare la rilevazione empirica di cui ero responsabile intorno all’ipotesi che occorreva comprendere quali fossero i beni, o incentivi selettivi di fatto esplicitamente o implicitamente, anche inconsapevolmente, offerti dal sindacato in cambio dell’iscrizione. E questa fu l’ipotesi di fondo che guidò la ricerca entro un disegno complesso di variabili strutturali di contesto, di variabili indipendenti, intervenienti e dipendenti. Studiammo quattro casi provinciali, uno ciascuno in Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia per tener conto della diversa articolazione socio-economica del paese su base territoriale. Io andai lontano, nell’estremità della Puglia. Fu un’esperienza particolarmente bella e fruttuosa: alla fine furono individuati tre modelli di sindacalizzazione, che sono quelli che anche Guido fece propri, e che sarebbero diventati una chiave di lettura per leggere le variazioni negli andamenti della sindacalizzazione più in generale (come nel saggio Ipotesi sulla sindacalizzazione negli anni Settanta che poi scrissi su richiesta di Mimmo Carrieri nel 1981). …Sul piano personale quella ricerca è anche legata a un episodio significativo nella mia esperienza di studiosa donna. Ma non so se ha importanza raccontarlo…
Perché no? ….
Andai due volte sul campo, nel 1979. La prima volta c’era anche Guido Romagnoli. La seconda andai da sola; stavo in albergo e poi andavo in giro a intervistare questo e quello, a prendere dati. Avevo anche deciso di intervistare alcuni segretari comunali fuori città e allora mi accompagnava in macchina un giovane sindacalista della Fim, bravissimo, che mi ha fatto capire molte cose. Alla fine di una di queste interviste fuori città, una bellissima intervista, salutandomi il mio interlocutore aggiunse: “Signora, sono le sei, dovrà andare a casa dai suoi figli”. Automaticamente risposi “Non si preoccupi, la mia famiglia, mio marito sono a Milano…”. Lui cambiò completamente lo sguardo e mi sentii come spogliata, mentre mi diceva: “Beh, se ha tempo, se vuole rimanere a cena con me stasera…”. Chiaro che la cosa finì lì. Anche allora non ero una persona che si faceva facilmente intimidire, ma mi aveva molto colpito il subitaneo cambiamento di atteggiamento e di sguardo quando si era saputo che mio marito non era dietro l’angolo. Tornata in albergo, la mattina dopo vado alla sede della Cisl per le mie interviste come sempre e come sempre vado poi a mangiare un boccone fuori con gli altri. Mentre si era lì, a un certo punto mi si avvicina uno dei giovani del sindacato – eravamo nel 1979, io avevo 33 anni ma sembravo forse un filo più giovane, lui avrà avuto 25 anni – e mi dice “Ci ho pensato tutta la notte… Ma io non lo farei! …” Io non capivo: “Di che cosa stai parlando? Che cosa non faresti?”. E lui: “Io non lascerei mia moglie andare in giro così…”. Mi montò una collera grandissima: che ne sapevano del mio rapporto – bellissimo, certo per loro inimmaginabile – con mio marito? E in ogni caso con che diritto giudicavano la mia vita? Perché d’un tratto mi fu chiaro che la mia presenza era oggetto di chiacchiere e giudizi malevoli. Rimasi molto fredda, non dissi una parola, ma feci con grande studiata consapevolezza una cosa molto semplice, che ebbe un effetto straordinario: mi alzai e pagai il caffè a tutti. Rimasero come impietriti: una donna che offre il caffè agli uomini non era propriamente nella logica delle cose… Un’umiliazione…
Finii la mia ricerca tranquilla e scrissi un rapporto credo interessante, ma in cui non si diceva esattamente quello che i miei interlocutori avrebbero voluto sentirsi dire. Ho sempre avuto una forte consapevolezza della responsabilità di chi fa ricerca per cercare di capire (ci sono anche altre ragioni per fare ricerca, ma adesso non è il momento di parlarne), dell’onestà con sé stesso e con gli altri che deve caratterizzare il più possibile il lavoro dell’intellettuale, specie in campo sociale, a cui compete di restituire con lealtà quello che ha trovato, che ha capito, anche se può essere sgradevole per qualcuno, a cominciare dal committente. Magari occorre trovare le forme e i modi più adatti per evitare equivoci e polemiche sterili, ma è un dovere morale cui non ci si può sottrarre. Anche questa era una lezione di Pizzorno. Scrissi quindi il mio rapporto sui tre modelli di sindacalizzazione che erano stati svelati dall’analisi empirica, due dei quali si basano su logiche di scambio utilitaristico, a volte anche un po’ truffaldino, che mi rendevo conto non sarebbero piaciuti alla committenza. Cercai di scriverlo in punta di penna… Nessuno ebbe a che ridire, per lo meno apertamente. Solo una volta, quando mi capitò di presentare i risultati in un’assemblea di iscritti della Cisl in Veneto, percepii un rifiuto e un’evidente ostilità nei confronti di quanto dicevo che sottilmente mi intimorivano, erano come un muro e fu faticoso giungere alla fine.
Mi rendo conto che per me è stata una ricerca importante anche come occasione di crescita umana nella professione, in particolare per quanto riguarda il rapporto con la committenza e la mia identità di studiosa donna. Su quest’ultimo versante, è qui che ho incominciato a capire qualcosa di cui avrei poi tante volte discusso con le dottorande, con le collaboratrici: e cioè che noi come donne abbiamo una potenzialità forse maggiore di fare buone interviste di tipo qualitativo, di interviste volte alla scoperta… Questo perché abbiamo una maggiore capacità di empatia; e perché probabilmente abbiamo – questo vale per me, ma forse per noi donne più in generale – una minore propensione a ritenere di aver già una verità in tasca, di sapere in anticipo ciò che conta e va tenuto e ciò che è secondario e si può trascurare. Ciò può renderci più disponibili a cogliere particolari apparentemente irrilevanti, ma che, risultando fuori posto, deviando dalle attese, possono rivelarsi punti d’accesso a nuovi modi di osservare le cose o a aspetti in precedenza non considerati. Nel caso della ricerca sulla sindacalizzazione aspetti del tutto imprevisti emersero conversando con il sindacalista della Fim, che casualmente mi parlò di dinamiche eccentriche nel comportamento degli iscritti che sarebbero diventate illuminanti per comprendere l’importanza dell’identità nelle dinamiche sull’iscrizione al sindacato in sistemi competitivi come il nostro. E lo stesso capitò in altri casi. Ma c’è un altro aspetto, collegato a questo: proprio perché ti metti nell’atteggiamento di chi non sa già tutto e invece sta cercando di capire per davvero, in qualche modo faciliti in chi ti sta rispondendo una maggiore disponibilità a lasciarsi andare, e talvolta a dire cose che altrimenti a altri – magari a intervistatori uomini che si presentano più sicuri di sé – non direbbero. Di questo mi sarei resa conto via via con più chiarezza in varie occasioni in seguito. Ci fu per esempio un progetto di ricerca sulla democrazia nel sindacato promossa dalla Fondazione Brodolini. Io coordinavo uno studio sui congressi sindacali e a qualche mese dalla fine delle tornate congressuali intervistai a Roma i segretari generali delle tre confederazioni e di alcune categorie. Ricordo che in un caso feci una lunga intervista al segretario di un sindacato dei braccianti. Non ci conoscevamo. Alla fine feci alcune considerazioni di carattere generale. Lui ne fu stupito e un po’ preoccupato: “Ma allora lei queste cose le conosce?!…” E credo che mentalmente ripassasse quanto aveva detto col timore di aver rivelato qualcosa di sconveniente. “Beh, è diverso tempo che faccio ricerche sul sindacato… E il mondo sindacale è così variegato e interessante da capire…” dissi conciliante. L’avevo intervistato con interesse e attenzione, facendo molte domande, anche apparentemente ovvie, per avere conferme ma soprattutto per andare oltre quello che sapevo già. Ma certo all’inizio lui avrà pensato che quella giovane (e donna…) curiosa fosse un po’ sprovveduta, che non ci fossero rischi a parlare in libertà… Ho spesso sperimentato che una certa più facile propensione femminile alla curiosità e all’empatia, in cui metti a tuo agio l’altro e cerchi di capirne le ragioni senza giudicare, anche se fosse evidente che non la pensa come te, è una marcia in più, preziosa nell’attività di ricerca. Poi naturalmente ciò che infine conta dipende da come utilizzi i dati che così raccogli, quanto riesci a capire delle dinamiche che suggeriscono, alla luce di ciò che si sa già, di ciò che si dice, alla luce della teoria: dati che cercherai quindi di interpretare in modo strutturato e non personalizzato, secondo un percorso di progressivi avvicinamenti a una comprensione più generale, che può infine condurti a proporre tipi ideali stilizzati. In questo processo di semplificazione e generalizzazione il nome e cognome – ma non il ruolo! – di chi te l’ha detto diventa irrilevante.
…E questa percezione di una specificità di studiosa, ma di studiosa donna, l’hai sentita in tutta la tua carriera…
In qualche modo sì. E credo faccia parte delle ragioni per cui mi sono sempre ritrovata profondamente realizzata nel fare ricerca, indipendentemente dai risultati in termini di carriera e successo. In questo – intendo nella disponibilità a ascoltare e cercare di capire le ragioni dell’altro e a cercare di tenerne accuratamente conto – può aver anche giocato il fatto che all’inizio non avevo quella sicurezza sulle mie capacità che in modo incrollabile ha sempre invece avuto mio marito. Io avevo più dubbi, anche se dalla mia avevo sicuramente due cose: una grande tensione o passione di tipo conoscitivo, soprattutto legata al comportamento umano – l’ho avuta sempre, fin dalla scuola, era un fatto mio, per me molto importante – e un grande attivismo e propensione a fare, anche di tipo pratico. Mi è congeniale spendermi in cose molto concrete: mi piace far da mangiare e mi piace ricamare… E nel fare ricerca, empirica, c’è una dimensione conoscitiva e c’è una dimensione pratica… Quello che sicuramente non mi è mai stato particolarmente congeniale è l’aspetto remunerativo di tutto ciò (in profonda sintonia anche in questo con mio marito), o un’adeguata attenzione agli sbocchi di carriera, e forse anche – e soprattutto questo oggi mi sembra un errore – un sufficiente interesse a impegnarmi per valorizzare i risultati della ricerca nel dibattito culturale e scientifico più generale. Quanto al primo punto, essendo per diverso tempo rimasta fuori da una posizione strutturata, talvolta guadagnavo e talvolta no, eppure – questo lo posso dire con assoluta tranquillità – era l’esito di una scelta fatta con mio marito, non mi pesava, non mi sentivo una precaria. Del resto, molti degli studi che più mi hanno appassionato li ho fatti prima di entrare in università.
Tra quelli che più mi piace ricordare, ci fu naturalmente la ricerca sulla mobilitazione operaia in Italia di Pizzorno, in cui scrissi (nel volume Lotte operaie e sindacato: il ciclo 1968-1972 in Italia, del 1978, che concludeva la ricerca) il capitolo Rappresentanza operaia e sindacato: il mutamento di un sistema di relazioni industriali; e prima ancora, quando la ricerca venne estesa anche agli altri paesi europei, il saggio Conflitti di lavoro e relazioni industriali in Italia, scritto assieme a Marino Regini e Emilio Reyneri (pubblicato in italiano nel volume Conflitti in Europa a cura di Colin Crouch e Alessandro Pizzorno del 1977, e poi l’anno dopo in inglese da Macmillan). Ci fu la ricerca sulla sindacalizzazione di cui ho detto. Ci fu lo studio sui consigli di fabbrica in Italia, promosso dal Centro Studi Cisl, da cui nacque il 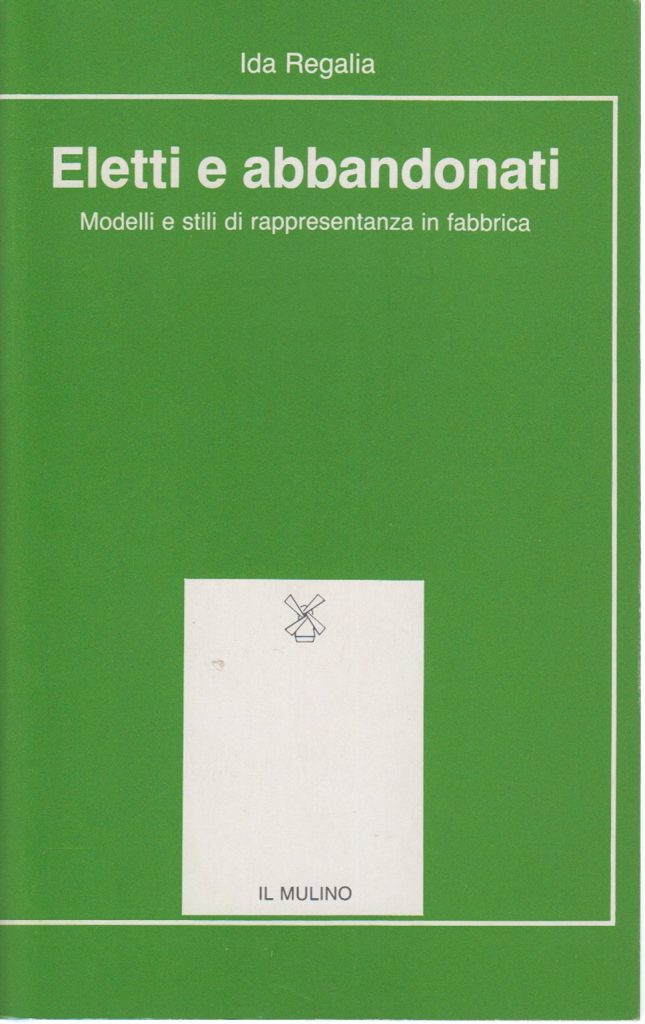 volume Eletti e abbandonati. Modelli e stili di rappresentanza in fabbrica, del 1984. Ci furono le riflessioni e la ricerca sulla democrazia nel sindacato, che sfociarono in brevi articoli: Democrazia e sindacato. Preliminari per una riflessione critica (su “Il Mulino” nel 1984 e in inglese su “Economic and Industrial Democracy” nel 1988); e Quale democrazia nel sindacato. Note a margine di uno studio sui congressi sindacali (pubblicato molto più avanti, nel 1999, negli Scritti in onore di Gino Giugni
volume Eletti e abbandonati. Modelli e stili di rappresentanza in fabbrica, del 1984. Ci furono le riflessioni e la ricerca sulla democrazia nel sindacato, che sfociarono in brevi articoli: Democrazia e sindacato. Preliminari per una riflessione critica (su “Il Mulino” nel 1984 e in inglese su “Economic and Industrial Democracy” nel 1988); e Quale democrazia nel sindacato. Note a margine di uno studio sui congressi sindacali (pubblicato molto più avanti, nel 1999, negli Scritti in onore di Gino Giugni ). E ci furono diversi studi sulle relazioni di lavoro in diversi ambiti del terziario, che mi appassionarono molto e confluirono nel libro Al posto del conflitto. Le relazioni di lavoro nel terziario del 1990: un titolo che suscitò un certo scandalo negli ambienti sindacali (del resto non era piaciuto a molti neppure il titolo ‘Eletti e abbandonati’…). Allora ero da qualche anno approdata all’Ires Lombardia, l’istituto di ricerca della Cgil lombarda, diretto in modo estremamente innovativo da Marino Regini e per cui sarebbe transitata una gran parte dei sociologi economici che ora sono nell’università.
). E ci furono diversi studi sulle relazioni di lavoro in diversi ambiti del terziario, che mi appassionarono molto e confluirono nel libro Al posto del conflitto. Le relazioni di lavoro nel terziario del 1990: un titolo che suscitò un certo scandalo negli ambienti sindacali (del resto non era piaciuto a molti neppure il titolo ‘Eletti e abbandonati’…). Allora ero da qualche anno approdata all’Ires Lombardia, l’istituto di ricerca della Cgil lombarda, diretto in modo estremamente innovativo da Marino Regini e per cui sarebbe transitata una gran parte dei sociologi economici che ora sono nell’università.
Come ti sei avvicinata e poi sei entrata all’università?
Formalmente sono entrata nel 1992, vincendo un concorso nazionale a associato. Iniziai a insegnare all’Università di Torino. Nel 2000 venni chiamata alla Statale a Milano, dove avrei coordinato due nuovi corsi di laurea e il dottorato in Scienze del lavoro, sarei stata direttore di Dipartimento, nel Consiglio di amministrazione dell’Ateneo. In quegli anni divenni coordinatrice della sezione Economia, lavoro e organizzazione dell’Associazione italiana di sociologia e poi presidente della Society for the Advancement of Socio-Economics – Sase… Ma tornando a come mi ci sono avvicinata, negli anni settanta, all’epoca della ricerca con Pizzorno, Emilio Reyneri, Marino Regini e Bianca Beccalli erano entrati in università come professori incaricati. L’università si stava trasformando in università di massa e era in forte espansione, e in espansione erano gli insegnamenti in ambiti allora nuovi come la sociologia, anche per effetto della mobilitazione sociale. Io ero un poco più giovane e ammetto che non me ne curai: un po’ero intimorita e non mi sentivo pronta, un po’ero incerta di fronte all’ipotesi di assumermi un impegno che certo mi avrebbe condotta lontano da Milano avendo due figli piccoli. Benché non mi fossi data la pena di guardare in giro, ricevetti in realtà una proposta, mi sembra dall’università di Sassari. Ma proprio in quei giorni uno dei due bambini non era stato bene e mi sembrò sbagliato mettermi nell’ottica di stare lontana da casa per periodi lunghi. Con grande disapprovazione di mio marito, che cercò a lungo di farmi cambiare idea, lasciai correre. Del resto, pensavo che non sarebbero mancate altre occasioni. Non fu così. La legge di riforma del 1980 congelò l’esistente e bloccò gli accessi per quasi dieci anni. Io rimasi fuori. Qualche contatto con l’università, Statale e la neonata Facoltà di Scienze Politiche, per qualche tempo l’ho comunque avuto: facevo le esercitazioni degli studenti e per un anno e mezzo fui supplente dell’insegnamento di sociologia del lavoro di Bianca Beccalli che era andata per un periodo di studio all’estero. Tenni il corso, feci laureare molti studenti – una tesi divenne un importante libro sulla storia del sindacato nelle banche; ma il merito era dello studente, bravissimo! – e scoprii che il mestiere mi piaceva.
Dopo, ci fu l’incontro con Marino Regini: diciamo un secondo incontro, perché ci eravamo già conosciuti e eravamo diventati amici fraterni durante la ricerca con Pizzorno. Lui aveva poi seguito altri brillanti percorsi. Nel 1984 venne chiamato da Bruno Trentin, che era allora segretario generale della Cgil, a mettere ordine e dirigere l’Ires Lombardia. Lui fece un progetto che ne avrebbe fatto un istituto di ricerca, legato al sindacato, di alto livello. Fin da subito chiese che ci fossi anche io per le tematiche di relazioni industriali: io sarei poi rimasta all’Ires per vent’anni fino a quando l’istituto venne sciolto nel 2004. Con Marino si rinvigorì così un sodalizio che non è più venuto meno: non ho difficoltà a dire che è tra le cose più belle che mi ha dato la vita e di cui sono molto grata. Col tempo abbiamo preso parte con varia responsabilità a molti progetti e scritto insieme saggi e articoli su diversi aspetti delle relazioni di lavoro in Italia, che sono stati pubblicati, per darne un’idea, nel manuale di Relazioni industriali a cura di Gianprimo Cella e Tiziano Treu (del 1982 e 1989), nel volume Employment Relations in a Changing World Economy a cura di Richard Locke, Thomas Kochan, Micael Piore (del 1995), nel terzo volume della Storia dell’Italia repubblicana di Einaudi, curato da Barbagallo (del 1996), in Crisis and Transition in Italian Politics a cura di Martin Bull e Martin Rhodes (del 1997), nel volume Changing Industrial Relations In Europe a cura di Anthony Ferner e Richard Hyman (del 1998), in Trade Unions in Europe. Facing Challenges and Searching for Solutions a cura di Jeremy Waddington e Reiner Hoffmann (del 2000), in The New Structure of Labor Relations, a cura di Harry Katz, Wonduck Lee e Joohee Lee (del 2004). E ancora di recente, nel 2018, in South European Society and Politics.
Il periodo passato all’Ires fu molto importante. Non tanto sul versante economico – non avevamo stipendio, ma compensi piuttosto frugali sulle ricerche cui partecipavamo – ma perché per me significava una certa stabilità entro uno spazio strutturato e umanamente gradevole, ricchissimo di sollecitazioni, e perché permetteva continuità nel fare ricerca. Ed essendomi io ormai appassionata di ogni aspetto che riguardasse il lavoro, la sua regolazione, la sua rappresentanza, che si trattasse di democrazia del sindacato, o di rappresentanza nei luoghi di lavoro, o di relazioni di lavoro in azienda, o di politiche del lavoro, o di flessibilità e forme non standard d’impiego, o di relazioni sindacali nelle banche, o nei trasporti, nei fast-food o nei pony express, o nella grande distribuzione, eccetera eccetera, per me erano tutte tematiche che mi intrigavano, mi appassionavano. Ed è ancora così. Molti si stupiscono di questo. Ma per me il lavoro, ogni forma di lavoro, che è l’altra faccia viva del mondo della produzione e dei servizi, è talmente centrale per la vita e nella definizione dell’identità delle persone, e allo stesso tempo è così tanto in movimento, in trasformazione, sfuggente e refrattario a facili etichette, che non capisco come si possa non esserne affascinati… A me non interessano particolarmente gli aspetti tecnici specifici o l’organizzazione del lavoro in quanto tale, se non come variabili che influiscono sul modo in cui si lavora. A me interessa il modo in cui le persone lavorano, si identificano e si realizzano con il loro lavoro e come possano avere una vita il più possibile buona a partire dalle condizioni di lavoro. E come si possa distribuire e promuovere il lavoro perché non manchi. Ma questo a partire dalla realtà che intanto c’è e da quello che è realistico fare per cambiare in meglio, e non in base a quello che si pensa o si vorrebbe in modo astratto che fosse. Quando ho incominciato a studiarlo cinquant’anni fa il lavoro – quello formalizzato, per il mercato – era per lo più lavoro operaio e racchiuso in luoghi di lavoro ben identificati. Era il culmine del modo di produzione fordista. Da allora non ha mai cessato di assumere forme diverse e trasformarsi, secondo una molteplicità di traiettorie, in relazione ai mutamenti del modo di produrre e di consumare, agli andamenti dell’economia, ma anche in relazione ai mutamenti sul piano sociale – e spesso questo non viene considerato – così che non è affatto agevole coglierne il senso e le implicazioni. Questa diversificazione, o segmentazione, o fluidificazione del mondo del lavoro continua a interrogarti… Ho appena finito una ricerca sulle relazioni di lavoro nelle piccole imprese, i cui risultati mi è sembrato potessero aprire degli spiragli di interpretazione non scontata sulla dinamica delle relazioni di lavoro più in generale, comprese le grandi imprese, tradizionali o innovative, i distretti industriali e l’economia diffusa. Ma mi sono subito resa conto, quando ho finito di scrivere, che c’era tanto altro da considerare: per esempio una realtà come quella della platform economy, che pone problemi nuovi di impostazione sia dal punto di vista di che cosa significhi qui lavorare sia dal punto di vista di dare le opportune tutele al lavoro. Ti dico questo per spiegare come per me la tematica sia così appassionante, rimanga un campo pieno di sorprese. …Non è che continuo per mestiere, perché so già, e magari vorrei conferme, ma al contrario perché non so (abbastanza) e vorrei capire di più…
Questa è una caratteristica tua. Conoscendoti da tempo, per te appena finisci una ricerca c’è sempre qualcosa che “sì, va bene, ma è da capire meglio…” E questo è forse quello che, penso, immagino, ti abbia un po’ spinto a andare avanti e a innovare sempre di più sul tema del sindacato e delle relazioni di lavoro. Adesso mi vieni a parlare di platform economy che la maggior parte degli studiosi di relazioni industriali, a parte i più giovani, non conoscono….
…Ma parliamo ancora di piccole imprese. Assieme a un bel gruppo di studiosi giovani, ho fatto questa ricerca sulle piccole imprese di cui sono abbastanza soddisfatta… Sono emerse cose importanti e ho capito meglio alcune dinamiche che si leggono in particolare nell’ultimo capitolo del volume, a più voci, pubblicato ora da Palgrave con un titolo impegnativo:  Regulating Work in Small Firms. Perspectives on the Future of Work in Globalised Economies. In realtà, riguardandolo, mi verrebbe da dire che forse avrei dovrei dovuto scriverlo in modo un po’ diverso… Ma quello che vorrei ora sottolineare, Sabrina, è che la questione del lavoro e della sua regolazione nella piccola impresa – una tematica di per sé certo non particolarmente innovativa – mi ha sempre colpito, mi ha sempre stupito per lo scarto evidente tra la sua rilevanza in termini quantitativi e la sostanziale disattenzione con cui è per lo più scivolata via negli studi sul lavoro e le relazioni industriali. Sia da un punto di vista economico, sia in termini di numero di imprese e di percentuale sugli occupati totali, la piccola impresa rappresenta una realtà imponente. Non solo in Italia, dove sono la maggioranza, ma in tutte le economie avanzate quasi la metà di chi lavora è in un’impresa piccola o piccolissima. Che questo non sia mai divenuto, se non in maniera laterale o occasionale, come un importante filone nello studio e nella riflessione sulle relazioni di lavoro – con l’eccezione però di una scuola che si è affermata un po’ curiosamente nel Regno Unito e in Australia… – è un evidente segnale dei limiti degli studi, dell’attenzione sulle relazioni di lavoro. Tu non poi lavorare sulle relazioni industriali basandoti solo sulla logica della media e grande impresa. Certo, quella è, è stata, fondamentale, perché ha permesso di immaginare e proporre via via miglioramenti e soluzioni alla fatica del lavoro industriale mediati dalla contrattazione collettiva: la riduzione dell’orario, la riduzione dei ritmi, una certa definizione dei compiti… Nella piccola impresa non è così, si fa in altro modo. Nella piccola impresa tutti tendono a far tutto. E allora questa parte del mondo del lavoro non la consideriamo, o la consideriamo solo in negativo, per evidenziare come si discosti dal modello dell’impresa più grande e strutturata? Mi è sempre più chiaro che per riflettere fruttuosamente su come si regola il lavoro – su come lo si fa e come lo si potrebbe far meglio – occorre disporre di un quadro di riferimento che possa tener conto di tutte le realtà esistenti: delle imprese piccole e delle grandi; e anche di realtà come la platform economy, ossia di quel modo di lavorare che non è più strutturato dentro organizzazioni in senso tradizionale, e la cui collocazione entro gli schemi ereditati dal passato – sono lavoratori autonomi o che cosa? – è incerto e oggetto di dibattito in tutti i paesi avanzati. Per questo non mi ritrovo più negli schemi tradizionali delle relazioni industriali: occorre una visione il più possibile inclusiva… Mi rendo conto che il mio è stato, è ancora…, un percorso di continuo allargamento della prospettiva: dalla fabbrica metalmeccanica studiata con Pizzorno al mondo dei servizi, alle multinazionali, dall’azienda come organizzazione ben identificabile a tutti i modi di lavorare che non entrano più in un contenitore chiaro, ben definito e ben circoscrivibile, ossia entro un “luogo” di lavoro per cui puoi sapere chi è dentro e chi è fuori, e alle varie mutevoli forme di rapporto d’impiego.
Regulating Work in Small Firms. Perspectives on the Future of Work in Globalised Economies. In realtà, riguardandolo, mi verrebbe da dire che forse avrei dovrei dovuto scriverlo in modo un po’ diverso… Ma quello che vorrei ora sottolineare, Sabrina, è che la questione del lavoro e della sua regolazione nella piccola impresa – una tematica di per sé certo non particolarmente innovativa – mi ha sempre colpito, mi ha sempre stupito per lo scarto evidente tra la sua rilevanza in termini quantitativi e la sostanziale disattenzione con cui è per lo più scivolata via negli studi sul lavoro e le relazioni industriali. Sia da un punto di vista economico, sia in termini di numero di imprese e di percentuale sugli occupati totali, la piccola impresa rappresenta una realtà imponente. Non solo in Italia, dove sono la maggioranza, ma in tutte le economie avanzate quasi la metà di chi lavora è in un’impresa piccola o piccolissima. Che questo non sia mai divenuto, se non in maniera laterale o occasionale, come un importante filone nello studio e nella riflessione sulle relazioni di lavoro – con l’eccezione però di una scuola che si è affermata un po’ curiosamente nel Regno Unito e in Australia… – è un evidente segnale dei limiti degli studi, dell’attenzione sulle relazioni di lavoro. Tu non poi lavorare sulle relazioni industriali basandoti solo sulla logica della media e grande impresa. Certo, quella è, è stata, fondamentale, perché ha permesso di immaginare e proporre via via miglioramenti e soluzioni alla fatica del lavoro industriale mediati dalla contrattazione collettiva: la riduzione dell’orario, la riduzione dei ritmi, una certa definizione dei compiti… Nella piccola impresa non è così, si fa in altro modo. Nella piccola impresa tutti tendono a far tutto. E allora questa parte del mondo del lavoro non la consideriamo, o la consideriamo solo in negativo, per evidenziare come si discosti dal modello dell’impresa più grande e strutturata? Mi è sempre più chiaro che per riflettere fruttuosamente su come si regola il lavoro – su come lo si fa e come lo si potrebbe far meglio – occorre disporre di un quadro di riferimento che possa tener conto di tutte le realtà esistenti: delle imprese piccole e delle grandi; e anche di realtà come la platform economy, ossia di quel modo di lavorare che non è più strutturato dentro organizzazioni in senso tradizionale, e la cui collocazione entro gli schemi ereditati dal passato – sono lavoratori autonomi o che cosa? – è incerto e oggetto di dibattito in tutti i paesi avanzati. Per questo non mi ritrovo più negli schemi tradizionali delle relazioni industriali: occorre una visione il più possibile inclusiva… Mi rendo conto che il mio è stato, è ancora…, un percorso di continuo allargamento della prospettiva: dalla fabbrica metalmeccanica studiata con Pizzorno al mondo dei servizi, alle multinazionali, dall’azienda come organizzazione ben identificabile a tutti i modi di lavorare che non entrano più in un contenitore chiaro, ben definito e ben circoscrivibile, ossia entro un “luogo” di lavoro per cui puoi sapere chi è dentro e chi è fuori, e alle varie mutevoli forme di rapporto d’impiego.  Una tappa per me molto importante di questo processo di allargamento della prospettiva fu una vasta ricerca, finanziata dal IV European Framework Programme, sulle forme di lavoro non standard e le potenzialità della regolazione locale in Europa, di cui ero la responsabile scientifica e i cui risultati vennero pubblicati nel volume di Routledge Regulating New Forms of Employment: Local Experiments and Social Innovation in Europe nel 2006 (e poi in italiano come Regolare le nuove forme di impiego Esperimenti locali di flexicurity in Europa).
Una tappa per me molto importante di questo processo di allargamento della prospettiva fu una vasta ricerca, finanziata dal IV European Framework Programme, sulle forme di lavoro non standard e le potenzialità della regolazione locale in Europa, di cui ero la responsabile scientifica e i cui risultati vennero pubblicati nel volume di Routledge Regulating New Forms of Employment: Local Experiments and Social Innovation in Europe nel 2006 (e poi in italiano come Regolare le nuove forme di impiego Esperimenti locali di flexicurity in Europa).
Fu importante per la possibilità di svolgere uno studio comparativo in cui, entro uno stesso disegno di ricerca sul campo, si mettevano a confronto le esperienze di sviluppo e regolazione, in particolare a livello locale, delle  varie flessibilità di impiego del lavoro in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. Da allora il senso di termini come flessibilità, o lavori atipici, o anche regolazione locale acquistarono per me uno spessore, una dimensione poliedrica e multiforme inaspettati, e un po’ diversi dagli stereotipi di senso comune. In parte se ne colgono gli echi in un saggio, che mi è caro, e che avrei scritto su invito della giurista americana Katherine Stone, Regional and local-level experiments for labor-market policy in Europe (in Rethinking Workplace Regulation: Beyond the Standard Contract of Employment a cura di Katherine Stone e Harry Arthurs presso Russell Sage nel 2013).
varie flessibilità di impiego del lavoro in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. Da allora il senso di termini come flessibilità, o lavori atipici, o anche regolazione locale acquistarono per me uno spessore, una dimensione poliedrica e multiforme inaspettati, e un po’ diversi dagli stereotipi di senso comune. In parte se ne colgono gli echi in un saggio, che mi è caro, e che avrei scritto su invito della giurista americana Katherine Stone, Regional and local-level experiments for labor-market policy in Europe (in Rethinking Workplace Regulation: Beyond the Standard Contract of Employment a cura di Katherine Stone e Harry Arthurs presso Russell Sage nel 2013).
Più in generale, di fronte alla straordinaria diversificazione del mondo del lavoro che abbiamo sotto gli occhi, in cui si intrecciano ragioni e dimensioni di tipo economico-produttivo e di tipo politico, di opportunità offerte dalla tecnologia, di dinamiche e aspettative di tipo sociale (e che non ha senso leggere alla luce di qualche facile teoria del complotto per cui qualcuno manovrerebbe per non assumere più con contratti stabili a tempo indeterminato per indebolire il lavoro e le sue organizzazioni di rappresentanza), credo che occorra fare molta ricerca empirica, in modo paziente, lento, cercando il modo di guardare più adeguato, e da più punti di vista. Per esempio, si parla molto dell’utilizzo della tecnologia informatica, dei modi nuovi di informazione e comunicazione, di social network. Indubbiamente sono elementi fondamentali per capire come oggi si regola il lavoro. Le aziende utilizzano le nuove tecnologie per organizzare ai propri fini il lavoro e i flussi produttivi e da tempo così riescono a coordinare lavori e luoghi di lavoro assolutamente eterogenei, disarticolati, distanti. Ma le nuove tecnologie permettono ai cittadini, agli individui di comunicare e produrre azioni che un tempo non si potevano fare. Cosa può vuol dire questo? Che effetti ha questo da un punto di vista del lavoro, della sua rappresentanza, della sua regolazione? Le implicazioni sono potenzialmente enormi, positive, ma anche negative, rischiose, difficili da controllare. E da chi? Occorre studiarlo bene e non a tavolino. In effetti incomincia a esserci una letteratura su questo, su come questo possa diventare, sia già talvolta diventato, un modo inedito di esprimere la protesta e di organizzare il conflitto anche nel mondo del lavoro: un modo ben diverso dalla logica dello sciopero. La razionalità originaria dello sciopero stava nella capacità di costringere al confronto una controparte riottosa bloccando una produzione di cui essa aveva forte necessità, o minacciando di farlo. Con la crescente globalizzazione dell’economia, in particolare nella produzione di beni, lo sciopero tende però a diventare un’arma sostanzialmente spuntata sul terreno economico e a assumere soprattutto valore rituale e dimostrativo nel rapporto tra rappresentanti e rappresentati, o a costituire un segnale inviato a altri, alle autorità politiche. La logica di una protesta organizzata in rete, da un social network, è volta invece a attaccare la reputazione di un’impresa; e le sue condizioni di successo sono assai diverse. Da qui possono acquistare un senso nuovo tutti i ragionamenti sulla corporate social responsability e sugli International frameworks agreements, che di per sé possono apparire come dei corollari, dei particolari poco significativi e di limitato interesse in termini di successo in un’ottica tradizionale di relazioni sindacali; ma possono rivelarsi invece quei particolari un po’ marginali che possono aprirti nuove prospettive. Recentemente mi è capitato di essere invitata dalla scuola di management del Politecnico a parlare di relazioni industriali a un corso per dirigenti d’azienda. Dopo ragionamenti più generali, e tradizionali, ho appunto fatto anche cenno ai social network e più in generale a come oggi l’impresa sia particolarmente sensibile a ogni forma di attacco alla sua reputazione. E la cosa ha avuto successo: “finalmente una cosa su cui ci misuriamo tutti i giorni!”, qualcuno ha osservato. Molto più di altro, questo dovrebbe essere un punto su cui riflettere anche dal punto di vista della rappresentanza del lavoro…
Io volevo portarti proprio su questo. Nella tua carriera tu sei intervenuta non solo in ambiti accademici, ma anche in scuole di formazione e nel sindacato. Com’è cambiato nel tempo il messaggio che tu porti a queste persone? Perché tu hai cambiato la tua visione, ma loro ti seguono?
Dipende. … Ma non direi che ho cambiato il modo di vedere le cose. È cambiata la realtà da cercare di comprendere. Ciò che scrivevo negli anni settanta o ottanta in relazione a ciò che avveniva allora nel mondo del lavoro e della sua rappresentanza lo sottoscriverei anche oggi… Ma venendo a quello che mi chiedi, recentemente sono stata invitata a un seminario di Italiani Europei, la fondazione di D’Alema, sul tema del lavoro oggi. Si partecipava per inviti e il pubblico era costituito da sindacalisti, intellettuali del partito, studiosi del sindacato. Mi avevano chiesto di parlare sul vissuto soggettivo dei lavoratori oggi e mi avevano suggerito di ragionare in particolare sul nesso flessibilità/precarietà, sullo svilimento del lavoro, sulla perdita di centralità della dimensione lavorativa nella definizione dell’identità dei soggetti, sul rinvio dei tempi di uscita dalla famiglia di origine e le ripercussioni sulla natalità che l’instabilità lavorativa comporta… Ho ripreso tutti questi spunti a uno a uno, dando conto dei modi in cui di solito se ne parla e delle ragioni per cui tende a prevalere una rappresentazione della realtà del lavoro a tinte fosche. E tuttavia, ho poi cercato di mostrare, punto per punto, come questa ne fosse una rappresentazione nel complesso vera, ma parziale, e proprio dal punto di vista della soggettività dei lavoratori. Ho citato alcuni esempi (per lo più tratti dall’intensa attività che da alcuni anni svolgo presso uno sportello della Caritas in un quartiere difficile di Milano, con un occhio di riguardo alla questione del lavoro): esempi da considerare come indizi di qualcosa che per qualche verso non torna, che almeno in parte obbliga a ripensare come si possa valorizzare, tutelare, rappresentare il lavoro così com’è oggi. Il caso per esempio, un paio d’anni fa, del giovane egiziano, da tempo ben socializzato, ma che non riesce a trovare un lavoro con cui mantenersi dignitosamente, e che un giorno viene a dirmi trionfante: “ho finalmente trovato il lavoro per cui ora riesco a vivere bene e mi trovo libero!” Aveva iniziato a fare il rider. Non so se la cosa duri ancora, ma in quel momento quel lavoratore era venuto a raccontarmelo perché gli piaceva e molto. O il caso della ragazza italiana con due figli piccoli e un compagno che la maltratta. Lavorava in una pasticceria, ma aveva smesso con la nascita del secondo figlio. È stata però poi assunta con contratto a tempo determinato a vendere panini e bibite su una postazione mobile in bicicletta al Politecnico; perché lo potesse fare noi abbiamo pagato il nido al bambino, in attesa che potesse usufruire di un servizio pubblico. Tu dovevi vedere com’era contenta! Il progetto purtroppo si è poi concluso, ma intanto per lei è stato un modo per tornare a lavorare, in un ambiente di giovani che le piaceva e con un orario con cui teneva assieme lavoro e cura dei figli. O c’è il caso di chi ha il contratto per le pulizie in una cooperativa e è felice di averlo… Eccetera eccetera…In genere di queste figure che sono così comuni in una città come Milano, come già diverso tempo fa ci aveva mostrato Saskia Sassen, si sottolinea, dicevo, la dimensione della precarietà, ma se ne dimentica la possibile dimensione soggettiva della soddisfazione, del piacere di avere un proprio pur piccolo spazio di realizzazione. E non molto diversamente avviene per le figure invece alte dei freelance nei giornali, nell’editoria, nel mondo della comunicazione e in altro ancora. È dalla riflessione su questo mix di condizioni oggettivamente incerte e soggettivamente positive che occorre che le organizzazioni di rappresentanza del lavoro prendano le mosse, sostenevo, con l’obiettivo non di offrire in modo irrealistico assunzioni a tempo indeterminato a tutti, ma di garantire una piattaforma di diritti individuali e di politiche di welfare realmente, ma realmente!, in grado di rendere socialmente sostenibili le diverse frammentate e mutevoli posizioni di lavoro. Ammetto che l’argomento non ha avuto un gran successo, da qualcuno è stato apertamente criticato su linee molto tradizionali. Qualcuno mi ha però detto “continua così”. Io continuo così: se mi invitano cerco di svolgere quello che ritengo il mio compito di riflessione critica a partire dall’osservazione di fatti e dinamiche reali. …Devo comunque aggiungere che non sono pochi i sindacalisti disponibili a riflettere anche in modo non convenzionale: se non fosse così, non mi inviterebbero… Invece lo fanno, e ne nascono spesso momenti intensi di scambio reciproco. Un rapporto molto bello si era per esempio instaurato con Riccardo Terzi. Quando era diventato segretario nazionale dello SPI, il sindacato dei pensionati della Cgil – lo si immaginerebbe un sindacato un po’ spento, di vecchi rivolti al passato, e invece è una realtà molto vivace, di persone anche spregiudicate –, mi aveva invitato a delle giornate di studio con docenti universitari e studiosi. Ero andata a uno di questi incontri in una bella località della Liguria e si discuteva molto liberamente dei problemi dell’economia e del lavoro. A me aveva chiesto di parlare di come il sindacato poteva o doveva riformarsi sul territorio. Feci un ragionamento che implicava una riforma radicale della logica di organizzazione e rappresentanza del sindacato, sulla falsariga dell’articolo Beyond workplaces and industries: possibilities for organized action at the territorial level, poi uscito su “Comparative Labor Law & Policy Journal” nel 2017. Lui ne era interessatissimo. È per questo che non sono pessimista: sono convinta che il mondo stia cambiando radicalmente, ma che ci sono potenzialità positive da scoprire. Certamente anche negative: quelle è facile vederle. Dire che il lavoro precario crea problemi è ovvio. Ma è importante capire, senza pregiudizi, in che modo per esempio i singoli e le famiglie continuino a andare avanti. E allora puoi anche scoprire che in questo modo precario o comunque instabile di lavorare ritrovino una loro logica e talvolta anche una loro soddisfazione. Ma occorre intanto vedere, con occhi nuovi, al di là di ciò che è scontato. Ne possono nascere soluzioni che permettano il più possibile di sostenere, ampliare, generalizzare gli aspetti positivi che già ci sono, cambiando le regole, modificando le politiche. Se si va indietro nel tempo, all’inizio del Novecento, quando stava scomparendo la manifattura tradizionale e il sindacalismo di mestiere stava perdendo la sua base e la sua logica d’essere, la crisi del sindacato sembrava irreversibile. Ma con i primi tentativi e lo sviluppo poi del sindacalismo d’industria, che è figlio del fordismo, ebbe inizio in modo del tutto inaspettato l’epoca forse più straordinaria nella capacità sindacale di rappresentare i lavoratori sulla base di un nuovo paradigma estremamente più inclusivo, molto più capace di estendere in modo potenzialmente universalistico le tutele. Oggi siamo in una fase nuovamente di travaglio, alla ricerca di un nuovo paradigma. Immaginare le relazioni industriali come prima, centrate sui modi della mediazione collettiva come la conosciamo, non va più bene, è diventato insufficiente. È un punto di cui sono convinta. D’altro canto, fallimentari (e in qualche modo irrealistici) si stanno rivelando per la stessa produttività delle imprese, e non solo in termini di equità e giustizia, i modelli di stampo neoliberista basati semplicemente sul rapporto diretto tra lavoratore e impresa. Persino gli studi sulle piccole imprese mostrano che non tutto si risolve in un’imposizione di tipo autocratico da parte dell’impresa.
Siamo in un’epoca di rifondazione… Siamo come negli anni settanta forse…
Direi di sì, nel senso che ci sono segni, ma sono ancora deboli e dispersi. In questo non è come cinquant’anni fa. Ma segni ci sono. Per esempio, in Italia è potenzialmente già un cambiamento di paradigma la costituzione, entro le grandi confederazioni, di sindacati che non rappresentano il lavoro né sulla base del mestiere, né sulla base del settore di appartenenza come nel sindacalismo d’industria, e neppure sulla base dell’azienda di appartenenza: modelli questi che corrispondono ai diversi classici modi di strutturare la rappresentanza che si sono affermati nel tempo. Questi diversi sindacati, che pure rientrano nella Cgil, nella Cisl e nella Uil, rappresentano i lavoratori altri, gli atipici, i lavoratori temporanei non standard, individuati in base alla peculiarità del loro contratto, ossia del legame particolare con il loro mutevole datore. Nidil della Cgil per esempio è così. E non solo è un (piccolo) sindacato che cerca di rappresentare lavoratori che sono ai margini della tradizionale struttura organizzativa del sindacato, ma soprattutto non è un sindacato di mestiere, né un sindacato di categoria secondo la logica industriale. Sfugge ai modi conosciuti di strutturare la rappresentanza così che inevitabilmente crea problemi organizzativi, tensioni, diffidenze. È una realtà piccola, ma potenzialmente è una cosa nuova, che potrebbe aprire prospettive inedite. Ecco io sono interessata a queste cose qua…
In tutto quello che ci hai raccontato si legge una grande coerenza nel tuo percorso. Certamente raccontando si cerca di rendere più coerente un discorso. Però, come dire, dalle caste, al sindacato, al centro d’ascolto della Caritas oggi, emerge una volontà di metterci le mani e di essere coinvolta nelle cose che ti ha portato nel tempo a essere attiva non solo come studiosa, ma anche come volontaria. Io direi che dopo che ci hai un po’ raccontato quello che pensi del futuro del sindacato, potresti parlarci di questa tua esperienza perché la trovo molto importante e molto coerente con te come persona.
C’è un discorso di fede, che qui ora non interessa. Direi invece che una breve riflessione sul mio impegno come volontaria nella Caritas ha senso qui anche perché, almeno in Italia, ci sono molti punti di contatto tra il sindacato e la Caritas. Tra l’altro, uno dei segni di novità che si possono leggere nell’azione del sindacato oggi, e che emerge in molte ricerche, è un’estensione della sua azione al di fuori dei luoghi di lavoro, verso un’ampia platea di tematiche di tipo sociale, che inevitabilmente lo portano a entrare in contatto e cooperare in varie forme con altri, un po’ erodendo la tradizionale prassi di agire, in quanto rappresentante dei lavoratori, in condizioni di monopolio. L’avevamo in parte già osservato nello studio sulla negoziazione sociale che abbiamo fatto insieme, Sabrina, nel 2011 (Sindacato e welfare locale. La negoziazione delle politiche sociali in Lombardia nel primo decennio degli anni Duemila).  Questi nuovi altri sono i movimenti sociali (anche se in modo limitato da noi), le associazioni di tipo etnico-culturale con riferimento ai lavoratori immigrati, le varie organizzazioni del terzo settore e di matrice religiosa… Nella mia esperienza recente, ho in effetti più volte visto progetti con punti di contatto tra il sindacato – in particolare la Cgil – e la Caritas o altre realtà della Chiesa. Un episodio che mi colpì fu la grande assemblea per discutere dell’enciclica di papa Francesco Laudato si’ sulla custodia del creato e la questione ecologica, che, con una certa mia sorpresa, venne organizzata alla Camera del Lavoro e in cui parlarono come relatori il direttore della Caritas, un teologo, un filosofo non credente. In altra occasione, si tenne sempre alla Camera del lavoro una riunione, coordinata dal responsabile della Casa della Carità, del gruppo, molto eterogeneo quanto a partecipanti, Ero straniero, che organizzava la raccolta delle firme per una nuova proposta di legge di iniziativa popolare sull’immigrazione che ora giace alla Camera. …Mi tornano qui in mente le riflessioni che ricordavo prima di Sidney Tarrow sul sindacato italiano e la sua potenziale apertura, per quanto contradditoria, a tutto quello che avviene, non solo nel mondo del lavoro, anche nel sociale e non solo. A volte penso che anche il mio interesse per il sindacato e per le politiche sociali e del lavoro abbia in qualche modo facilitato la decisione, avvenuta un po’ per caso, di impegnarmi come volontaria nella Caritas del mio quartiere; o che comunque sia stato utile. Avrei scoperto che c’è una non piccola sintonia nel modo di impostare gli interventi. Intanto perché lo stile con cui si lavora nei centri di ascolto, come li aveva istituiti il cardinal Martini, non è di contrapposizione a quello che si fa nel mondo civile e politico; per principio non ci si sostituisce a nessuno. Noi ascoltiamo le persone e, se occorre e possiamo, offriamo sostegno anche immediato: un aiuto per la spesa, per il vestiario, una ricarica del telefono, talvolta un contributo per le bollette… Ma più in generale, cerchiamo di capirne i bisogni, di accompagnarli e essere loro vicini con l’amicizia e l’attenzione, ma instradandoli poi verso le soluzioni offerte dalle istituzioni e altre organizzazioni: le strutture sanitarie ovviamente, i vari servizi del Comune – noi lavoriamo molto con le assistenti sociali – e della Regione, i centri per l’impiego, l’edilizia popolare, le scuole, i patronati, il Tribunale dei minori, i servizi per i detenuti, i vigili, la Questura, i dormitori, le mense, gli ambulatori solidali, varie organizzazioni specializzate e di servizio, e naturalmente il sindacato… Ciò che ci contraddistingue è l’accoglienza e l’ascolto nei confronti di chiunque si presenti, senza alcun limite o filtro, se non quello dell’appartenenza, anche temporanea, all’area territoriale di pertinenza definita dalla parrocchia o parrocchie di riferimento. E chi non rientrasse nel nostro ambito viene indirizzato al proprio centro di ascolto, giacché siamo una rete, o ai servizi centrali della Caritas. Per alcuni versi, è un po’ come il sindacato che in un’ottica universalistica ha (o dovrebbe avere…) sedi aperte a chiunque si presenti e non necessariamente solo ai lavoratori, benché nel nostro caso ovviamente non esistano tessere e iscrizioni. Noi teniamo però una scheda per ogni persona che si rivolge a noi, che viene aggiornata a ogni incontro: è fondamentale per poter rendersi conto in modo rapido dei problemi, dei cambiamenti, dei progressi; essa costituisce inoltre la base conoscitiva dei rapporti sulla povertà annualmente redatti dalla Caritas. Il nostro centro ha anche un progetto speciale, modulato sulla logica delle politiche attive per l’impiego, che si chiama “Fondo per ricominciare”. C’era stata in passato una donazione di una certa consistenza alla nostra parrocchia e il parroco di allora – un prete estremamente sensibile e aperto al servizio degli ultimi – aveva deciso che quella donazione non andasse alla parrocchia, ma al centro di ascolto per qualcosa di speciale. Costituito un piccolo comitato di gestione, si è deciso di utilizzare quei fondi per dare un aiuto straordinario a persone che si trovano in situazioni di necessità, ma che immaginiamo che, con un progetto attivo, mobilitandone le capacità, affiancati da uno o più tutor, possano tornare a essere autonomi e a non avere più bisogno di noi. In realtà questo vale in generale, ma talvolta occorre un intervento un po’ più consistente anche in termini economici, oltre a molto affiancamento. In alcuni casi sai già che la cosa non funzionerebbe, perché le situazioni di disagio o difficoltà sono divenute croniche e a noi, con i nostri limiti, non rimane che continuare a dare attenzione, vicinanza e piccoli aiuti. Ma ce ne sono altre su cui si può scommettere… Abbiamo quindi steso un regolamento che si ispira a come dovrebbero funzionare i servizi attivi per l’impiego e che prevede: la stesura di un progetto, in cui si indicano le azioni da compiere per superare le criticità, che l’interessato deve discutere e approvare; l’individuazione di una scadenza di massima e di tappe intermedie di verifica e riaggiustamento; la designazione di tutor di riferimento; la definizione dell’impegno economico. Che poi funzioni proprio così, direi di no, onestamente. Ma secondo questo spirito e in questa prospettiva si sono fatti interventi molto belli, alcuni dei quali hanno avuto successo e che in ogni caso, almeno per i tutor ma presumo non solo per essi, si sono rivelati esperienze profonde e coinvolgenti. Una delle esperienze più belle di successo, in cui sono stata personalmente, e molto a lungo, coinvolta è stata quella di una giovane egiziana, molto determinata, ma insieme inizialmente fragile e spaesata, e senza disponibilità economiche, che abbiamo aiutato a laurearsi alla Statale in Mediazione linguistica e culturale. Il suo sogno era di diventare mediatrice per le donne arabe presso le istituzioni: ci è sembrato un progetto buono, da sostenere. Le abbiamo pagato le tasse, i libri; soprattutto l’abbiamo aiutata a capire come studiare: un’altra volontaria si è dedicata a questo con incredibile tenacia. Ma ancor prima, all’inizio, è stato necessario sostenerla in un percorso di autonomia e rafforzamento della sua decisione di fronte al marito che non capiva perché lei volesse studiare e che era anzi ostile; e in un percorso di apprendimento su come organizzare la casa e la famiglia in crescita (nel frattempo aveva avuto altri due figli). Si è infine laureata, si è anzi iscritta alla laurea magistrale per proprio conto e con l’approvazione del marito. Ha preso senza dir niente a nessuno la patente di guida. E ha iniziato le prime esperienze di mediatrice culturale per il Comune. Ora siamo diventate amiche, posso dire di essere di casa, anche se riusciamo a vederci raramente. I suoi figli mi chiamano nonna…
Questi nuovi altri sono i movimenti sociali (anche se in modo limitato da noi), le associazioni di tipo etnico-culturale con riferimento ai lavoratori immigrati, le varie organizzazioni del terzo settore e di matrice religiosa… Nella mia esperienza recente, ho in effetti più volte visto progetti con punti di contatto tra il sindacato – in particolare la Cgil – e la Caritas o altre realtà della Chiesa. Un episodio che mi colpì fu la grande assemblea per discutere dell’enciclica di papa Francesco Laudato si’ sulla custodia del creato e la questione ecologica, che, con una certa mia sorpresa, venne organizzata alla Camera del Lavoro e in cui parlarono come relatori il direttore della Caritas, un teologo, un filosofo non credente. In altra occasione, si tenne sempre alla Camera del lavoro una riunione, coordinata dal responsabile della Casa della Carità, del gruppo, molto eterogeneo quanto a partecipanti, Ero straniero, che organizzava la raccolta delle firme per una nuova proposta di legge di iniziativa popolare sull’immigrazione che ora giace alla Camera. …Mi tornano qui in mente le riflessioni che ricordavo prima di Sidney Tarrow sul sindacato italiano e la sua potenziale apertura, per quanto contradditoria, a tutto quello che avviene, non solo nel mondo del lavoro, anche nel sociale e non solo. A volte penso che anche il mio interesse per il sindacato e per le politiche sociali e del lavoro abbia in qualche modo facilitato la decisione, avvenuta un po’ per caso, di impegnarmi come volontaria nella Caritas del mio quartiere; o che comunque sia stato utile. Avrei scoperto che c’è una non piccola sintonia nel modo di impostare gli interventi. Intanto perché lo stile con cui si lavora nei centri di ascolto, come li aveva istituiti il cardinal Martini, non è di contrapposizione a quello che si fa nel mondo civile e politico; per principio non ci si sostituisce a nessuno. Noi ascoltiamo le persone e, se occorre e possiamo, offriamo sostegno anche immediato: un aiuto per la spesa, per il vestiario, una ricarica del telefono, talvolta un contributo per le bollette… Ma più in generale, cerchiamo di capirne i bisogni, di accompagnarli e essere loro vicini con l’amicizia e l’attenzione, ma instradandoli poi verso le soluzioni offerte dalle istituzioni e altre organizzazioni: le strutture sanitarie ovviamente, i vari servizi del Comune – noi lavoriamo molto con le assistenti sociali – e della Regione, i centri per l’impiego, l’edilizia popolare, le scuole, i patronati, il Tribunale dei minori, i servizi per i detenuti, i vigili, la Questura, i dormitori, le mense, gli ambulatori solidali, varie organizzazioni specializzate e di servizio, e naturalmente il sindacato… Ciò che ci contraddistingue è l’accoglienza e l’ascolto nei confronti di chiunque si presenti, senza alcun limite o filtro, se non quello dell’appartenenza, anche temporanea, all’area territoriale di pertinenza definita dalla parrocchia o parrocchie di riferimento. E chi non rientrasse nel nostro ambito viene indirizzato al proprio centro di ascolto, giacché siamo una rete, o ai servizi centrali della Caritas. Per alcuni versi, è un po’ come il sindacato che in un’ottica universalistica ha (o dovrebbe avere…) sedi aperte a chiunque si presenti e non necessariamente solo ai lavoratori, benché nel nostro caso ovviamente non esistano tessere e iscrizioni. Noi teniamo però una scheda per ogni persona che si rivolge a noi, che viene aggiornata a ogni incontro: è fondamentale per poter rendersi conto in modo rapido dei problemi, dei cambiamenti, dei progressi; essa costituisce inoltre la base conoscitiva dei rapporti sulla povertà annualmente redatti dalla Caritas. Il nostro centro ha anche un progetto speciale, modulato sulla logica delle politiche attive per l’impiego, che si chiama “Fondo per ricominciare”. C’era stata in passato una donazione di una certa consistenza alla nostra parrocchia e il parroco di allora – un prete estremamente sensibile e aperto al servizio degli ultimi – aveva deciso che quella donazione non andasse alla parrocchia, ma al centro di ascolto per qualcosa di speciale. Costituito un piccolo comitato di gestione, si è deciso di utilizzare quei fondi per dare un aiuto straordinario a persone che si trovano in situazioni di necessità, ma che immaginiamo che, con un progetto attivo, mobilitandone le capacità, affiancati da uno o più tutor, possano tornare a essere autonomi e a non avere più bisogno di noi. In realtà questo vale in generale, ma talvolta occorre un intervento un po’ più consistente anche in termini economici, oltre a molto affiancamento. In alcuni casi sai già che la cosa non funzionerebbe, perché le situazioni di disagio o difficoltà sono divenute croniche e a noi, con i nostri limiti, non rimane che continuare a dare attenzione, vicinanza e piccoli aiuti. Ma ce ne sono altre su cui si può scommettere… Abbiamo quindi steso un regolamento che si ispira a come dovrebbero funzionare i servizi attivi per l’impiego e che prevede: la stesura di un progetto, in cui si indicano le azioni da compiere per superare le criticità, che l’interessato deve discutere e approvare; l’individuazione di una scadenza di massima e di tappe intermedie di verifica e riaggiustamento; la designazione di tutor di riferimento; la definizione dell’impegno economico. Che poi funzioni proprio così, direi di no, onestamente. Ma secondo questo spirito e in questa prospettiva si sono fatti interventi molto belli, alcuni dei quali hanno avuto successo e che in ogni caso, almeno per i tutor ma presumo non solo per essi, si sono rivelati esperienze profonde e coinvolgenti. Una delle esperienze più belle di successo, in cui sono stata personalmente, e molto a lungo, coinvolta è stata quella di una giovane egiziana, molto determinata, ma insieme inizialmente fragile e spaesata, e senza disponibilità economiche, che abbiamo aiutato a laurearsi alla Statale in Mediazione linguistica e culturale. Il suo sogno era di diventare mediatrice per le donne arabe presso le istituzioni: ci è sembrato un progetto buono, da sostenere. Le abbiamo pagato le tasse, i libri; soprattutto l’abbiamo aiutata a capire come studiare: un’altra volontaria si è dedicata a questo con incredibile tenacia. Ma ancor prima, all’inizio, è stato necessario sostenerla in un percorso di autonomia e rafforzamento della sua decisione di fronte al marito che non capiva perché lei volesse studiare e che era anzi ostile; e in un percorso di apprendimento su come organizzare la casa e la famiglia in crescita (nel frattempo aveva avuto altri due figli). Si è infine laureata, si è anzi iscritta alla laurea magistrale per proprio conto e con l’approvazione del marito. Ha preso senza dir niente a nessuno la patente di guida. E ha iniziato le prime esperienze di mediatrice culturale per il Comune. Ora siamo diventate amiche, posso dire di essere di casa, anche se riusciamo a vederci raramente. I suoi figli mi chiamano nonna…
Altri casi che abbiamo deciso di sostenere non hanno avuto esito altrettanto positivo. E diversi altri sono aperti e spesso di difficile soluzione. Conoscendoli abbastanza nel dettaglio, ci si rende conto come ognuno sia diverso, molto diverso, nonostante un’apparente uniformità intorno a alcuni cliché. Vi si intrecciano questioni economiche, di lavoro, problemi abitativi, difficoltà familiari e di salute. Ma spesso non si riuscirebbe a comprenderne la dinamica senza considerare variabili intervenienti –diremmo noi – più difficili da individuare, talvolta sorprendenti, legate a caratteristiche dell’identità etnico-culturale o al timore di pregiudicare la propria reputazione sociale. Sono casi che costituiscono una sfida al nostro modo profondo di sentire, di immaginare ciò che è razionale o irrazionale, e che è facile inducano a scivolare inavvertitamente nel pregiudizio nonostante tutte le buone intenzioni. …Come credente dico che occorre molto pregare per avere mente e cuore disponibili e aperti per capire. Come studiosa dico che occorre anche qui molta ricerca basata sull’osservazione partecipante, di tipo etnografico. Meglio l’una cosa e l’altra!
Ma a me colpiscono inevitabilmente in modo particolarmente vivo le dinamiche legate al problema del lavoro. L’attività che prestiamo al centro di ascolto permette di avere sott’occhio un ventaglio piuttosto ampio di posizioni, soprattutto di quelle deboli e difficili da tutelare, per quanto siano spesso di grande rilevanza sul piano sociale e per il funzionamento delle imprese: colf e badanti, addetti alle pulizie nei condomini o negli uffici, magazzinieri e addetti al carico/scarico delle merci, personale di vigilanza, rider, addetti alle mense, baristi, camerieri, personale non qualificato in edilizia, e altri ancora. Per lo più si tratta di attività con contratti temporanei, quando non in nero, che in molti casi fanno capo a cooperative. Da noi vengono quando il lavoro lo perdono o quando sono stati oggetto di ingiustizie, di soprusi: cooperative che spariscono senza pagare gli ultimi mesi, licenziamenti ingiustificati, contratti di lavoro in cui le ore regolari sono poche e quelle in nero tante… Quando è necessario noi li mandiamo al sindacato: se ci riusciamo, però, perché molte volte hanno paura di essere così messi nei guai, di esser dopo additati come persone di cui non ci si può fidare e se sono immigrati temono che diventi una ragione in più per discriminarli. Nonostante tutto però, come già dicevo, in genere chi ha un lavoro ne è soddisfatto, talvolta fiero. Non sono i discorsi disfattisti sulla precarietà e la fine della centralità del lavoro a prevalere. Si può anzi toccare con mano come le riforme in senso universalistico degli ammortizzatori sociali della metà di questo decennio abbiano avuto un’efficacia pur modesta assai diffusa, dal momento che tutti coloro cui è capitato di perdere il lavoro, anche un lavoro di relativamente breve durata, purché dichiarato, parlano con naturalezza delle indennità di disoccupazione cui hanno avuto diritto. Un tempo non sarebbe stato così. Da questo particolare punto di osservazione, mi sembra di poter dire che viene inaspettatamente riproposta la centralità, e non la marginalità, del lavoro nell’esperienza degli individui, uomini e donne. Non è più, se non per pochi, lavoro nel manifatturiero. Ma è lavoro, soprattutto è lavoro nei servizi, che, come sottolineava Talcott Parsons cinquant’anni fa, è attività relazionale, un “gioco tra persone”, anziché come nel manifatturiero “gioco contro il dato naturale”: è lavoro con altre persone, per altre persone, su altre persone o le loro cose, in cui diviene cruciale la dinamica delle relazioni sociali. Le implicazioni sul significato soggettivo del lavoro e su come regolarlo a mio avviso sono notevoli e non sono state ancora sufficientemente comprese. E questo è uno dei punti importanti su cui riflettere, anche da parte del sindacato: non puoi pensare che le attese e la logica di comportamento di una commessa siano le stesse di un’operaia in un reparto di produzione…
Tra l’altro questo lo dicevi già nel 1990 quando hai scritto “Al posto del conflitto” che è diventato un caposaldo negli studi sul terziario.
…Mi rendo conto che dopo la ricerca con Pizzorno praticamente non ho più studiato il manifatturiero, se non molto occasionalmente o di sfuggita. Non perché non sia importante… Ma perché mi sembrava che tutti avessero in mente il mondo del manifatturiero come se fosse il mondo del lavoro: certo è molto importante, ma non è tutto, anzi, ormai quantitativamente si è molto ridimensionato. Bisogna ragionare sui servizi, nel senso molto lato del termine, così come bisogna ragionare sui contratti non tradizionali: occorre misurarsi con le tematiche che non sono quelle su cui si era fondato il modello di produzione fordista. Su questo sono d’accordo con Pietro Ichino: bisogna rivedere il diritto del lavoro. Il diritto del lavoro va re-immaginato. Si era modellato sulla forma dell’assunzione a tempo indeterminato che occorreva allora alla grande industria manifatturiera. Per lungo tempo aveva un senso, era necessario che fosse così. Nella letteratura specie di tipo anglosassone che avevamo studiato per la ricerca sulle New forms of employment che prima ho ricordato, emergeva chiaramente però come in precedenza, prima del successo della produzione di massa nella grande impresa manifatturiera, lavorare a tempo indeterminato presso una stessa azienda non fosse affatto il modo tipico di lavorare. Anzi, un po’ ironicamente, all’inizio questo modello era visto con sospetto soprattutto dai sindacati, che lo consideravano una forma di asservimento del lavoratore, una limitazione della sua libertà di movimento e di scelta… Credo in effetti che ci sia molto da riflettere, molto da svelare dietro a ciò che appare ovvio, per capire meglio e fornire elementi in vista di un necessario cambiamento di prospettiva e di intervento politico e sindacale. Talvolta penso che mi piacerebbe farlo, almeno provarci, sapendo che è un lavoro che non finisce mai e per questo è appassionante… C’è chi mi dice che alla mia età potrei pensare a altro, dedicarmi anche di più all’attività di volontariato che è ormai così importante per me. E però è proprio l’impegno con chi ha più difficoltà che continuamente mi ripropone la necessità di studiare ancora: questo impegno, che pure mi dà tanto, non è (ancora?…) divenuto un’alternativa, anzi… In ogni caso mi sembra che si debba con determinazione continuare a seguire delle piste nuove di ricerca sul tema del lavoro. Avrei in mente tante cose che vorrei approfondire ancora…
Noi ci aspettiamo proprio questo: che segua i nuovi ambiti di ricerca che hai in mente, magari in un libro sul metodo perché hai raccontato molte cose interessanti che potrebbero essere utili a tutti noi.
Devo ammettere che spesso penso di scrivere un libro sul tema della regolazione del lavoro, che è divenuto il mio tema. Non un libro sulle relazioni industriali come intese tradizionalmente, un libro sulle relazioni industriali nel modo in cui le intendo io. E vedendone diversi aspetti, diverse prospettive; e lasciando sicuramente molti spazi aperti, molti interrogativi da consegnare a altri, ai giovani. In fondo sarebbe come proporre un programma di ricerca. Questo a volte penso che lo potrei fare.
E noi ci contiamo molto! Grazie di cuore Ida!