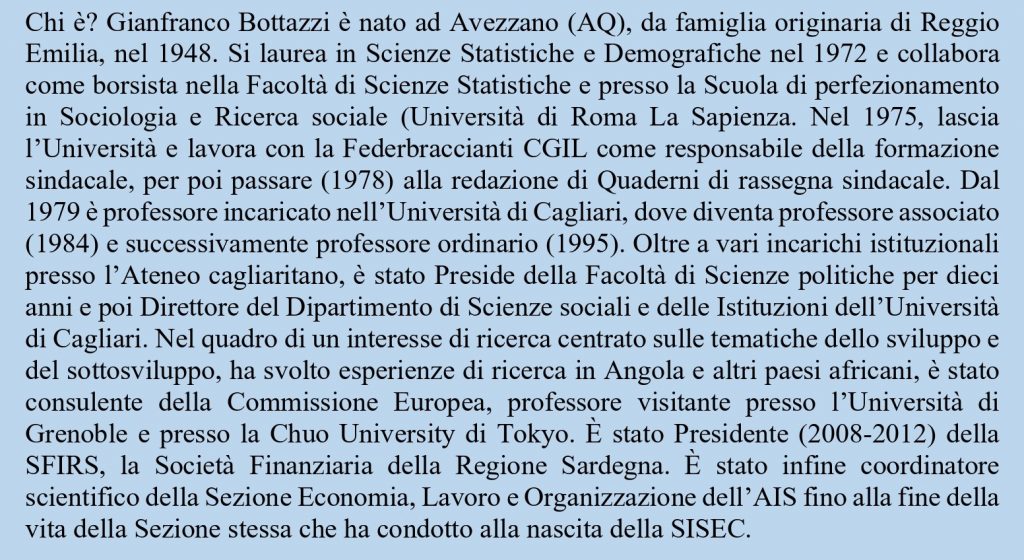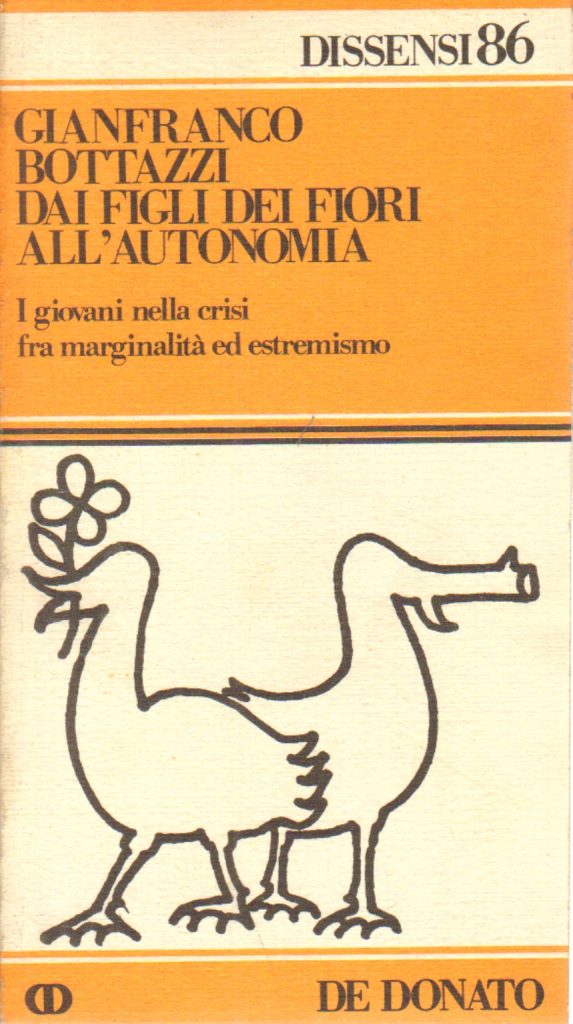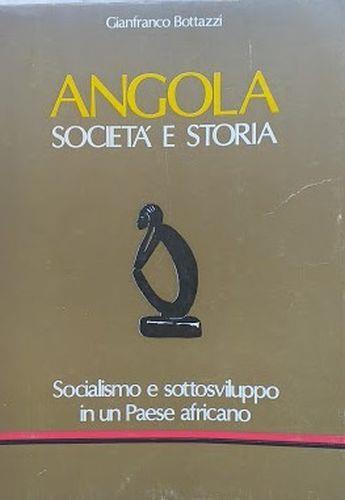In questa intervista raccolta da Marco Zurru e Antonello Podda, Gianfranco Bottazzi racconta un pezzo della sua biografia personale e professionale, dall’essere figlio di migranti, al suo lavoro nel sindacato dei braccianti agricoli fino alla sua esperienza di vita e lavoro in Africa, tutte esperienze che fondendosi, hanno contributo a consolidare l’interesse di ricerca e di studio per i temi dello sviluppo, il suo principale, anche se non unico, tema di ricerca. La passione per la ricerca l’ha portato infine a raggiungere la Sardegna, dove nell’Università di Cagliari ha costruito il suo percorso accademico.
Raccontaci del tuo percorso formativo, Prima dell’Accademia hai avuto ruoli di responsabilità in CGIL e nel settore formazione dell’Eni.
Il mio percorso formativo è stato quello abbastanza tipico di chi, come me, proveniva dagli strati sociali più bassi. In questo senso, emblematico della grande mobilità verticale che si realizzò nel dopoguerra in Italia. Poiché la continuazione degli studi era comunque finalizzata ad un lavoro e non certamente all’università, ho fatto l’Istituto Tecnico. Date le condizioni della mia famiglia, continuare a studiare fu una scommessa, e la scelta cadde su Statistica, perché si trattava – tra quelle che all’epoca permettevano l’accesso ai diplomati degli Istituti Tecnici – di quella che mi sembrava più vicina ai miei interessi. Ho fatto diversi lavori durante gli studi universitari e mi sono laureato nel 1972, praticamente in corso. Quasi subito, ottenni prima una collaborazione di ricerca, pagata, e poi una borsa di studio del CNR. Questo, grazie anche al professore con cui avevo fatto la tesi, Francesco P. Cerase (che da quegli anni è stato un maestro e un amico). Ho avuto una seconda borsa di studio e la frequentazione della scuola di Perfezionamento in Sociologia e Ricerca sociale – che era presso la Facoltà di Statistica – mi ha indirizzato decisamente verso le scienze sociali e la sociologia economica in particolare (ho sempre avuto un grande interesse anche per l’economia politica). Cominciai in quegli anni, in modo molto autodidatta, a recuperare lo svantaggio di un percorso formativo alquanto atipico. Poiché la borsa mi lasciava abbastanza libero, ho studiato sistematicamente filosofia e i classici della sociologia, mentre gli studi statistici mi avevano dato una solida base e soprattutto una logica quantitativa e metodologica. Storia e letteratura erano invece passioni di lunga data. Oltre alla borsa di studio, grazie anche alle mie competenze statistiche, mi sono capitate diverse occasioni di lavoro professionale, come ricercatore, in alcune società di ricerca private o, occasionalmente, per enti pubblici o parapubblici.
Gianfranco Bottazzi, Francesco Cerase e Francesco Chiarello (2002)
Sono arrivato all’università, alla Sapienza di Roma, nel 1967, quindi ho vissuto in pieno il Sessantotto studentesco. Ero già abbastanza politicizzato a sinistra e il movimento studentesco, le assemblee, i dibattiti, nonché lo studio (il mio primo articolo era su Marx e il ceto medio), mi hanno naturalmente fatto venire in contatto con il sindacato, la CGIL in particolare, dati anche i miei orientamenti politici. Cominciai a collaborare con la Scuola di Formazione della CGIL di Ariccia, pubblicai alcuni scritti che ebbero una buona diffusione nel sindacato. Mi appassionai molto a questa attività che era di ricerca, ma anche didattica. Quando mi proposero di fare il responsabile della formazione della Federbraccianti CGIL accettai di buon grado. Mi sarei occupato anche di organizzazione e poi della redazione del mensile della Federbraccianti. É stata un’esperienza molto intensa, dalla quale ho imparato molto, anche e soprattutto dal punto di vista dei rapporti umani. Ho inoltre acquisito una conoscenza diffusa del nostro Mezzogiorno, visto che ho girato molto e conosciuto miriadi di situazioni e di persone (tra l’altro, venni per la prima volta in Sardegna, proprio per un Congresso sindacale). Nel frattempo avevo lasciato la Facoltà di Statistica dell’Università di Roma. Ricordo che il Preside, prof. Castellano, mi disse: “Bottazzi, non le chiediamo niente, perché se ne vuole andare?”. Probabilmente ero piuttosto rigido e mi sarei sentito in colpa se avessi percepito una retribuzione per qualcosa che in realtà non facevo. Fu così che per quattro anni feci il sindacalista.
Per quanto molto coinvolgente, tuttavia, non era quello che avrei voluto fare nella vita. L’esperienza della borsa di studio, mi aveva fatto conoscere dall’interno il mondo dell’università e della ricerca e alimentato un sogno che solo qualche anno prima non avrei mai sognato perché considerato impossibile, quello di diventare ricercatore e insegnante. Dopo un anno passato nella redazione dei Quaderni di Rassegna Sindacale – un mensile della CGIL apprezzato anche dal mondo della ricerca universitaria – nel 1978 lasciai il sindacato e ripresi a lavorare come ricercatore presso centri di ricerca come l’Arpes e il Cles di Roma, per i quali mi occupavo soprattutto di sociologia dell’organizzazione. Non perdevo d’occhio nel frattempo il mondo dell’università: ripresi i contatti e continuai, con fatica, a scrivere e a pubblicare (la “gavetta”, all’epoca, consisteva soprattutto nel fare recensioni e brevi note per le riviste accademiche di riferimento delle varie “scuole”).
E le tue esperienze all’estero?
Fu in quella fase che, come Arpes, entrai a far parte di un gruppo di lavoro dell’Italsider che faceva assistenza tecnica al settore siderurgico dell’Angola, ex colonia portoghese divenuta indipendente nel 1974. Avrei dovuto occuparmi, assieme a tecnici e ingegneri esperti nelle attività siderurgiche, del riavvio e messa in produzione di una acciaieria e laminatoio che era stata quasi del tutto abbandonata dagli operai e tecnici portoghesi che avevano in fretta e furia abbandonato l’Angola dopo l’indipendenza. Il mio ambito era l’organizzazione dell’impresa – la gestione del personale in primo luogo – e la predisposizione di un piano di formazione per operai e tecnici angolani della Siderurgia Nacional (a Luanda) e di un’altra impresa che produceva tubi in acciaio. Dopo la prima esperienza sul campo (1978), tornai più volte in Angola, questa volta con altre società che facevano cooperazione tecnica con l’Angola, tra le quali la Comerint del gruppo ENI, con la quale insegnai per sei mesi in un corso para universitario per dirigenti di impresa. È indubbiamente stata un’esperienza che mi ha parecchio segnato. Da un lato, dal punto di vista professionale, mentre in Italia era in pieno sviluppo il dibattito sulla fine del taylorismo e sulla “nuova” organizzazione del lavoro, fu particolarmente intrigante misurarsi con un contesto decisamente arretrato, per cui appresi a mettere da parte le convinzioni troppo ideologiche e un po’ etnocentriche con le quali ero partito. Anche l’insegnamento a persone spesso fortemente carenti di formazione di base è stato un esercizio estremamente stimolante, poiché spesso bisognava improvvisare con quello che si aveva in testa, non avendo a disposizione biblioteche né materiale di studio. Fu molto gratificante, a 30 anni, scoprire di avere “cose” in testa. Inoltre, ho imparato il portoghese, lingua che parlo con un leggero accento angolano. D’altro lato, l’Angola – come tutta l’Africa d’altra parte – mi ha fatto scoprire la straordinaria umanità di un popolo gentile, sorridente, accogliente, pur nelle privazioni e nelle difficoltà di una fase nella quale continuava una guerra civile in gran parte alimentata dal Sud-Africa per destabilizzare la giovane indipendenza angolana. L’ultima missione in Angola fu nel 1982. Grazie anche ai contatti e alle conoscenze nel frattempo maturate, avevo ricevuto diverse proposte, anche dal governo angolano, alcune decisamente allettanti, per continuare l’esperienza in quel paese.
I casi della vita mi hanno spinto in un’altra direzione, quella di Cagliari. Infatti, nel 1979, seppi da amici che a Cagliari avevano bandito un incarico annuale per Sociologia dell’organizzazione. Avevo scritto qualche articolo sfruttando le esperienze di ricerca in Angola e in alcuni contesti organizzativi italiani. Avevo anche un volume che trattava, tra l’altro, delle tematiche dei giovani e del mercato del lavoro.
Inoltre avevo conosciuto Cagliari come sindacalista e mi era parecchio piaciuta. Mi attribuirono l’incarico. La retribuzione era decisamente più bassa di quello che avrei avuto all’INPS, dove avevo vinto un concorso, o all’ENI, con il quale ero in trattativa per una possibile assunzione. Ma era ciò che volevo fare, era il modo per rientrare all’università. Nel frattempo avevo messo su famiglia e, nel 1982, era nato mio figlio primogenito. Non potevo continuare con l’Angola e, all’epoca, non c’erano le condizioni per portare la famiglia in Angola. Ho passato alcuni anni impegnativi, viaggiando a settimane alterne da Roma, dove abitavo, a Cagliari. La Facoltà di Scienze Politiche era appena nata, c’erano pochi studenti, ma molto motivati, le lezioni erano pochissimo affollate e cominciai da subito a dare alcune tesi di laurea. I colleghi erano ospitali e gentili, insomma una situazione gradevole. Ero però obbligato a fare attività extra-universitaria – che all’epoca, come incaricato, era perfettamente compatibile – anche per mantenere me e la famiglia. Feci molte esperienze interessanti in quel periodo. Tra queste, sono stato consulente (1985) della Commissione Europea per gli studi preliminari relativi al Portogallo, in vista dell’adesione europea di Spagna e Portogallo. Grazie all’esperienza internazionale, ho inoltre svolto missioni di ricerca in Mozambico, in Algeria, a Mauritius. Nel 1983, ero riuscito a pubblicare un libro sull’Angola – lo sentivo quasi come un dovere – ed ebbe buone recensioni nelle riviste internazionali specializzate.
Intanto continuavo con l’incarico annuale di insegnamento. Ebbi fortuna e, nel 1984, passai il concorso per associati. Va detto che si è trattato di un concorso facile per chi era in quel momento sul treno dell’università, una sorta di giudizio di idoneità per tutti coloro che avevano un incarico di insegnamento, insomma più una sanatoria che un vero concorso. Con la certezza di un lavoro, cominciai a ripianificare la mia vita. Passai gran parte del 1986 in Francia, a Grenoble, grazie a un invito di alcuni colleghi francesi che avevo conosciuto nell’ambito di una ricerca sui trasferimenti di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo, e soprattutto grazie ad una sostanziosa borsa di studio del Formez. A quel punto, d’accordo con mia moglie, prendemmo la decisione di trasferirci a Cagliari. Avevo maturato un ottimo rapporto con la Sardegna e con i Sardi, avevo amici affettuosi e simpatici. E soprattutto ero e sono convinto che se si vuole costruire qualcosa dal punto di vista della didattica e della ricerca è importante vivere nel posto dove si insegna. Per quanto io fossi molto presente a Cagliari, sarei stato sempre comunque un flying professor, che il venerdì prendeva il suo aereo per tornare a casa. Così nel 1987 presi casa a Cagliari, giusto in tempo per far nascere la mia secondogenita. Ricordo quegli anni come anni pesanti, soprattutto per il carico didattico: per tenere attivati insegnamenti di Sociologia, ci furono anni in cui ho avuto titolarità di quattro o cinque insegnamenti (che naturalmente potevo coprire effettivamente solo in parte), e ogni anno dovevo darmi da fare per trovare qualche collega di qualche parte d’Italia ben disposto a svolgere una qualche supplenza. Evidentemente avevo del tutto abbandonato gli impegni di ricerca professionali. Intanto, continuavo a studiare e a scrivere, fino al 1995, quando ho vinto il Concorso per Ordinario. L’anno seguente sono stato eletto Preside della Facoltà di Scienze politiche.
Come si è sviluppato il tuo avvicinamento alla sociologia e quanto hanno influito le esperienze professionali pregresse?
Ho scoperto la sociologia con gli esami universitari. La Facoltà di Statistica aveva due indirizzi, demografico e attuariale. Nel primo, che è quello che scelsi, vi era una manciata di insegnamenti sociologici, che finirono tutti nel mio piano di studi. Devo dire che ero fortemente attratto da tutte le scienze sociali, e confesso che finii per puntare sulla sociologia per ragioni contingenti, perché erano disponibili borse di studio del CNR. Successivamente, praticai in maniera sistematica la sociologia economica. Anche per il mio coinvolgimento politico, ero molto attratto dalla questione della struttura di classe, come si diceva con terminologia marxista, ed ero affascinato da Marx che lessi e studiai in profondità. Ma scoprii anche Weber e Durkheim e maturai una vera passione per Veblen. Naturalmente, come molti in quel periodo, avevo un atteggiamento che finiva per essere abbastanza settario, si leggeva molto a senso unico. Ci misi anni ad avvicinarmi senza pregiudizi a Parsons. Ma mi convinsi abbastanza rapidamente che una “sociologia marxista” non aveva senso e che – qui fu decisivo Weber – solo la avalutatività poteva consentire alla riflessione sociologica di essere scientifica.
Naturalmente, le prime esperienze di lavoro professionale mi confermarono nel ruolo di sociologo, visto che, a parte la parentesi sindacale, si trattava di ricerche o di consulenze che, quasi sempre, avevano un deciso contenuto sociologico, o di tipo organizzativo o legato alle questioni del mercato del lavoro. Per mia fortuna, molte di quelle esperienze di ricerca mi consentirono di scrivere articoli e saggi.
Sembra che il tema dello sviluppo locale è sempre stato al centro dei tuoi interessi e dei tuoi lavori.
Dovrei rispondere seccamente “no”, poiché fino alla fine degli anni Ottanta nessuno usava l’espressione “sviluppo locale”. Ma anche rispondere “sì”, perché, come dirò, il tema dello sviluppo è di fatto un filo rosso che ha percorso gran parte delle mie curiosità di ricerca. E, contemporaneamente, anche per l’esperienza occasionale di studiare contesti territoriali in varie parti d’Italia (in Calabria e in Toscana in particolare), la dimensione dello sviluppo a scala locale mi ha sempre intrigato. Così, quando esplose quella che divenne una vera e propria moda, con la Commissione Europea che, auspice l’allora presidente Delors, lanciò il “Libro bianco”, una serie di programmi che andavano dai cosiddetti “giacimenti di occupazione” a livello territoriale ai vari interventi di promozione dello sviluppo a scala territoriale ridotta. Per alcuni anni, anche come Dipartimento, partecipammo a diverse ricerche sia promosse da organismi come il Formez, dalla Commissione Europea, dalla Regione Sardegna. 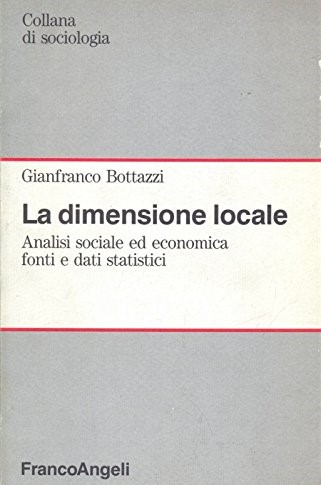 Con quest’ultima, coordinai il gruppo di esperti che predispose una legge regionale (la 37 del 1998) per le “Iniziative locali per l’occupazione e lo sviluppo”. Partecipammo anche a vari PRIN sempre sul tema, in generale, dello sviluppo locale e della programmazione territoriale. Nel 1992, scrissi La dimensione locale, una sorta di manuale sui dati e sugli indicatori che potevano utilmente essere utilizzati nelle analisi di contesti territoriali limitati. Lo ricordo con piacere perché ebbe una buona diffusione e credo sia stato uno strumento utile soprattutto per i ricercatori più giovani.
Con quest’ultima, coordinai il gruppo di esperti che predispose una legge regionale (la 37 del 1998) per le “Iniziative locali per l’occupazione e lo sviluppo”. Partecipammo anche a vari PRIN sempre sul tema, in generale, dello sviluppo locale e della programmazione territoriale. Nel 1992, scrissi La dimensione locale, una sorta di manuale sui dati e sugli indicatori che potevano utilmente essere utilizzati nelle analisi di contesti territoriali limitati. Lo ricordo con piacere perché ebbe una buona diffusione e credo sia stato uno strumento utile soprattutto per i ricercatori più giovani.
Per alcuni anni pubblicai quasi esclusivamente sullo sviluppo locale, anche con i contributi di altri colleghi ricercatori del Dipartimento, a partire dall’esperienza della Sardegna, ma non solo. Avevo mantenuto regolari scambi – anche per ragioni linguistiche – con il mondo della ricerca francese, portoghese, spagnolo e con la Commissione Europea. Ero spesso invitato a Convegni e Seminari. Riuscii a organizzare, grazie al contributo della Commissione stessa, una ricerca transnazionale che metteva assieme ricercatori delle università di Siviglia, Lisbona, Montpellier, Atene e Cagliari. Fu un’esperienza impegnativa ma anche gratificante, che si concluse con un Convegno internazionale a Cagliari e con una pubblicazione (Emploi et développement en Europe du Sud) che fu molto apprezzata nelle diverse sedi e a Bruxelles.  Altrettanto significative furono le analoghe esperienze transnazionali condotte con la partecipazione delle centrali sindacali e delle università di Sardegna, Rhône-Alpes e Estremadura. Al di là delle contingenze politiche, era già chiaro, in quel momento, che il contesto dei Paesi meridionali in Europa era abbastanza diverso, e con maggiori difficoltà rispetto ai Paesi del Centro e Nord Europa. Ricordo che in una di queste ricerche-azione descrivemmo un’esperienza sarda molto interessante, quella di Sa Corona Arrubia, un gruppo di Comuni che, anticipando di molto i tempi, si erano consorziati per la valorizzazione turistica del territorio. Il caso fu ripreso dalla Commissione Europea come “buona pratica” e fatto conoscere in tutta Europa.
Altrettanto significative furono le analoghe esperienze transnazionali condotte con la partecipazione delle centrali sindacali e delle università di Sardegna, Rhône-Alpes e Estremadura. Al di là delle contingenze politiche, era già chiaro, in quel momento, che il contesto dei Paesi meridionali in Europa era abbastanza diverso, e con maggiori difficoltà rispetto ai Paesi del Centro e Nord Europa. Ricordo che in una di queste ricerche-azione descrivemmo un’esperienza sarda molto interessante, quella di Sa Corona Arrubia, un gruppo di Comuni che, anticipando di molto i tempi, si erano consorziati per la valorizzazione turistica del territorio. Il caso fu ripreso dalla Commissione Europea come “buona pratica” e fatto conoscere in tutta Europa.
Quali reputi le tue esperienze internazionali di ricerca più significative?
Quelle di cui ho appena detto sono state indubbiamente molto significative. Ma mi piace ricordare che ho sviluppato da subito un marcato interesse per le esperienze internazionali. Uno dei miei primi incarichi – mi ero laureato da poco – fu una missione in Jugoslavia, Grecia e Turchia, per raccogliere documentazione e realizzare interviste nell’ambito di una ricerca sulle questioni ambientali nel Mediterraneo (nel 1973, per Tecneco, una società del gruppo ENI). Ero evidentemente molto inesperto, era la prima volta che prendevo un aereo ma, barcamenandomi tra inglese e francese, riuscii comunque a fare quello che mi veniva chiesto. Anche con il sindacato mi furono assegnati spesso compiti di contatto con le delegazioni estere, anche, probabilmente, per le mie conoscenze linguistiche. Ma è soprattutto con la lunga esperienza in Angola che ho acquisito un sistematico interesse per le analisi comparative, soprattutto in contesti extra-europei. Interesse che, anche per vicende familiari e personali, non potei coltivare con la continuità che avrei voluto. Molto importante è stata anche la collaborazione con le istituzioni europee, con le quali, devo sottolineare, è sempre stata importante una dimensione che ha sempre caratterizzato la mia voglia di fare ricerca. Ossia, a lato della attività conoscitiva vera e propria l’individuazione di percorsi di azione possibili. Non a caso, i Rapporti di ricerca per la Commissione, o per altre Agenzie europee (come la Fondazione di Dublino per il miglioramento delle condizioni di lavoro), si concludono sempre con “raccomandazioni” relativamente al cosa fare. Nella seconda parte del mio percorso di ricerca ha avuto maggior peso la tradizionale ricerca accademica. A questo proposito, un periodo importante è stato il semestre trascorso a Grenoble come professeur visitant presso l’IREP-Développement dell’Università di Grenoble (1986), a seguito del quale sono sistematicamente entrato in reti di ricerca francesi e multinazionali. La ricerca transnazionale Emploi et développement en Europe du Sud di cui ho parlato in precedenza è nata anche da questa mia frequentazione.
Merita di essere menzionato anche il periodo di visiting professor presso la Chuo University a Tokyo (2001) e, negli ultimi anni, la collaborazione con una università brasiliana (FIB) di Salvador de Bahia, sul tema dello sviluppo locale in una regione dello Stato di Bahia (Valença).
“Sviluppo e sottosviluppo” prima, e poi “Sociologia dello sviluppo” pubblicato presso Laterza ci porta sul tema della didattica. Quanto è stato rilevante questa dimensione nella tua carriera accademica?
È stata non solo rilevante, ma centrale. Ho sempre amato moltissimo il rapporto con gli studenti e la didattica è sempre stata per me una cosa che ho fatto con piacere, con passione, anche quando, in alcuni anni, il carico didattico era veramente massacrante. Ho sempre pensato che dedicare energie e attenzione alla didattica fosse il principale dovere di un professore universitario. Così come impegnarsi a proporre percorsi formativi adeguati e rispondenti alle esigenze del territorio nel quale l’università opera. Da questo punto di vista, per esempio, ho molto creduto e mi sono molto impegnato con la sede distaccata della Università di Cagliari a Nuoro. Le istituzioni locali nuoresi hanno molto creduto nella possibilità di una sede universitaria autonoma nel centro della Sardegna. Anch’io ho creduto nel progetto e per anni ho insegnato nei corsi di Nuoro e ho diretto – prima come Preside, poi come Presidente di Corso di laurea – il nostro corso di laurea. Mi sono anche impegnato molto nel contesto sociale e culturale della città e mi è restato un affetto profondo per la città e per le persone che mi hanno aiutato nell’impegno.
Passando allo “sviluppo”, ho sostenuto, nei primi anni Settanta, l’esame di “Sociologia dei paesi in via di sviluppo”. Da quel momento, al di là di interessi contingenti di ricerca – svolgendo attività professionale come ricercatore, evidentemente era a volte il committente che stabiliva l’oggetto della ricerca – lo sviluppo e il suo opposto sotto-sviluppo è stato una tema costante del mio lavoro intellettuale. Ho continuato a documentarmi, a studiare, con qualche articolo e saggio che affrontava aspetti specifici del tema. Mi accorsi, a un certo punto, che avevo accumulato una notevole quantità di materiale, decine e decine di quaderni che, secondo le mie abitudini, raccoglievano schede, sintesi, appunti di lettura. Così, nell’estate del 2005 – mi ricordo bene – misi mano a scrivere qualcosa che ripercorresse la parabola della questione “sviluppo” dal secondo dopo-guerra. All’inizio non pensavo ad un manuale, ma piuttosto a esplorare un tema sul quale si sono misurate le scienze sociali per oltre settanta anni, mescolando dibattito teorico e aspirazioni politiche in un mondo che sembrava divenuto sempre più piccolo e interconnesso. Il primo volume che ho dedicato allo sviluppo (Sviluppo e sottosviluppo, 2007) aveva come sottotitolo Idee, teorie, speranze e delusioni, proprio a sottolineare questo aspetto.
Il volume, un testo corposo di oltre 400 pagine, nel quale ho riversato trent’anni di riflessioni accumulate, è uscito con una casa editrice sarda (Aìsara) appena nata e con grandi ambizioni. Purtroppo, dopo nemmeno un anno dalla nascita, la casa editrice ha avuto problemi societari ed ha chiuso. Anche per questo ho accettato l’invito di Laterza per una edizione che avesse però limiti “ponderali” più ristretti e più pensata come un vero e proprio manuale. Ho molto pensato, in questo caso, all’utilizzazione didattica e mi sono sforzato di rendere più chiara e lineare possibile l’esposizione. Credo, almeno in parte, di esserci riuscito. Devo confessare che, mentre la vita accademica nel suo complesso mi ha lasciato anche qualche amarezza, una gioia profonda mi viene tutte le volte che incontro studenti che, anni dopo il corso che avevano frequentato, dei quali spesso non ricordo ovviamente il nome, mi salutano festosamente. Ancora di più questo avviene per le centinaia di tesi che ho seguito a Cagliari. Continuo a ricevere mail di persone che si sono laureate con me e, con molti di loro, intrattengo contatti regolari.
Ci hai detto come sei arrivato in Sardegna, ma l’isola ha influenzato il tuo percorso di ricerca?
Ho ricordato più sopra che, di fatto, sono arrivato in Sardegna per caso, perché c’era qui un’occasione per riprendere quel percorso universitario che avevo interrotto per fare altre cose. Appena arrivato, pensavo di restare un paio d’anni e, possibilmente, rientrare a Roma, che non amavo particolarmente, ma a Roma avevo scampoli di famiglia e naturalmente amici. Il fatto che alcuni colleghi sociologi andassero via da Cagliari e la voglia di tenere in piedi, nella Facoltà di Scienze politiche, un indirizzo di studi politico-sociale che nel frattempo era stato comunque avviato, mi spinse a riflettere sulla possibilità di trasferirmi in Sardegna, per lavorare all’ipotesi di un rafforzamento della ricerca sociale nel contesto cagliaritano. Quando decidemmo, con mia moglie, del trasloco, ero diventato professore associato, avevo quindi una prospettiva futura abbastanza certa. Riuscii ad accendere un mutuo e comprammo una casa. I colleghi di Cagliari, che mi avevano molto ben accolto, furono ancora più gentili dopo il mio trasloco, avevano apprezzato la mia scelta. Avevo un’esperienza di vita di relativo nomadismo (origine emiliane, nato in Abruzzo, vissuto in Molise e poi a Roma, seguendo le peripezie di mio padre sempre alla ricerca di qualche prospettiva di lavoro; ho passato lunghi periodi in giro per l’Italia e per il mondo). Non mi ero prefisso nessun limite a restare in Sardegna. Così, anno dopo anno, ho sempre più pensato che la Sardegna fosse la mia terra, anche perché era nel frattempo molto aumentato il mio coinvolgimento nel dibattito culturale e politico isolano e perché più conoscevo la Sardegna e i Sardi, più mi sentivo “sardo”.
Una parte importante della mia ricerca ha riguardato la Sardegna, come, d’altra parte, la maggior parte delle centinaia di tesi che ho assegnato e discusso hanno riguardato questa o quell’area dell’Isola, questo o quel problema sardo. Conoscevo bene, come ho detto, il Mezzogiorno, e la prima cosa di cui fui consapevole fu che la Sardegna, pur essendo spesso ricompresa nello stesso Mezzogiorno e pur avendo evidentemente qualche punto di somiglianza, “non è Mezzogiorno”: è una realtà sociale, culturale, economica, con una sua forte specificità. Ho scritto varie cose relativamente alla regione, ma probabilmente il lavoro che rappresenta un po’ una sintesi delle mie riflessioni in proposito è un saggio del 1999 (Eppur si muove! Saggio sulle peculiarità del processo di modernizzazione in Sardegna), che mi ha fatto conoscere anche al di fuori dell’università.
Con l’amico e collega Pippo Puggioni, statistico, avevamo lavorato già dai primi anni Ottanta sui primi flussi di immigrati che arrivavano in Sardegna. Sempre con Puggioni, una decina di anni fa, abbiamo svolto, per conto della Regione (Centro regionale di Programmazione), una ricerca sui fenomeni di spopolamento che interessano particolarmente la parte interna dell’isola. Redigemmo, con Puggioni, un rapporto di ricerca, molto documentato, con dati per ognuno dei 377 Comuni sardi, che la Regione mise a disposizione nel suo sito Internet. Avevo affrontato già anni prima lo stesso problema, quando avevo dato un’ampia collaborazione ad una “Associazione dei piccoli Comuni”, preoccupata da un fenomeno che, già dagli anni Novanta del Novecento, appariva evidente e grave. Ma il rapporto scritto con Puggioni mi ha sicuramente fatto conoscere al di là dell’università.
Gianfranco Bottazzi e Pippo Puggioni, 2002, Cagliari.
Sappiamo che hai avuto diversi incarichi istituzionali extra accademici di rilievo
In realtà non moltissimi. Quando mi sono trasferito in Sardegna con la famiglia, ero già abbastanza conosciuto negli ambienti del sindacato e della sinistra ed ho continuato a dare un mio piccolo contributo al dibattito politico e sindacale. Avendo deciso di fare ricerca e università a tempo pieno, ho sempre rifiutato ogni incarico, candidatura o impegno istituzionale – e non sono mancate le proposte – che rischiasse di distrarmi dall’obiettivo che mi ero proposto. D’altra parte, ho sempre avuto molti impegni accademici di gestione che mi assorbivano già notevolmente. Come ho sopra detto, sono stato Preside della Facoltà di Scienze politiche per 10 anni, Direttore di Dipartimento, rappresentante in Senato e membro di varie Commissioni rettorali.
C’è stata però una occasione, durante la Giunta Regionale guidata da Soru, dal 2004 al 2009, che ho accettato, ed è stata la presidenza della SFIRS, ossia la finanziaria regionale sarda. È stato, da un lato, una sorta di riconoscimento della mia “sardizzazione”, e, dall’altro, ho accettato e vissuto l’esperienza come una sfida. Dopo aver scritto e parlato per anni su sviluppo e sottosviluppo si trattava di mettermi alla prova e vedere cosa sarei stato capace di fare. Sono stati anni di impegno molto duro (durante i quali ho continuato a fare i miei corsi), nei quali ho conosciuto i “poteri forti” regionali e nazionali, e sono riuscito a fronteggiare le diverse spinte che, da ogni parte, arrivano a chi maneggia una parte comunque importante della finanza regionale. Devo dire che, con grande fatica, sono riuscito a dare un ruolo alla SFIRS, prima obbligata a vivacchiare senza fare molto di strategico per lo sviluppo della Sardegna. La SFIRS era una Società per Azioni, a maggioranza posseduta dalla Regione Sardegna, ma con importanti partecipazioni di Banche di rilievo nazionale. Nella mia profonda convinzione che la sfera pubblica possa giocare un ruolo fondamentale per lo sviluppo, ho portato la SFIRS a misurarsi con alcuni nodi storici dello sviluppo sardo. Siamo andati molto avanti, ad esempio, nei rapporti con gli algerini della Sonatrach (l’Azienda di Stato per i petroli) per la costruzione di un gasdotto che attraversasse la Sardegna. Con la stessa Sonatrach avevo negoziato e fatto firmare una dichiarazione di intenti, nella quale SFIRS e Sonatrach si impegnavano a dar vita a una società mista – al 50% ciascuno – per la commercializzazione di una parte importante del gas arrivato in Sardegna. Ricordo che ricevetti telefonate dalla Regione Toscana, dalla Corsica e dalla Azienda Regionale per l’Energia della Regione Emilia-Romagna, per entrare nella società, o chiedendo condizioni di favore nell’acquisto del gas. Allo stesso modo, osando, ero riuscito a riportare in possesso della Regione Sardegna tutto il comprensorio della vecchia cartiera di Arbatax, compresi i macchinari. Ricordo anche che dopo sei mesi la SFIRS aveva ricuperato quasi la metà dei 15 milioni di Euro spesi, in parte vendendo dei terreni al gruppo Azimut, leader mondiale della cantieristica, che avrebbe dovuto insediarsi in Sardegna, in quello che avrebbe potuto diventare un polo per la nautica da diporto. Purtroppo, nel 2009 Soru perse le elezioni e io preferii dimettermi, visto che la mia nomina era stata di tipo politico. Con la nuova Giunta, di centro-destra, in pochi mesi la SFIRS tornò alla sua azione (per carità, utilissima!) di piccolissimo cabotaggio; successivamente furono estromesse le Banche azioniste ed è diventata un organo esclusivamente rispondente alla Giunta regionale. Quanto ai rapporti internazionali e con imprese interessate alla Sardegna, gira voce che quando esponenti della Sonatrach algerina sono giunti in visita alla Presidenza della Giunta, sono stati costretti a fare una lunga anticamera e poi liquidati con l’espressione “Non ci interessa!”.
Devo anche ricordare, con grande emozione, il ruolo di Coordinatore scientifico della Sezione ELO (Economia, Lavoro, Organizzazione) della Associazione Italiana di Sociologia. Sono stato eletto nel Convegno tenutosi a Cosenza nel settembre 2012 e, non senza qualche tormento, ho contribuito con il Direttivo uscente all’uscita della Sezione dall’AIS e alla nascita, nel 2015, della SISEC. Si è trattato di un’esperienza che mi ha veramente riempito di orgoglio. Essere eletto da molti di coloro che io ho considerato “maestri” è stata una grande soddisfazione professionale.
Gianfranco Bottazzi, 2019, cerimonia di Laurea della figlia Adele.
Vorresti dare qualche consiglio ai giovani ricercatori?
Per fare il ricercatore e poi il professore universitario credo sia necessario avere tanta passione, tanta determinazione e tanta pazienza. Bisogna avere un gusto per lo studio e la voglia di esplorare che riempia tutte le nostre giornate. E bisogna tener duro, continuare a scrivere – possibilmente cose intelligenti e sensate, anche se in quel dato momento non ci sono possibilità di concorso di alcun tipo. E quindi tanta pazienza, per aspettare che si apra la nostra occasione. Ovviamente, chi proviene da famiglie meno facoltose (un eufemismo per non dire “famiglie povere”) ha bisogno di ancora più passione, ancora più determinazione e ancora più pazienza. Ma può farcela.
Rispetto agli accessi alla carriera, credo che non sia cambiato così tanto il mondo universitario rispetto a 50 anni fa, per lo meno per le scienze sociali. Anche allora c’era comunque una lunga gavetta da fare, e il precariato esisteva anche allora. Poi come in tutte le cose del mondo c’è una componente “caso” o forse meglio “fortuna” che può rendere tutto più facile. Ma, alla fine, il mestiere della ricerca e dell’insegnamento è un mestiere coinvolgente, che ci arricchisce continuamente, che ci fa crescere. È un bel mestiere.