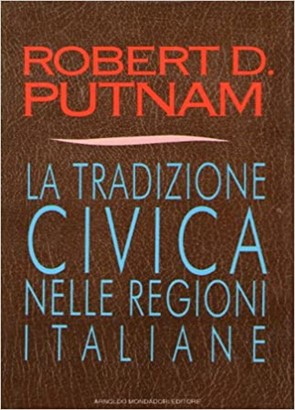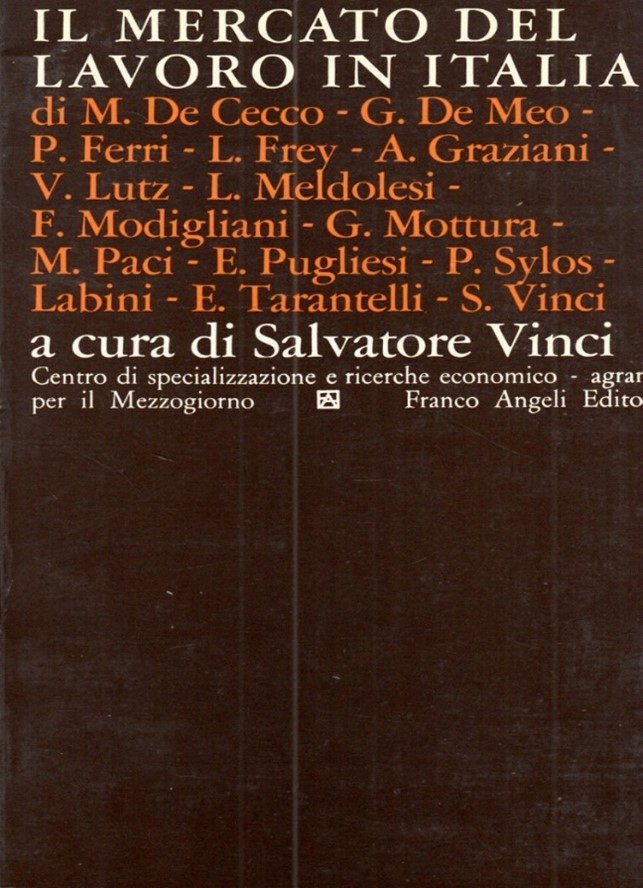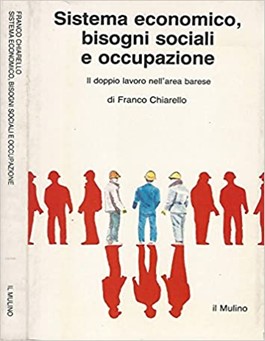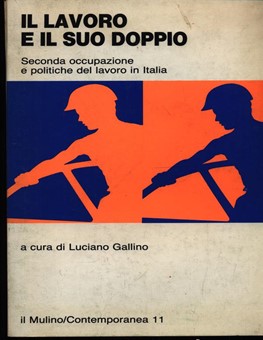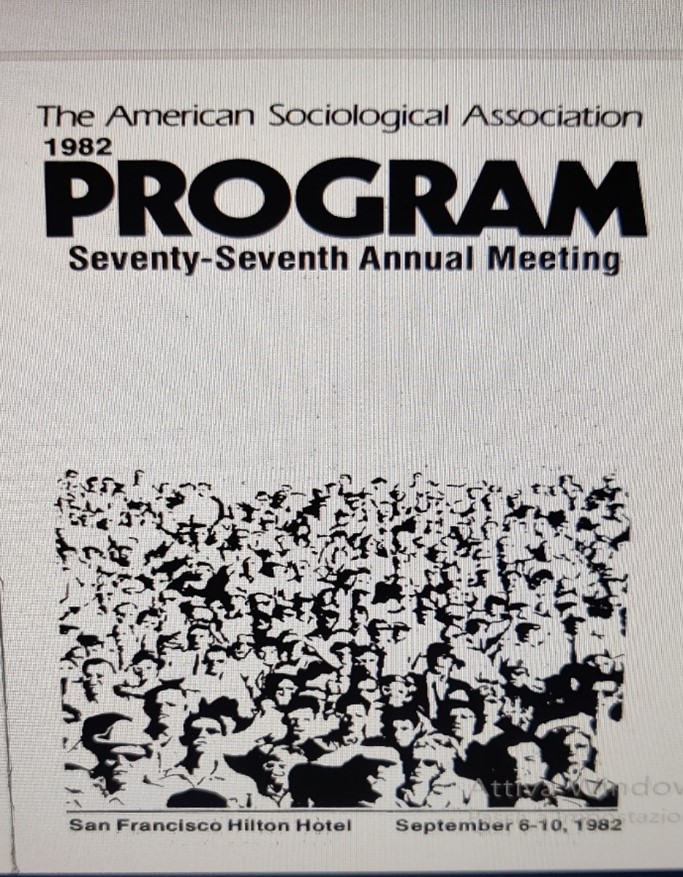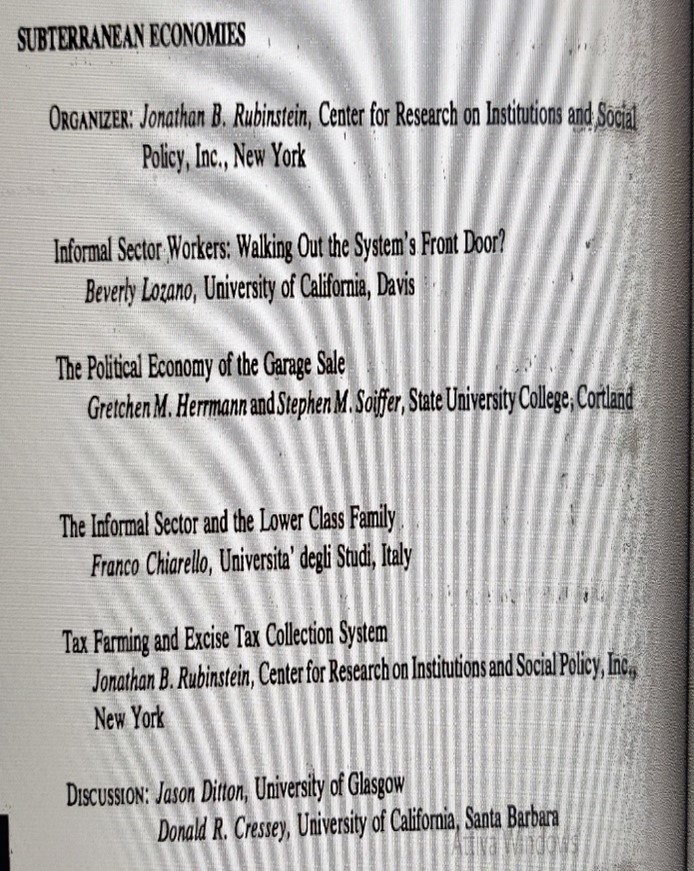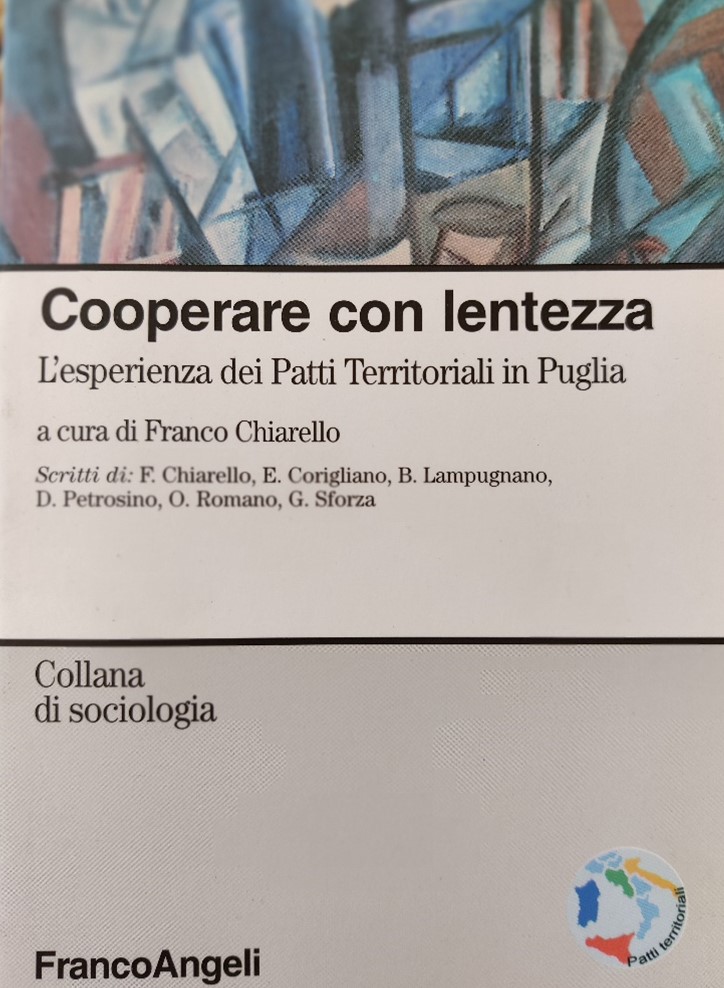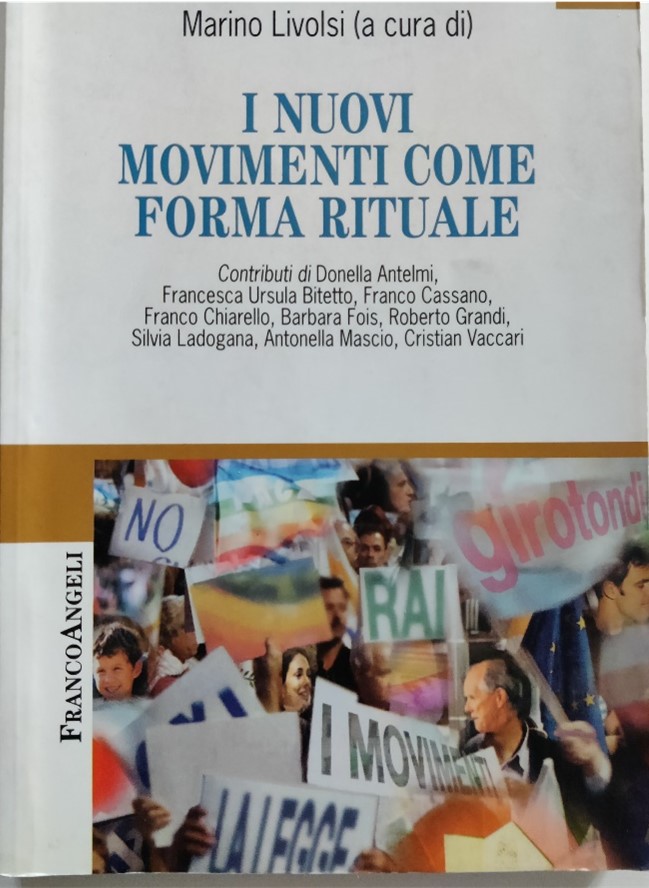Il concetto centrale attorno al quale ruota l’intervista con Franco Chiarello raccolta da Lidia Greco, e che di fatto ne contraddistingue l’attività accademica, è quello – da lui stesso suggerito – di sociologia pubblica, un concetto ripreso da Michael Burawoy che ne fece il tema principale di riflessione dell’American Sociological Association durante il suo mandato presidenziale del 2004. La sociologia pubblica si pone, da una prospettiva critica, in stretto dialogo con altri soggetti. Essa non è antitetica alla sociologia accademica, ma ne rappresenta una dimensione costitutiva. Nel percorso personale e professionale di Franco Chiarello lo studio dei fenomeni sociali si è costantemente intrecciato con l’impegno nell’arena socio-politica e le due esperienze si sono sempre alimentate a vicenda. Per questo, durante l’intervista si è scelto di ripercorrere la carriera di Franco Chiarello secondo degli snodi tematici che intrecciano la sua traiettoria professionale in diversi momenti temporali.
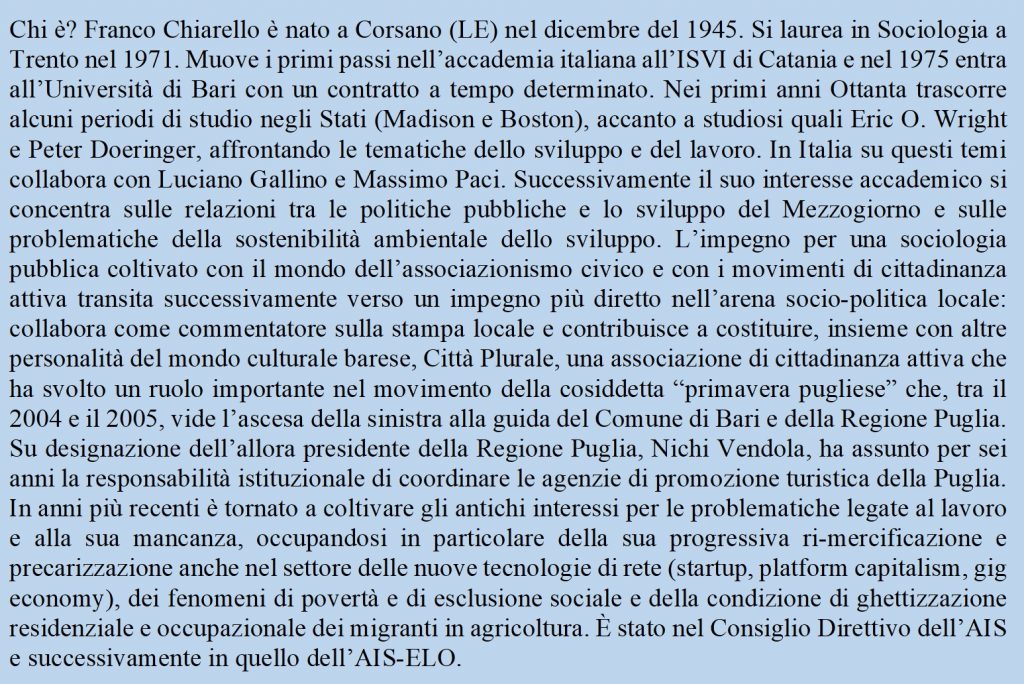
Caro Franco, prima di conversare con te sul tuo percorso nell’accademia italiana, mi piacerebbe chiederti delle tue origini familiari e del rapporto con la tua terra. Ti conosco da tanto e so che si tratta di legami forti che non sono mai venuti meno.
Sono nato in un piccolo centro del Salento nel Capo di Leuca, un’area oggi assai nota dal punto di vista turistico, ma all’epoca del tutto remota e poco conosciuta. Con la mia terra ho sempre conservato un legame forte e una costante frequentazione: anzi, da quando sono in pensione e anche a causa di questa tragica pandemia, vi trascorro periodi più lunghi. Credo che questo amor loci, legato tanto ai suoi caratteri fisici e monumentali quanto alla folta famiglia d’origine ma al tempo stesso distante dalle tradizionali e persistenti pigrizie della provincia, abbia molto giovato a darmi distanza dall’idea che la modernità sia tutta nei modelli di vita metropolitana o addirittura non abbia radici fortemente localizzate.
Provengo da una famiglia numerosa (7 fratelli e due sorelle) di modeste condizioni sociali: mio padre da sempre artigiano e contadino al tempo stesso, era divenuto piccolo imprenditore edile durante gli anni del boom economico. Aveva tirato su un’impresa familiare che lavorava prevalentemente in sub-appalto e che, dopo alcuni anni fortunati, fu spazzata via in seguito alle disavventure finanziarie dell’impresa appaltante. In ogni caso, temo che non sarei riuscito a proseguire gli studi più in là delle scuole superiori se non avessi avuto la fortuna di essere cresciuto nella famiglia di una zia dopo che – non avevo ancora 4 anni – mia madre era morta, lasciando mio padre solo con sei figli maschi, il maggiore dei quali aveva appena 16 anni.
Franco Chiarello a 12 anni con la sua famiglia acquisita nel giorno del matrimonio di sua sorella
A questo proposito, devo dire che un indirizzo decisivo per il mio percorso scolastico venne dal preside della scuola media che frequentavo, la cui influenza indusse mio padre ad abbandonare il proposito di fare di me un geometra per avere un supporto professionale che aiutasse la sua impresa edile a crescere. Oltre ad essere il preside della mia scuola e il mio professore di materie letterarie, questa persona era un esponente importante della Democrazia Cristiana locale (di lì a poco sarebbe diventato presidente della Provincia di Lecce e avrebbe sicuramente meritato di sedere in Parlamento) e, non da ultimo, era stato il mio padrino di cresima. Ricordo bene quando, invitato a casa da mio padre e mia zia per un consiglio sul mio futuro scolastico, egli suggerì con forza che io frequentassi il liceo classico invece che l’istituto tecnico per geometri: il che, a quel tempo, significava anche poter proseguire gli studi all’università, che era invece quasi preclusa per chi provenisse da istituti tecnici. La sua autorità intellettuale e politica rese quel parere inappellabile e io considero questo uno degli snodi fondamentali della mia formazione e, più in generale, della mia vita.
Pensando alle mie origini sociali e territoriali, credo di poter dire oggi che esse hanno influenzato significativamente l’orientamento della mia attività di ricerca di cui parleremo più avanti.
Si, del tuo percorso di ricerca parleremo in seguito. Vogliamo prima vedere in che modo la tua biografia si è intrecciata con la sociologia? Come ti sei avvicinato alla disciplina?
Se ripenso al mio percorso formativo, trovo che ci sono state due tappe importanti che hanno favorito l’avvicinamento alle problematiche sociali, dapprima attraverso lo sviluppo di quello che Raymond Aron definirebbe un modo di pensare sociologico e, in seguito, attraverso l’interesse specifico per la sociologia come disciplina.
La prima deriva dalla figura di due miei professori di liceo: uno di italiano e greco (il prof. Cazzato) e l’altro di storia e filosofia (il prof. Valzano). Docenti molto preparati e rigorosi; nel loro insegnamento non era difficile scorgere una forte passione civile e politica e un’adesione altrettanto forte ai valori che – al contrario di oggi – a quel tempo (siamo nei primi anni Sessanta) a questa erano collegati. Entrambi erano infatti esponenti del Partito Socialista Italiano (peraltro, a lungo sindaci dei loro rispettivi comuni in provincia di Lecce).
Ricordo in particolare un episodio che mi aveva particolarmente colpito: il giorno successivo alla scomparsa di Papa Giovanni XXIII (ero al penultimo anno di liceo), i due professori, invece di fare lezione nelle rispettive materie, decidono di ricordare la figura del Pontefice e il significato sociale e politico del Concilio Vaticano II. Ricordo bene la loro commozione mentre parlavano di Papa Roncalli, un fatto che impressionò fortemente noi studenti, tanto più che quelle parole e quei sentimenti venivano da persone che noi tutti intuivamo essere assai lontane dalla religione cattolica e dai suoi riti. Sempre in relazione a queste figure decisive nel mio percorso formativo, un episodio che mi toccò profondamente fu quando, molti anni dopo, verso la metà degli anni Novanta del secolo scorso, mi capitò di rincontrare il mio vecchio professore di italiano e greco in occasione un seminario sul rapporto tra colonialismo e sottosviluppo che avevo organizzato a Bari nella mia Facoltà. Al termine dell’incontro, un anziano signore si avvicina lentamente alla cattedra e, con molta deferenza, si congratula con me per la chiarezza e l’incisività –a suo dire – del mio intervento. Lo guardo, mi sembra un volto conosciuto e dopo qualche attimo scocca la scintilla del ricordo: è lui, Andrea Cazzato, il mio amatissimo professore di liceo. Gli chiedo conferma, mi risponde che effettivamente è lui, che con la moglie trascorre diverso tempo a Bari perché una loro figlia vive lì con la sua famiglia. Rimango impietrito, arrossisco, farfuglio qualcosa, lo rimprovero bonariamente per il suo atteggiamento riverente nei miei confronti, dicendogli che tra noi due soltanto io ero tenuto ad esserlo poiché quel che ero e quel che pensavo era in larga parte merito suo. Un incontro che mi ha emozionato profondamente e che mi porterò sempre nel cuore!
Il secondo momento topico nel mio percorso formativo accadde dopo la fine del liceo. La crisi dell’impresa di mio padre aveva costretto i miei quattro fratelli più grandi ad emigrare. Uno dopo l’altro, si erano trasferiti a Parigi, dove, qualche anno dopo, avevano anch’essi avviato una piccola impresa edile. Così, potendo contare sul loro supporto, dopo il liceo decido anch’io di trasferirmi nella Ville Lumière per continuare i miei studi. Una cosa del genere non era semplice a quel tempo: dovetti prendere l’equivalente francese della mia licenza liceale e soltanto dopo potetti iscrivermi alla Facoltà di Sciences Humaines della Sorbona e, al contempo, ad un corso universitario di lingua e civilizzazione francese che mi avrebbe abilitato a insegnare la lingua francese all’estero. Come puoi immaginare, per un ragazzo che veniva dal profondo sud italiano, l’esperienza parigina (vi sono rimasto dal 1964 al 1967) è stata molto intensa e formativa sotto tutti i punti di vista: avevo la fortuna di vivere in una delle più vivaci capitali europee, di assorbirne tutti gli stimoli culturali e di studiare in una università prestigiosa, piena già allora di studenti provenienti da tutto il mondo e con l’opportunità di essere a contatto con alcuni dei mostri sacri della cultura internazionale: per dire, alla Sorbona mi è accaduto di seguire alcune conferenze di Jean Paul Sartre! Inoltre, in quel periodo in Francia si respirava già il fermento culturale e politico che sarebbe poi esploso nel maggio del 1968. Cominciava a delinearsi una critica forte alla società e all’economia capitaliste e notoriamente gli studenti di sociologia erano tra i più attivi nell’alimentare il dibattito politico e nell’organizzazione delle prime manifestazioni studentesche: insomma, erano l’anima del movimento del Maggio ’68 nel suo stato nascente. Cominciai così a interessarmi alla sociologia ed a leggere qualcosa in materia: ricordo, per esempio, che partecipai ad una conferenza di Alain Touraine che, insieme a Pierre Bourdieu e ad altri, era già un personaggio molto popolare nell’ambiente studentesco. Fu in quel contesto che oggi mi sento di collocare il mio passaggio dal “modo di pensare sociologico” che avevo appreso durante gli anni del liceo all’interesse per la sociologia come disciplina scientifica.
Tornato in Italia, decisi di continuare i miei studi nell’ambito delle scienze sociali, ma le mie informazioni sull’esistenza in Italia di un corso di studi universitari in Sociologia erano negative. Decisi allora di iscrivermi alla Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze, che mi sembrava quella più vicina alle tematiche che intendevo studiare. Caso volle che, durante l’estate, qualche mese prima di partire per Firenze, incontrai un ragazzo di un paesino vicino al mio, che non vedevo da qualche anno e che conoscevo perché ci avevo giocato contro a calcio. Parlando del più e del meno, egli mi disse che si era trasferito a Trento per studiare sociologia. Per me fu una rivelazione: cambiai subito i miei piani e nell’autunno del 1967 mi iscrissi all’Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento, che di lì a qualche anno sarebbe diventata la prima Facoltà di Sociologia in Italia, dove mi laureai nell’anno accademico 1970/71 con una tesi in Politica economica con Luigi Frey.
Come sono stati gli anni di formazione a Trento?
Quando sono arrivato a Trento, la Facoltà di Sociologia si trovava sul crinale di due epoche: da un lato, vi erano i corsi tradizionali incentrati sull’insegnamento delle teorie sociologiche classiche e degli strumenti di carattere tecnico-professionale (gli esami di matematica e di statistica erano tra i più ostici da superare!); dall’altro, grazie alla pressione del nascente movimento studentesco, guadagnava spazio lo studio di una sociologia critica, che a sua volta si intrecciava con un forte impegno politico. Il corpo docente era composto da personaggi conservatori, molto legati alla tradizione, su cui venivano però innestandosi professori più giovani, di orientamento più democratico e progressista. Di conseguenza, si doveva studiare intensamente: per superare gli esami, ma anche per entrare in possesso degli strumenti che pensavamo fossero necessari per interpretare e trasformare la realtà che ci circondava. Oltre ai corsi convenzionali, la Facoltà brulicava di seminari di studio e di assemblee politiche. E ad entrambi partecipavano spesso i nostri docenti, molti dei quali non erano la nostra controparte, ma contribuivano alle nostre elaborazioni politiche. Salvo poche eccezioni, da Trento sono passati i sociologi più importanti dell’epoca: da Achille Ardigò a Franco Ferrarotti, da Francesco Alberoni a Vittorio Capecchi, da Gian Enrico Rusconi a Marino Livolsi, da Gian Primo Cella ad Antonio de Lillo a Chiara Saraceno, solo per citarne alcuni.
Franco Chiarello all’ingresso della Facoltà di Sociologia di Trento con altri studenti. Al centro, Marco Boato che sarà poi parlamentare dei Verdi per lungo tempo.
Nel mio percorso universitario due figure sono state per me particolarmente importanti: Giovanni Arrighi e Franco Cazzola. Il corso di Politica economica di Arrighi, che al Fernand Braudel Center della State University di New York sarebbe poi diventato, con Immanuel Wallerstein, uno dei massimi studiosi del sistema-mondo, era frequentato da un numero straordinario di studenti. Egli era arrivato a Trento dopo un’esperienza di insegnamento universitario in Rhodesia (l’odierno Zimbabwe) e in Tanzania ed è stato lui ad introdurmi alle tematiche del neo-colonialismo e alle teorie della modernizzazione e della dipendenza, facendomi conoscere autori come Frantz Fanon, Andre Gunder Frank, Samir Amin.
Arrighi era anche molto impegnato sul piano politico: all’inizio degli anni ’70 era stato tra i fondatori di un movimento politico, il Gruppo Gramsci, all’interno di quella che allora veniva chiamata sinistra extraparlamentare. Questa organizzazione operava soprattutto a Milano, ma era attiva anche a Trento e aveva instaurato rapporti di stretta collaborazione con il Circolo Lenin di Puglia, un gruppo politico della mia regione che seguivo da vicino. Ricordo benissimo che, mentre preparavo la mia tesi di laurea, Arrighi mi suggerì caldamente di ritornare in Puglia, di prendere contatti con i dirigenti del Circolo Lenin e di lavorare da lì alla mia tesi. Qualche anno dopo, invitai Arrighi in Puglia dove tenne delle conferenze molto partecipate su una sua esperienza di viaggio nella Cina della rivoluzione culturale di Mao Tse Tung.
Franco Cazzola era invece il mio professore di Sociologia Politica. Anche il suo corso era molto seguito e, su sua richiesta, in diverse occasioni coordinavo dei seminari di studio che si svolgevano a latere del suo insegnamento.
Dopo Trento quale percorso ti ha portato ad entrare nei ranghi dell’accademia?
Nel frattempo, non ancora laureato, mi ero sposato con Maria e poco dopo era nato mio figlio Emiliano. Subito dopo la laurea, seguendo il consiglio di Arrighi, mi trasferii con la famiglia nel Salento dove per un anno insegnai lingua e letteratura francese in un liceo linguistico privato di Lecce. Alla fine di quell’anno (1971), Cazzola mi propose di partecipare a un bando del CNR per una borsa di studio biennale di specializzazione post-laurea presso l’Istituto sui Problemi Sociali dello Sviluppo (ISVI), che muoveva i suoi primi passi a Catania ed era affiliato alla giovane Facoltà di Scienze Politiche della città etnea. L’ISVI, che si avvaleva del supporto del Formez e del CNR, era una creatura del Comitato per le Scienze Politiche e Sociali (Co.S.Po.S), che tra la metà degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta, su impulso del politologo Alberto Spreafico, svolse un ruolo fondamentale nello sviluppo delle scienze sociali italiane, grazie al sostegno di istituzioni americane, come la National Science Foundation e la Ford Foundation e, in Italia, della Fondazione Adriano Olivetti. Il Comitato, di cui Spreafico era il segretario generale, era formato da illustri studiosi tra i quali da parte italiana Manlio Rossi Doria e Norberto Bobbio e da parte americana Joseph La Palombara e Franco Modigliani.
L’ISVI ospitava borsisti provenienti da tutta Italia, offrendo un percorso di formazione multidisciplinare che ruotava fondamentalmente intorno alla sociologia, alla scienza politica e all’economia. Tra i nostri tutor figuravano giovani studiosi come Raimondo Catanzaro ed Emilio Reyneri e tra i docenti invitati figure come Alberoni, Gallino, La Palombara, Tarrow, Salvati, De Cecco, Marradi, Graziano, Caciagli, Pugliese e tanti altri. L’atmosfera che si respirava all’ISVI mi ricordava molto quella che avevo trovato a Trento, assai diversa da quella ingessata che, nonostante il ’68, era ancora predominante in molta parte dell’Università italiana: i ritmi dei corsi e dei seminari erano molto intensi e altrettanto intensi erano i rapporti tra i borsisti e i docenti anche fuori dall’aula. Vi era una forte convivialità: si stava spesso insieme a pranzo o a cena e non di rado nei weekend ci si spostava tutti insieme a Salina, nelle isole Eolie, dove alcuni borsisti mettevano a disposizione la casa dei loro genitori. Dopo quella di Trento, per me il biennio all’ISVI rappresentò un’esperienza scientifica e umana straordinaria. Durante quel periodo ho fatto anche il mio apprendistato nella ricerca sul campo, collaborando ad alcune ricerche sul rapporto tra imprenditorialità e politica locale nell’area di Catania, coordinate da Raimondo Catanzaro e Franco Cazzola, che intanto si era trasferito per insegnare nella città etnea.
Qualche mese dopo aver concluso il mio biennio all’ISVI continuai il mio apprendistato sul campo, collaborando a un’indagine sulla governance negli enti pubblici condotta da Alberto Predieri per la Fondazione Adriano Olivetti e al celebre studio di Robert Putnam sul rendimento economico e politico delle Regioni italiane, i cui risultati furono raccolti diversi anni dopo nel volume “La tradizione civica nelle regioni italiane” (1993), nel quale, com’è noto, vennero introdotti due concetti chiave – quello di civicness e quello di capitale sociale – che negli anni successivi hanno alimentato un serrato dibattito nelle scienze sociali italiane.
Nel 1975, superai la selezione per un contratto a tempo determinato all’Università di Bari. La posizione di “contrattista”, come allora veniva definita, era incardinata nella Facoltà di Giurisprudenza e precisamente nel prestigioso Istituto di Diritto del Lavoro, diretto allora da Gino Giugni, che qualche anno prima aveva elaborato lo Statuto dei Lavoratori. Poiché in quell’ambiente gli spazi per una sociologia che non fosse legata alle relazioni industriali erano angusti, mi trasferii quasi subito presso l’Istituto di Sociologia che si era appena costituito nella stessa Facoltà grazie a un piccolo gruppo di giovani studiosi arrivati alla sociologia attraverso diversi percorsi culturali (Giovanni Bechelloni, Franco Cassano, Eligio Resta, Filippo Battaglia, Peppino Cotturri e Giovan Francesco Lanzara).
Di lì a poco, da Milano arrivò a Bari per il suo triennio di straordinariato Franco Rositi. Ad una inesauribile vivacità intellettuale Rositi univa grandi doti organizzative. Per me, e credo anche per gli altri miei colleghi baresi, la presenza di Rositi è stata fondamentale per la sua capacità di creare a Bari una comunità di sociologi aperta e innovativa e di inserirla nel dibattito sociologico nazionale e nelle reti di ricerca che a quel tempo cominciavano a strutturarsi anche in Italia. Numerosi erano i seminari organizzati dall’Istituto di Sociologia ai quali partecipavano giovani studiosi di altre discipline, alcune anche lontane dalla sociologia (medicina, informatica, fisica,…). Grazie anche al rapporto con il sindacato, e in particolare con Bruno Manghi, che allora dirigeva a Taranto la Scuola di formazione della CISL nel Mezzogiorno, promuovemmo a Bari, credo per primi in una università del Sud, i corsi delle 150 ore destinati ai lavoratori. La mia stessa partecipazione, come unità di Bari, alla ricerca nazionale sul doppio lavoro coordinata da Luciano Gallino, che alla fine degli anni Settanta rappresentò un esperimento di collaborazione tra centri di ricerca universitari (sei), che nel campo delle discipline sociologiche non aveva forse precedenti in Italia, maturò in quell’atmosfera barese di industriosità disciplinare. Con Rositi, che lasciò Bari nei primi anni Ottanta per ritornare al Nord, ho un debito intellettuale enorme e un profondo sentimento di amicizia che continuo a coltivare nonostante le occasioni di incontrarci si siano diradate nel tempo.
Di quali temi di ricerca ti sei occupato all’inizio della tua carriera universitaria e che sono rimasti oggetto del tuo interesse scientifico anche in seguito?
Già durante gli anni di università a Trento, grazie all’influenza che su di me avevano esercitato alcuni docenti, avevo maturato un interesse particolare verso lo studio dei fenomeni economici, in particolare verso le problematiche dello sviluppo e del lavoro, da una prospettiva sociologica. Direi che fondamentalmente – salvo qualche sporadica incursione in altri territori della sociologia – attorno a questi due temi si è snodata tutta la mia attività di studio e di ricerca.
Frey, con cui mi ero laureato, era a quel tempo uno degli studiosi più influenti delle trasformazioni della struttura produttiva e del mercato del lavoro in Italia. Questi stessi temi costituivano poi uno degli assi portanti dell’offerta formativa durante il mio percorso di specializzazione all’ISVI di Catania. Naturalmente, la necessità di connettere l‘analisi dei fenomeni economici allo studio dei processi sociali e istituzionali partiva da classici come Marx, Durkheim, Weber e Polanyi fino ad arrivare in seguito alle “complicazioni” dell’economia di Hirschman e al radicamento sociale dell’azione economica (embeddedness) di Granovetter.
In particolare, la mia attenzione si andava concentrando – rimanendo poi costante nel tempo – sul rapporto tra sviluppo e disuguaglianze territoriali e sociali, che mi apparivano – allora come oggi – fortemente correlate: nel senso che la penalizzazione dei territori più deboli tendeva ad accentuare le disuguaglianze sociali e, viceversa, la proliferazione delle fasce sociali più deboli tendeva ad accrescere le disparità territoriali.
Una delle forme più rilevanti in cui le disuguaglianze territoriali si traducevano in disuguaglianze sociali era quella del mercato del lavoro, un tema che nei primi anni ’70 convogliava l’attenzione di molti studiosi e che fu al centro di un vivace dibattito tra economisti e sociologi. Gli studi e le ricerche sul tema si moltiplicavano in Italia come in altri paesi, segnatamente negli Stati Uniti (M. Piore, The Dual Labor Market: Theory and Implications, 1971; M. Reich, D. M. Gordon and R. C. Edwards, A Theory of Labor Market Segmentation, 1973). In Italia sono da ricordare in particolare i contributi raccolti in due volumi: uno curato da P. Leon e M. Marocchi del 1973 (Sviluppo economico italiano e forza-lavoro) e un altro a cura di S. Vinci del 1974 (Il mercato del lavoro in Italia), che ospitavano saggi sia di economisti come Graziani, De Cecco, Frey, Meldolesi, Modigliani, Tarantelli, Sylos Labini, che di sociologi come Paci, Mottura, Pugliese. Inoltre, particolarmente influente per i giovani sociologi di allora fu il volume di Massimo Paci, Mercato del lavoro e classi sociali in Italia (1973).
I riscontri empirici di partenza erano apparentemente contraddittori: da un lato, la diminuzione del tasso di attività, con una riduzione tanto degli occupati quanto delle persone alla ricerca di un lavoro, e, dall’altro, l’esistenza di una forza lavoro “rigida” e garantita pur in presenza di forti tassi di disoccupazione manifesta o latente. La spiegazione stava nel fatto che, per dirla in termini marxiani, la sovrappopolazione relativa non poteva essere assimilata all’esercito industriale di riserva (con una quota residuale di sottoproletariato), ma era composta da una crescente massa marginale che non entrava in concorrenza con la forza lavoro “centrale”.
Nei settori produttivi più moderni, questa situazione sembrava determinata da un meccanismo di selezione degli occupati che si concentrava sui lavoratori maschi, nelle fasce centrali di età, con scolarizzazione media e pre-socializzazione urbana e, nei settori produttivi tradizionali, da una parallela domanda di manodopera “debole”, disposta dal canto suo a impieghi più flessibili (precari, irregolari, ecc) e a remunerazioni inferiori. Fuori da questi due mercati, esisteva poi un mercato del lavoro intellettuale sul quale si addensavano i giovani più scolarizzati. È questa la tesi della segmentazione del mercato del lavoro, che cerca di spiegare la rigidità dell’offerta con il tipo di domanda centrale e con gli effetti secondari da questa indotti nel sistema.
La configurazione sociale del mercato del lavoro aveva – e ha tuttora – evidenti declinazioni territoriali, nel senso che più ci si allontanava dai territori dove più diffusa era la presenza dei settori produttivi moderni, più cresceva la domanda e l’offerta di lavoro marginale. Nel Mezzogiorno le forme di occupazione precaria o informale erano naturalmente molto più diffuse che nel resto del paese. Alle dinamiche del mercato del lavoro nel Mezzogiorno dedicai alcune delle mie prime pubblicazioni all’inizio degli anni 70.
In seguito, nel 1979, prese avvio una ricerca nazionale sul doppio lavoro promossa dal Consiglio Italiano per le Scienze Sociali con il contributo del CNR, alla quale, grazie all’operosità di Franco Rositi, partecipai insieme con altri colleghi dell’Istituto di Sociologia di Bari. Questa ricerca appariva molto innovativa non solo per l’argomento di studio, ma anche perché per la prima volta in Italia impegnava sullo stesso tema gli istituti di sociologia di sei diverse sedi universitarie (Ancona, Bari, Catania, Napoli, Pisa e Torino). Il lavoro di ricerca mi dette l’opportunità di conoscere e frequentare molti eccellenti ricercatori e alcuni esponenti di primo piano della sociologia italiana, in primis Luciano Gallino (che ne era il coordinatore) e Massimo Paci, che hanno costituito per me una costante fonte di apprendimento e di ispirazione. Il rapporto con entrambi, professionale e umano, si è poi consolidato nel tempo tanto che, anni dopo (nel 2004), fu proprio Gallino a propormi di entrare nel comitato editoriale dei Quaderni di Sociologia di cui faccio parte tuttora. Sul tema del doppio lavoro, oltre a diversi saggi pubblicati nel corso degli anni (il primo da me scritto proprio con Rositi nel 1979), uscirono sei monografie, tra cui la mia sull’area di Bari, e un volume di sintesi curato da Gallino con un mio capitolo su doppio lavoro e partecipazione sociale (entrambi nel 1985).
So che in quegli anni hai trascorso dei periodi di studio negli Stati Uniti. Cosa ci puoi dire di quell’esperienza?
Al termine della ricerca sul doppio lavoro, mentre procedevo all’elaborazione dei dati raccolti e cominciavo a lavorare alla mia monografia, mi si offrì l’opportunità di partecipare ad un bando internazionale promosso dalla Ford Foundation per una borsa di studio annuale negli Stati Uniti. Il tema che mi proponevo di studiare era quello dell’economia informale, un fenomeno che anche oltre oceano stava suscitando un notevole interesse. Così, all’inizio del 1981 mi trasferii negli Stati Uniti prima al Dipartimento di Sociologia dell’Università del Wisconsin – Madison e poi, negli ultimi quattro mesi, presso il Center for Research on Institutions and Social Policy (CRISP), affiliato alla New York University. A Madison fui accolto da Erik Wright, un importante sociologo purtroppo scomparso di recente, che ha dato un grande contributo allo studio delle classi e delle disuguaglianze sociali da una prospettiva neo-marxista.
L’ambiente accademico di Madison era molto vivace e stimolante, ricco di incontri e seminari con i più influenti esponenti della sociologia critica dell’epoca (ricordo tra gli altri Michael Burawoy, Jon Elster, Goran Therborn, Ivan Szelényi). Il CRISP di New York era invece diretto da Jonathan Rubinstein, un allievo di Erving Goffmann, noto allora per aver pubblicato un saggio (City Police) sulla vita professionale e sociale degli agenti della polizia di una grande città americana, analizzandola dall’interno dopo essersi arruolato nel corpo di polizia di Filadelfia. Egli inviò a Goffmann una prima versione del saggio sull’economia informale a cui stavo lavorando durante il mio soggiorno statunitense. Dal grande sociologo ricevetti una bella lettera di sostegno e di incoraggiamento e da Rubinstein l’invito a presentare una relazione sul tema al congresso annuale dell’American Sociological Association di cui nel 1982 Goffmann era presidente e lo stesso Rubinstein coordinatore di una sessione sulle subterranean economies. Con alcune integrazioni il testo italiano di quella relazione venne poi pubblicato l’anno successivo nella Rassegna Italiana di Sociologia.
Sono ritornato negli Stati Uniti qualche anno dopo con una borsa di studio del governo americano la cui genesi è assai curiosa. Infatti, il governo americano aveva donato all’Italia dei fondi destinati alla ricostruzione delle scuole distrutte dal terremoto del 1980 in Irpinia. Poiché queste risorse non erano state utilizzate entro il tempo concordato, nel 1985 il governo americano, invece di riprendersele, decise di convertirle in borse di studio destinate a giovani ricercatori delle università meridionali. Ricordo di aver sostenuto il colloquio di selezione a Bari davanti ad una commissione giunta dagli Stati Uniti, presieduta da David Gordon, un economista della New School for Social Research, molto conosciuto dai sociologi italiani per i suoi studi sulla segmentazione del mercato del lavoro. Nel 1986 e nel 1988, mi trasferii a Boston per due tornate semestrali come Visiting Scholar presso l’Institute for Employment Policy della Boston University. L’Istituto era diretto da Peter Doeringer, un economista anche lui noto tra gli studiosi italiani per i suoi studi sul mercato del lavoro. Naturalmente, anche questa seconda esperienza fu per me molto stimolante. Boston è una città molto bella e gradevole e, sotto il profilo scientifico, ero costantemente impegnato a partecipare a corsi e seminari che, oltre che alla B.U., si svolgevano nelle cattedrali accademiche di Harvard e del MIT con studiosi del calibro di Michael Piore, Charles Sabel, Suzanne Berger, Ronald Dore, Robert Putnam, Alessandro Pizzorno,
A Boston, come già a Madison, il rapporto tra professori, giovani ricercatori e studenti era molto rigoroso sul piano professionale, ma al tempo stesso molto più rilassato e informale che in Italia. Gli incontri con docenti famosi fuori dall’ambito accademico erano frequenti e in uno di questi ebbi modo di conoscere Franco Modigliani, a cui l’anno prima era stato conferito il Premio Nobel per l’economia. Non solo egli mi chiese informazioni sulla mia attività di ricerca, ma mi propose anche di incontrarci nel suo studio al MIT per discuterne. Io pensavo che fosse un invito di circostanza e invece, quando per cortesia chiamai il numero che mi aveva dato, la sua segretaria mi disse che il professore stava aspettando la mia telefonata e mi fissò un appuntamento per il giorno successivo. Io ero davvero emozionato, ma Modigliani mi mise a mio agio in maniera molto cordiale. Nell’ora che mi dedicò, ascoltò con molta attenzione quello che avevo da dire sulla mia ricerca, fece qualche commento benevolo e mi manifestò la sua disponibilità per qualsiasi cosa di cui avessi avuto bisogno. Non ci rivedemmo più, ma di quell’incontro conservo un ricordo indelebile.
Durante la mia permanenza a Boston, mi recai un paio di volte alla MCGill University di Montreal per tenere dei seminari (uno sull’economia informale e l’altro sul doppio lavoro) su invito di Anthony Masi, un docente di sociologia del lavoro e dell’industria in quell’università, che avevamo ospitato a Bari l’anno prima per una ricerca che stava conducendo sull’Italsider di Taranto e che sulla rivista Contemporary Sociology aveva scritto una circostanziata recensione dei volumi sul doppio lavoro da poco pubblicati in Italia.
Da quello che dici, questi soggiorni negli Stati Uniti sono stati molto importanti per la tua attività di studio e di ricerca. Ci sono state altre occasioni di esperienza all’estero?
Si, ma per periodi molto più brevi, soprattutto per tenere dei seminari. Un paio di mesi a New York (Fordham University) e a Parigi (SciencesPo) nel 2004; due brevi soggiorni a Buenos Aires, nel 2001 e nel 2004, per tenere un corso all’Università di Belgrano e dei seminari all’Università di Quilmes nel quadro di un accordo di collaborazione tra l’università di Bari e diverse istituzioni accademiche argentine. Un soggiorno breve ma molto interessante l’ho fatto in Iran a seguito di una summer school sul Vicino Oriente svoltasi ad Otranto nel 2009 e un susseguente scambio culturale con ricercatori e intellettuali iraniani. Poi diversi soggiorni a Londra negli ultimi anni della mia vita accademica per studiare il capitalismo delle piattaforme, la cosiddetta gig economy e i processi di precarizzazione del lavoro ad esso connessi.
Dopo queste esperienze quali sono stati i tuoi orientamenti di ricerca?
Rimanendo nel solco di una sociologia pubblica, di ritorno dal mio primo soggiorno negli Stati Uniti, sono stato coinvolto nel progetto di una nuova rivista che si chiamava Azimut e che nacque nell’ambiente vivacissimo della FIM-Cisl milanese, di cui era allora segretario Piergiorgio Tiboni mentre Pierre Carniti ne era il segretario confederale. Si trattava di una rivista non accademica, ma molto rigorosa sul piano dei contenuti e molto innovativa dal punto di vista grafico. Alla redazione della rivista, insieme con me, lavoravano fotografi come Uliano Lucas, grafici come Davide Danti, giornalisti come Biagio Longo allora direttore di Radio Popolare, una radio che ha fatto la storia della comunicazione in Italia, e collaboravano tra gli altri studiosi come Giorgio Galli, Paolo Leon, Lorenzo Rampa. Nei suoi sei anni di vita vi ho pubblicato diversi articoli sugli argomenti che allora erano al centro dei miei interessi di ricerca: lo sviluppo e le disuguaglianze territoriali, l’economia informale, le trasformazioni del lavoro, l’immigrazione clandestina, un tema questo su cui credo di essere stato uno dei primi (con Umberto Melotti) a scrivere in Italia.
Questi temi sono stati al centro delle tue ricerche anche in seguito?
Soltanto in parte, direi. Certo, anche in seguito, negli anni ’90, ho continuato a lavorare su queste tematiche, ma la mia attenzione si è andata via via concentrando sulle relazioni tra le politiche pubbliche e lo sviluppo del Mezzogiorno e sulle problematiche della sostenibilità ambientale dello sviluppo, un aspetto, questo, che già appariva cruciale in quegli anni e che, com’è facile accorgersi, lo è diventato ancor di più ai giorni nostri.
L’interesse verso il primo tema si ricollegava al fatto che in quegli anni la tradizionale politica dell’intervento straordinario dello Stato veniva abbandonata a favore di un decentramento istituzionale delle politiche di sviluppo che enfatizzavano maggiormente il ruolo degli attori e dei sistemi produttivi locali. L’evento cardine del passaggio alla cosiddetta “programmazione negoziata” fu il seminario di Catania “Cento idee per lo sviluppo”, promosso nel 1998 dall’allora ministro del Tesoro Ciampi e dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione diretto da Fabrizio Barca, al quale partecipai insieme a molti altri studiosi, contribuendo anche al documento programmatico di base.
L’interesse verso le relazioni tra lo sviluppo economico e l’ambiente naturale era nata invece nel 1994 a seguito della mia elezione come rappresentate della comunità sociologica nel Comitato per le scienze economiche, sociologiche e statistiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Comitato mi aveva designato a rappresentare le scienze sociali in un altro Comitato del CNR, quello per le scienze e le tecnologie dell’ambiente, e nello Steering Committee del Programma europeo TERM (Tackling Environment Management Research) promosso dallo Standing Committee for Social Sciences (SCSS) dell’European Science Foundation (ESF). Infine, designato a rappresentare il CNR anche nel Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Gargano, avevo cominciato a misurarmi con i problemi del governo e della gestione operativa di un ecosistema complesso come quello di un’area protetta.
Del Comitato del CNR, presieduto da Luigi Paganetto, preside della Facoltà di Economia di Tor vergata, facevano parte tra gli altri studiosi del calibro di Marcello De Cecco, Michele Salvati, Vera Zamagni e Ignazio Visco, attuale Governatore della Banca d’Italia.
Sono di questo periodo alcuni saggi sui Patti Territoriali, uno dei principali strumenti della “programmazione negoziata” volti a promuovere lo sviluppo dei territori meridionali, e sul tema della sostenibilità ambientale dello sviluppo. Tra i primi, vorrei segnalare il volume Cooperare con lentezza. che presenta i risultati per la Puglia di una ricerca condotta nell’ambito di un Progetto di interesse nazionale (PRIN), coordinata da Franco Cerase, al quale parteciparono diverse università meridionali (Napoli, Bari, Cagliari e Catania).
Dei rapporti tra sviluppo e sostenibilità ambientale, trattano alcuni altri lavori. Tra questi ricordo in particolare un saggio uscito nel 1998 su OIKOS, una piccola ma prestigiosa rivista di ecologia delle idee, che riprendeva una relazione su Environment and Development. The Limits of Conventional Economic Wisdom da me presentata al 14° Congresso Mondiale di Sociologia di Montreal, un articolo dal titolo Population, Environment and Economic Growth, pubblicato su Theomai, una rivista argentina, e un volume del 2002, scritto con Emma Corigliano, sull’impatto ambientale e sociale di un grande insediamento industriale (la Fiat nell’area di Melfi). Sul tema dei rapporti tra grande industria e ambiente sono poi tornato anche in tempi più recenti con alcuni saggi riguardanti l’ILVA e il territorio di Taranto scritti a quattro mani con Lidia Greco.
Si, le drammatiche vicende dell’ILVA e del territorio tarantino, che per un tratto abbiamo seguito e studiato insieme, e più in generale le problematiche ambientali continuano a porre domande stringenti ai sociologi dell’economia e del lavoro. Con le ricerche sui rapporti tra sviluppo e ambiente arriviamo nel nuovo millennio. Quali impegni e interessi hanno scandito la parte finale della tua carriera accademica?
Intanto, accanto all’attività didattica e al lavoro di ricerca sui temi appena indicati, nei primi anni del nuovo millennio, si è rinnovato il mio impegno nella comunità scientifica dei sociologi dell’economia e del lavoro, essendo stato eletto per la seconda volta nel Consiglio Direttivo dell’AIS-ELO. D’altro canto, in quegli stessi anni anche il mio impegno per una sociologia pubblica, caratterizzato da una costante interlocuzione con il mondo dell’associazionismo civico e con i movimenti di cittadinanza attiva, transita verso un impegno più diretto nell’arena socio-politica locale, sia collaborando come commentatore all’edizione locale del quotidiano “La Repubblica”, sbarcato a Bari proprio nel 2000, sia costituendo, insieme con altre personalità del mondo culturale barese, Città Plurale, una associazione di cittadinanza attiva che ha svolto un ruolo importante nel movimento della cosiddetta “primavera pugliese” che, tra il 2004 e il 2005, vide l’ascesa della sinistra alla guida del Comune di Bari e della Regione Puglia. Una riflessione su quell’esperienza è contenuta un saggio apparso del 2005 in un volume sui nuovi movimenti sociali curato da Marino Livolsi.
Dall’anno successivo, su designazione dell’allora presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ho assunto per sei anni la responsabilità istituzionale di coordinare le agenzie di promozione turistica della Puglia. In questa veste, mi piace pensare di aver dato un qualche contributo al successo turistico della regione che decolla proprio in quegli anni. A seguito di questo incarico, in quel periodo ho condotto delle ricerche su questo settore, che ne hanno evidenziato la valenza nel quadro dello sviluppo territoriale, senza tuttavia sopravvalutarne gli effetti sull’economia e sulla società locale. Infatti, con una torsione semplificatrice, che in un lontano passato si era già palesata nei confronti dei grandi insediamenti dell’industria pubblica (i cosiddetti poli di sviluppo) e, in tempi più recenti, di fronte alla diffusione di alcuni sistemi produttivi locali di piccola impresa, non pochi tra policy e opinion makers guardavano al turismo come la nuova leva archimedea per la rinascita complessiva della regione.
Le nostre ricerche confermavano invece la lezione hirschmaniana dello sviluppo polifonico: le dinamiche del turismo non solo sono strettamente connesse alla produzione e alla fruizione culturale, alla sostenibilità ambientale e alle produzioni agro-alimentari, ma non possono sostituirsi ad una solida base manifatturiera.
Terminata questa esperienza istituzionale, negli anni più recenti sono tornato a coltivare i miei antichi interessi per le problematiche legate al lavoro e alla sua mancanza, occupandomi in particolare della sua progressiva ri-mercificazione e precarizzazione anche nel settore delle nuove tecnologie di rete (startup, platform capitalism, gig economy), dei fenomeni di povertà e di esclusione sociale e della condizione di ghettizzazione residenziale e occupazionale dei migranti in agricoltura.
E oggi come trascorri il tuo tempo? Che cosa ti manca dell’università?
Intanto – è banale dirlo – dell’università continua a mancarmi soprattutto il rapporto con gli studenti. Per il resto – è altrettanto banale rilevarlo – il mio rapporto con gli orari si è trasformato in un più disteso rapporto con il tempo. Tempo da dedicare alla lettura e allo studio senza le pressioni e le scadenze della vita accademica, anche se di quella vita mi manca anche l’attività di ricerca. Soprattutto in questi tempi pandemici che sembrano non finire mai, la cui immane tragedia offre alla sociologia infinite possibilità di ricerca sull’organizzazione sociale del futuro tra spinte al cambiamento e inerzie continuiste: opportunità e limiti della globalizzazione, disuguaglianze sociali, società, economia ed emergenze ambientali, strutturazione della socialità, modelli di produzione e di lavoro, rapporto tra centri e periferie, mobilità territoriale e sociale, solo per citare alcuni macrofenomeni sui quali indagare e riflettere. Per la sociologia questa potrebbe essere una grande occasione per riguadagnare prestigio e visibilità nel dibattito pubblico. Questo riguarda anche la sociologia pubblica il cui declino in Italia mi pare innegabile non solo a causa dell’indebolimento della domanda sociale legata alla decomposizione di gran parte dei soggetti collettivi, ma anche al ripiegamento della sociologia su se stessa e al suo ritiro dalla scena pubblica.
Da parte mia, in questo periodo sto lavorando alla revisione di alcuni miei scritti sui rapporti tra sviluppo e sostenibilità ambientale, la cui persistente attualità mi induce ad aggiornare ed integrare in vista di una loro possibile pubblicazione in una forma più sistematica. Per il resto, trascorro molto più tempo nel mio paesello d’origine nel Salento, mi godo il mare sotto casa e del mare coltivo l’antico amore, prendendomi cura di Great Expectations, la barca a vela di cui sono armatore con altri amici d’infanzia e andando per mare anche d’inverno quando le condizioni meteorologiche lo consentono. Infine – last but not least – mi godo le mie tre bellissime nipotine che vivono a Milano e con le quali, purtroppo, negli ultimi due anni passo meno tempo di quanto vorrei a causa del Covid.