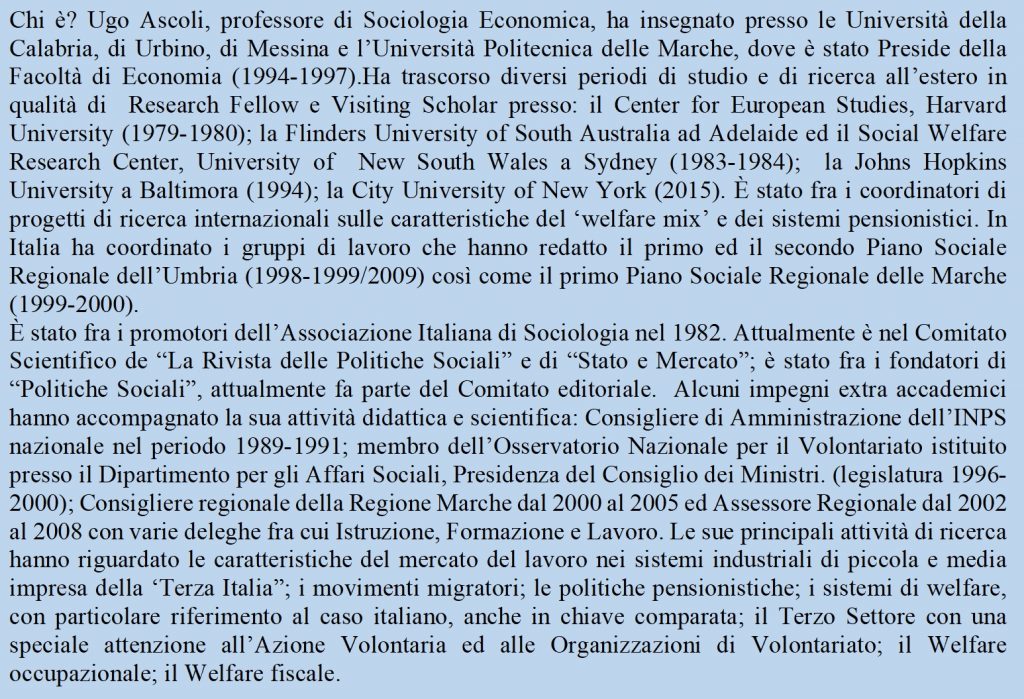In questa intervista raccolta da Emmanuele Pavolini, Ugo Ascoli ripercorre la sua biografia di studioso, dai primi anni formativi in cui sono stati importanti gli incontri con Massimo Paci, Alessandro Pizzorno, Giordano Sivini e Ada Cavazzani, fino alle successive esperienze di ricerca all’estero e in varie sedi universitarie italiane. Attraverso un racconto denso, dalle prime ricerche sul lavoro informale e l’azienda famiglia si arriva alla maturazione degli importanti contributi sulle specificità del “welfare state all’italiana” e sul ruolo del terzo settore nel welfare, fino a parlare della propria esperienza di coinvolgimento in politica e nel sindacato.
Quando e come hai sviluppato il tuo interesse per la sociologia?
La mia vocazione sociologica si è sviluppata durante i miei anni all’università. Ho iniziato l’università nel 1967 e allora non avevo neanche un minimo sentore di che cosa fosse l’economia, né tanto meno, la sociologia. Quando mi sono iscritto ero solo appassionato di filosofia e di storia e per questo poi scelsi i corsi di economia con l’indirizzo sociale.
Però sono stato subito preso della nuova atmosfera che c’era anche all’interno dell’Università di Urbino, nella facoltà di Economia collocata ad Ancona: c’era il movimento studenti di cui facevo parte e ho cominciato ad avere scambi importanti già al secondo anno con una serie di persone che a vario titolo frequentavano la facoltà. Da una parte, c’era un gruppo di sociologi accademici fra cui Alessandro Pizzorno, Massimo Paci (che era da poco arrivato col primo incarico), Giordano Sivini ed Ada Cavazzani (Giordano era incardinato in una Facoltà di Urbino, ma dato che venivano duplicati ad Ancona i corsi che svolgeva ad Urbino, era possibile ascoltare anche le sue lezioni). Quindi, iniziai a frequentare un bel numero di corsi di sociologia: da quello sui classici della sociologia con Pizzorno, a quello sulla sociologia del lavoro con Paci, alla sociologia politica con Sivini e alla sociologia urbana e rurale con Cavazzani. Ho fatto quindi una profonda immersione in temi sociologici praticamente appena entrato all’università. La Facoltà di Ancona aveva una caratteristica: era la prima Facoltà, insieme alla Bocconi, in cui era stato introdotto un indirizzo sociale accanto a quello economico propriamente detto.
Dall’altra parte, vi era un gruppo di studenti che avevano creato un “collettivo” – mi pare si chiamasse il “collettivo universitario marchigiano” – in cui erano attivi anche alcuni docenti di sociologia – soprattutto Sivini e Cavazzani -, che era animato da un grande dibattito e che si faceva carico anche di ricerche sul campo. Partecipai così ad una ricerca sulle condizioni di lavoro nel cantiere navale di Ancona, che allora era la principale azienda nell’anconetano con quasi 3000 dipendenti. Questa ricerca fu per me molto importante: per la prima volta cominciai a capire che cos’era un questionario, come si faceva un’intervista, come si elaboravano i dati. In più questi dati venivano discussi anche insieme alla Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM), assai interessata ad approfondire tematiche rilevanti per l’azione sindacale.
Si era in presenza di una commistione di occasioni scientifiche, accademiche e politiche; ho cominciato ad appassionarmi alla ricerca sociologica, mantenendo però il mio interesse anche per l’economia. La mia tesi di laurea è stata di pura teoria economica, su “Il Capitale negli schemi di equilibrio economico generale”. Quando mi sono trovato alla fine a scegliere come proseguire gli studi, ho scelto la sociologia economica, che allora era in fase nascente: Massimo Paci si era trasferito ad Ancona, prometteva di fare ricerca e di mettere in piedi una vera e propria ‘scuola’: era una persona che stimavo molto e lo stesso mio relatore di tesi, Fausto Vicarelli, che veniva dalla Banca d’Italia, mi supportò rispetto alla scelta della sociologia, dato che a suo parere si trattava di un indirizzo di studi assai promettente.
Da quel gruppo di studenti che seguiva Pizzorno e Paci, il primo tornato da poco da Harvard, sono usciti poi studiosi che hanno fatto carriera accademica: oltre a me, Piero Fantozzi, Patrizia David, Ennio Pattarin, Fabio Bugarini.
Sono andato avanti poi con una borsa di studio in sociologia economica ed ho iniziato la mia collaborazione con Massimo Paci, studiando il mercato del lavoro. Massimo creò un gruppo di ricerca per studiare il mercato del lavoro e l’economia marchigiana basata su piccola e media impresa. Per anni abbiamo lavorato sui distretti industriali più importanti delle Marche: quello tessile a nord di Ancona, quello del pesarese del mobile e quello calzaturiero nel fermano-maceratese. In queste aree della regione individuammo sei comuni, due per ogni distretto, e andammo a fare le interviste. Io andai a svolgere le mie interviste nel settore calzaturiero: interviste porta a porta come si diceva allora, cercando di comprendere come era organizzato quel settore. Scoprimmo così tanto lavoro, che oggi definiremmo “nero”. Durante le interviste emerse quanto fosse diffuso il lavoro a domicilio, quanto le donne fossero costantemente al centro di tensioni fra una occupazione (irregolare) a domicilio e il lavoro di cura per la famiglia. Trovammo una organizzazione familiare basata su quella che definimmo “famiglia azienda”: una famiglia nella quale i maschi andavano a lavorare nelle fabbriche, mentre le donne stavano in casa a fare il doppio lavoro. Grazie a queste ricerche riuscimmo anche a correggere le statistiche dell’Istat, che stimava tassi di attività e di occupazione femminili molto più bassi rispetto a quelli che avevamo scoperto noi. Alla fine siamo usciti con buone pubblicazione fra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta e nel frattempo abbiamo continuato ciascuno di noi ad approfondire alcune di quelle tematiche.
Ci sono ricordi particolari che ti legano a questa prima grande ricerca a cui hai partecipato?
Ve ne sono molti. In quel periodo andavamo in giro per i paesini delle Marche a fare interviste alle famiglie e incontravamo tanta gente. Nelle interviste porta a porta nei paesi calzaturieri spesso ci venivano a rispondere delle donne con grembiuli sporchi di colla e di vernici e quando chiedevamo: “Lei che cosa fa?”, ci veniva in genere risposto: “Niente! Sto in casa”. Poi, ricostruivamo insieme la giornata di queste presunte “casalinghe” e allora emergeva come lavorassero almeno 8 ore al giorno per cucire le tomaie o assemblare parti del prodotto, mentre però allo stesso tempo preparavano il pranzo o la cena, o si facevano carico dei bambini. Spesso e volentieri stavano in cucina: c’era il pentolone della pasta, magari vicino alle colle o alla macchina da cucire per le tomaie; tranquillamente e serenamente ci raccontavano la loro giornata dicendo che stavano in casa e “facevano qualcosa”. In realtà scoprimmo che si trattava di lavori spesso pesanti e pericolosi e che le loro giornate andavano tranquillamente oltre le 14-16 ore di lavoro complessivo fra lavoro di cura a casa e lavoro per i piccoli-medi imprenditori calzaturieri. L’altro aspetto interessante che scoprimmo in queste nostre ricognizioni riguardava quanto accadeva nelle piccole e medie imprese, dove si stava facendo spazio il sindacato. Ricordo che insieme alla Camera del Lavoro di Fermo tante volte partecipammo ad incontri originati da una chiamata dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende dove erano entrati in sciopero: spesso in queste imprese il sindacato non esisteva, operai ed operaie avevano deciso di scioperare autonomamente per protestare contro le condizioni di lavoro e chiamavano a quel punto il sindacalista. Mi ricordo alcune scene da film western a la Sergio Leone, in cui i sindacalisti si fronteggiavano con gli imprenditori: ci si trovava fuori dei cancelli dell’azienda con il sindacalista che parlava con dietro a sé le lavoratrici, di fronte a lui c’era uno spazio vuoto e poi l’imprenditore che col megafono si confrontava duramente con il sindacalista. I due gruppi si fronteggiavano e polemizzavano anche ferocemente come se fossero stati due duellanti: l’uno voleva ottenere salari e condizioni lavorative migliori, l’altro rifiutava i cambiamenti adducendo ragioni economiche. A quel punto il sindacalista conduceva tutte le lavoratrici di una fabbrica presso una sala del Comune vicino dove si organizzava una assemblea: lì ragionavano insieme, si riprendevano le analisi, si creava una piattaforma rivendicativa; quindi si tornava nell’azienda per contrattare col piccolo imprenditore aumenti di salario, cambiamenti di orario o di condizioni di lavoro. Gli imprenditori erano stupiti e sorpresi: la conflittualità era esplosa all’improvviso. Praticamente in quegli anni vi era una sorta di doppio binario nei distretti che studiavamo: da una parte vi era chi lavorava in casa e non si rendeva neanche conto di quanto lavorasse, dall’altra parte si stava diffondendo in modo spontaneo la lotta per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, con il sindacato che rincorreva le mobilitazioni spontanee.
Dopo questa prima esperienza di ricerca che cosa è successo?
A quel punto è accaduto che il gruppo dei sociologi anconetani si è scisso in due parti: una parte è rimasta con Massimo Paci a fare ricerca sull’economia “periferica”, altri invece hanno seguito Giordano Sivini ed Ada Cavazzani ed hanno fondato insieme la sociologia nella università nuova della Calabria ad Arcavacata di Rende, nell’area di Cosenza. Un altro pioniere per gli studi di sociologia in quei luoghi fu Giovanni Arrighi. Accanto a Giordano ed Ada, andarono alcuni di noi “giovani”, come Piero Fantozzi, Mariola Mandolini e Nedo Fanelli che proveniva dagli studi condotti ad Urbino. Alcuni anni dopo anche io raggiunsi la Calabria. Giordano Sivini mi telefonò comunicandomi che avrei potuto aspirare all’incarico – allora si chiamava incarico annuale – di sociologia nella loro sede. Io a quei tempi stavo lavorando ad un libro sull’immigrazione, mi sentivo ancora alle prime armi e non pensavo di poter già fare il salto a professore; in ogni caso inviai a Sivini ed Arrighi il mio curriculum e le mie pubblicazioni. Mi invitarono a fare domanda; ottenni l’incarico; fra gli altri che ottennero un incarico di sociologia in quell’occasione ci fu anche Pino Arlacchi. Mi trasferii così a Cosenza. Cominciò una nuova avventura: insegnavo nei corsi serali riservati agli studenti lavoratori. Devo dire che quella didattica mi diede grande soddisfazione: arrivavano certamente alcuni studenti lavoratori un po’ stanchi, che magari si addormentavano in aula, ma nel complesso avevo di fronte persone molto vivaci e motivate. Inoltre, il ‘modello universitario’ realizzato ad Arcavacata era molto avanzato, simile ad un campus “anglosassone”: gli studenti dovevano risiedere negli alloggi appositamente costruiti per loro, così come erano stati previste anche residenze fornite gratuitamente dall’Università ai docenti. Insomma si era in presenza di una vera e propria ‘comunità’: tale comunità era composta, da un lato, da docenti prevalentemente provenienti dal Centro-Nord Italia, dato che non c’era una tradizione di studi sociali ed economici in Calabria e, dall’altro, da studenti tutti calabresi e di classe sociale medio bassa (c’erano infatti graduatorie di ammissione che privilegiavano i meno abbienti). Le famiglie di classe medio alta inviavano i loro figli presso gli atenei di Roma o di Napoli.
Nel corso della tua carriera hai passato anche molti periodi all’estero? Come è iniziata questa esperienza?
Mentre ero in Calabria, dopo essermi confrontato con alcuni autorevoli studiosi, fra cui Massimo Paci e Gino Germani, ho maturato l’idea di un periodo di studio all’estero per inaugurare nuovi campi di ricerca ed allargare i miei orizzonti. Dopo vari tentativi (consiglio sempre ai colleghi e alle colleghe più giovani di andare all’estero per alcuni periodi e di non demordere se non si riesce al primo tentativo), ho ottenuto una borsa di studio della Ford Foundation per trascorrere un anno ad Harvard, presso il Center for European Studies: ho poi ‘spezzato’ la borsa in due periodi, passando inizialmente circa sei mesi a Cambridge e poi, dopo una interruzione, tornando per altri sei mesi. Nel frattempo, infatti, era maturata la possibilità di insegnare ad Ancona presso la Facoltà di Economia. Prima della mia partenza per gli States mi era stato detto che quando si va a studiare all’estero non si deve pretendere di analizzare in modo esaustivo e comprendere in poco tempo fenomenologie complesse che caratterizzano quel paese; piuttosto più proficuo si poteva rivelare l’approfondimento delle proprie analisi e dei propri studi condotti fino a quel momento ed eventualmente procedere ad alcune comparazioni. Io, invece, decisi di studiare il welfare americano, in particolare il rapporto fra politiche di assistenza alle persone disoccupate e loro comportamenti nel mercato del lavoro. Parliamo di fine anni ’70 e si aprirono così ai miei occhi fenomeni ancora poco o affatto conosciuti a quei tempi in Italia: un esempio su tutti, le problematiche relative ai working poor, già studiate negli Stati Uniti. L’idea di povertà che mi portavo dietro dall’Italia era collegata soprattutto alla mancanza di lavoro: scoprivo invece come molte persone, pur lavorando, non riuscivano ad oltrepassare la soglia di povertà! . Spesso gli Stati Uniti offrono panorami e scenari socio-economici, ma anche culturali, che tendono a manifestarsi più tardi in altri paesi, fra cui il nostro. Al Center for European Studies si stava proprio bene: era presente un piccolo un gruppo di studiosi italiani anche perché il direttore del programma in quei tempi era Peter Lange. Peter studiava da tempo le relazioni industriali nei paesi europei, con particolare riferimento al nostro paese, insieme a Marino Regini ed aveva anche una buona familiarità con la nostra lingua. Ho ancora il ricordo dei lunch del venerdì al Center for European Studies, frequentati da altri studiosi di Harvard o di altre università dell’area. Ti potevi trovare per caso a pranzare e discutere con persone del calibro di Barrington Moore: si potevano così realizzare scambi di grande interesse. Tornando alla ricerca, in quel periodo cercavo di comprendere il funzionamento del welfare americano soprattutto rispetto al mercato del lavoro: come e quando i soggetti pubblici dovevano sostenere le persone in difficoltà, con quali conseguenze sul loro inserimento in attività lavorative. L’interrogativo cui dovevano rispondere i ‘social experiments’ condotti in diverse località del paese era se l’assistenza pubblica avrebbe o meno indebolito l’etica del lavoro, ovvero la ricerca di una occupazione da parte dell’assistito. A partire proprio da tali tematiche pubblicai poi un saggio su Welfare e mercato del lavoro negli Stati Uniti, che contribuì, credo, ad arricchire il dibattito italiano: ricordo ancora con piacere i commenti positivi e gli apprezzamenti di Guido Romagnoli.
Dopo il periodo negli Stati Uniti torni ad Ancona. A quel punto su che cosa si è concentrata la tua attenzione?
Sollecitato dall’esperienza statunitense, mi dedicai a due filoni di ricerca. Il primo riguardava gli attori che intervenivano nel campo del welfare e iniziai a studiare, fra i primi in Italia, anche su suggerimento di Massimo Paci, quei soggetti che poi successivamente verranno definiti “terzo settore”. Massimo mi spinse a riflettere sull’azione volontaria. Il secondo riguardava una ricognizione di ampio respiro sulle caratteristiche e sulle trasformazioni del sistema di welfare italiano.
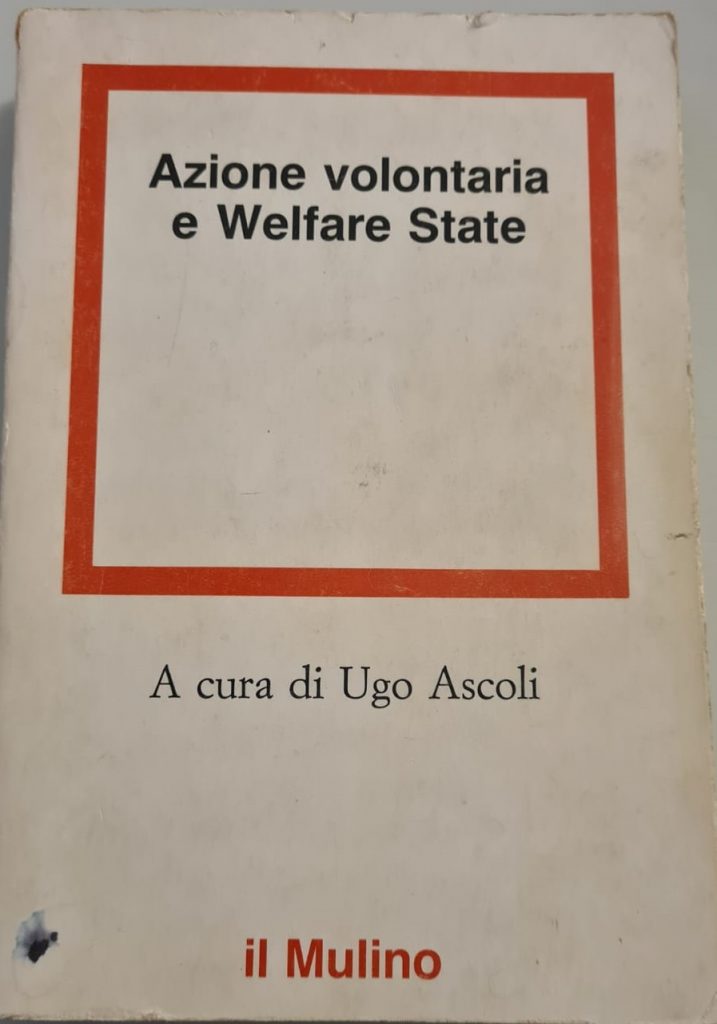 Le tematiche del terzo settore, del welfare mix e del welfare system hanno accompagnato dai primi anni ’80 una buona parte del mio successivo percorso di studi e di ricerche. Il mio secondo periodo all’estero nella prima parte degli anni ’80, fu sostanzialmente ispirato dalla volontà di comprendere meglio le caratteristiche del terzo settore. Scelsi di andare in Australia ed ottenni una borsa di studio del Ministero degli Esteri per l’Università di Adelaide. In quegli anni in genere ci si recava a studiare nei paesi Anglo-Sassoni, quasi esclusivamente in Gran Bretagna o negli Stati Uniti Io decisi diversamente e con la famiglia ci trasferimmo per un anno ad Adelaide: Laura Balbo mi aveva parlato molto bene delle università australiane. Partii assai incuriosito, convinto comunque che trattandosi di un paese anglosassone economicamente avanzato, avrei potuto continuare a studiare e a fare ricerche sul rapporto fra welfare e azione volontaria, confrontandomi da vicino con gli studi e la letteratura di riferimento, così come con centri di ricerca di grande rilievo. Ho scritto un primo saggio di literature review sul tema e poi ho stretto legami con il Social Welfare Research Center della Università di Sydney, dove ho potuto incontrare studiosi di grande spessore. Ricordo di aver tratto grande giovamento in particolare dalle pubblicazioni di Adam Graycar e di Ralph Kramer, fra i massimi studiosi anglosassoni sulle tematiche oggetto delle mie ricerche. Presi così ad organizzare il mio lavoro, approfondendo la conoscenza delle caratteristiche delle diverse organizzazioni del terzo settore. Quando tornai dall’Australia curai per il Mulino una antologia sull’Azione Volontaria, portando dentro il dibattito italiano il tema delle organizzazioni di terzo settore quali attori strategici del ‘welfare mix’, come lo avremmo chiamato un decennio dopo in un volume curato da me e da Costanzo Ranci.
Le tematiche del terzo settore, del welfare mix e del welfare system hanno accompagnato dai primi anni ’80 una buona parte del mio successivo percorso di studi e di ricerche. Il mio secondo periodo all’estero nella prima parte degli anni ’80, fu sostanzialmente ispirato dalla volontà di comprendere meglio le caratteristiche del terzo settore. Scelsi di andare in Australia ed ottenni una borsa di studio del Ministero degli Esteri per l’Università di Adelaide. In quegli anni in genere ci si recava a studiare nei paesi Anglo-Sassoni, quasi esclusivamente in Gran Bretagna o negli Stati Uniti Io decisi diversamente e con la famiglia ci trasferimmo per un anno ad Adelaide: Laura Balbo mi aveva parlato molto bene delle università australiane. Partii assai incuriosito, convinto comunque che trattandosi di un paese anglosassone economicamente avanzato, avrei potuto continuare a studiare e a fare ricerche sul rapporto fra welfare e azione volontaria, confrontandomi da vicino con gli studi e la letteratura di riferimento, così come con centri di ricerca di grande rilievo. Ho scritto un primo saggio di literature review sul tema e poi ho stretto legami con il Social Welfare Research Center della Università di Sydney, dove ho potuto incontrare studiosi di grande spessore. Ricordo di aver tratto grande giovamento in particolare dalle pubblicazioni di Adam Graycar e di Ralph Kramer, fra i massimi studiosi anglosassoni sulle tematiche oggetto delle mie ricerche. Presi così ad organizzare il mio lavoro, approfondendo la conoscenza delle caratteristiche delle diverse organizzazioni del terzo settore. Quando tornai dall’Australia curai per il Mulino una antologia sull’Azione Volontaria, portando dentro il dibattito italiano il tema delle organizzazioni di terzo settore quali attori strategici del ‘welfare mix’, come lo avremmo chiamato un decennio dopo in un volume curato da me e da Costanzo Ranci.
Il secondo tema che mi vide fortemente attivo nei primi anni ’80 fu quello delle trasformazioni e delle caratteristiche del welfare italiano. Fra fine anni ’70 e l’inizio del decennio successivo stavano maturando i primi studi su vari comparti del Welfare State (dalle politiche del lavoro a quelle assistenziali). Ricordo, ad esempio, le importanti riflessioni di Laura Balbo, che parlava di Stato assistenziale. Tuttavia, allora non c’era ancora un inquadramento complessivo del sistema di welfare italiano. Pensai così di formare un gruppo di studiosi che si riunisse e ragionasse insieme sul tema. Chiesi di farne parte a Massimo Paci, a Gloria Regonini, a Ida Regalia, a Gian Primo Cella, ad Antonio Tosi, a Paolo Trivellato, a Patrizia David, a Aldo Piperno ed allo scienziato delle finanze Ernesto Longobardi. Pensai poi ad un percorso di lavoro caratterizzato dalla condivisone di una metodologia di ricerca ed arricchito da scambi ed incontri in cui ciascuno avrebbe riferito sui suoi working progress. Non volevo comporre una classica antologia in cui ciascuno scriveva il suo pezzo ed il curatore avrebbe poi curato una introduzione. Volevo che il gruppo crescesse insieme sulla ricerca: abbiamo organizzato un seminario ad Ancona cui hanno partecipato tutti. Abbiamo discusso insieme l’approccio di ciascuno con l’idea di arrivare a delineare e condividere un quadro complessivo. Tutto ciò è stato estremamente arricchente sia dal punto di vista umano che da quello scientifico.
A proposito di questa ultima ricerca, ci racconti quale è stata la genesi di uno dei termini che ancora oggi spesso si associa al sistema di politiche sociali nel nostro paese: “welfare state all’Italiana”?
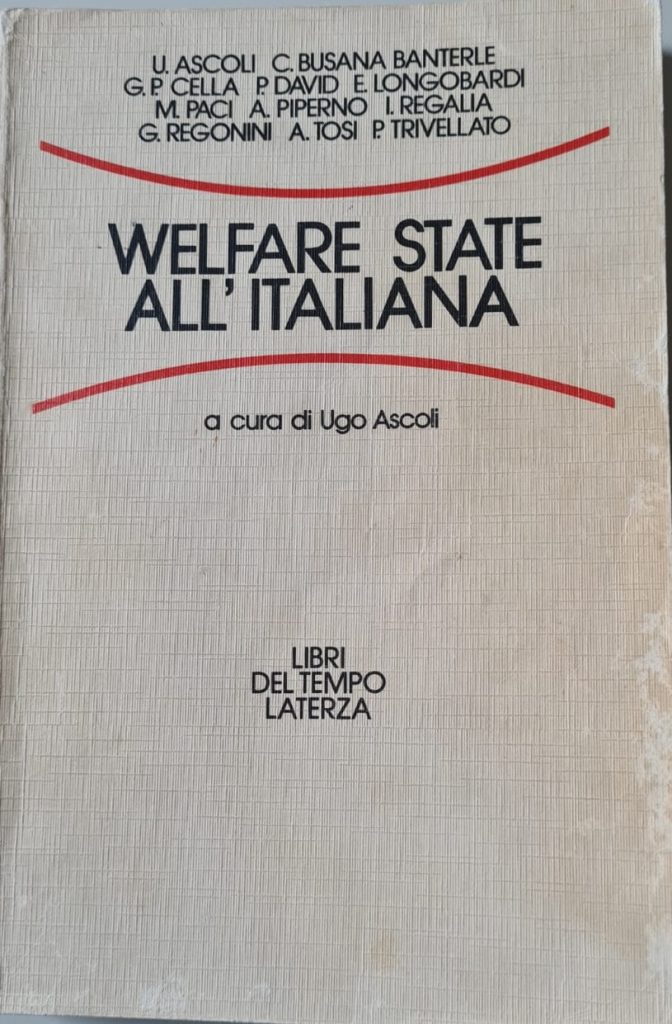 Quando sono partito per l’Australia il libro era stato ormai consegnato alla Laterza ma non sapevo come sarebbe stato intitolato. Tant’è vero che avevo escogitato i soliti titoli ridicoli e noiosi per un editore: volevo che comparissero le parole “welfare”, “Italia”, “trasformazione” e poi tutta una serie di altri riferimenti che avrebbero certamente reso il titolo del libro lungo e noioso per i non addetti ai lavori. Mentre ero in Australia, mi arriva la proposta dell’editore Laterza di intitolarlo “welfare state all’italiana”. Mi ricordo che in quel momento mi arrabbiai moltissimo, perché ero tutto preso dal discorso scientifico e pensavo dovessero esserci riferimenti precisi già dal titolo. Quando lessi per la prima volta la proposta dell’editore pensai: “sembra il titolo di un film ‘spaghetti western!”. Ero veramente contrariato, ma feci buon viso a cattivo gioco, dal momento che, come è noto, è l’editore ad avere l’ultima parola sui titoli. Tale titolazione è stata invece caratterizzata da un grande successo comunicativo, il cui merito va interamente attribuito alla Laterza.
Quando sono partito per l’Australia il libro era stato ormai consegnato alla Laterza ma non sapevo come sarebbe stato intitolato. Tant’è vero che avevo escogitato i soliti titoli ridicoli e noiosi per un editore: volevo che comparissero le parole “welfare”, “Italia”, “trasformazione” e poi tutta una serie di altri riferimenti che avrebbero certamente reso il titolo del libro lungo e noioso per i non addetti ai lavori. Mentre ero in Australia, mi arriva la proposta dell’editore Laterza di intitolarlo “welfare state all’italiana”. Mi ricordo che in quel momento mi arrabbiai moltissimo, perché ero tutto preso dal discorso scientifico e pensavo dovessero esserci riferimenti precisi già dal titolo. Quando lessi per la prima volta la proposta dell’editore pensai: “sembra il titolo di un film ‘spaghetti western!”. Ero veramente contrariato, ma feci buon viso a cattivo gioco, dal momento che, come è noto, è l’editore ad avere l’ultima parola sui titoli. Tale titolazione è stata invece caratterizzata da un grande successo comunicativo, il cui merito va interamente attribuito alla Laterza.
Terminata l’esperienza australiana, che cosa è successo?
Prima che partissi per l’Australia stavano prendendo il via i concorsi nazionali di prima fascia per professore ordinario. Io avevo deciso di non fare domanda. Ma l’Università italiana non finiva mai di sorprenderti (allora come oggi): quando tornai dall’Australia (erano anni in cui non esisteva la posta elettronica ed il telefono si usava poco), scoprii con stupore che ancora non si erano chiusi i termini per fare domanda per il concorso nazionale. Spinto da Massimo Paci, anche alla luce dei lavori portati avanti nel periodo australiano e delle pubblicazioni conseguenti, decisi di fare domanda. Vinsi il concorso e dopo un primo momento di incertezza se sarebbe stata l’università di Teramo o quella di Messina a ‘chiamarmi’, andai ad occupare la cattedra della Facoltà di Scienze Politiche di Messina, dove trovai un gruppo assai interessante di persone che si occupavano di studi sociologici. Ricordo ancora i viaggi dei primi tempi: per raggiungere Messina partivo la domenica pomeriggio da Ancona in treno, raggiungevo Roma, da qui prendevo un treno notturno che il giorno dopo arrivava in Sicilia. Sia gli anni ad Arcavacata che quelli a Messina mi hanno aiutato molto a crescere: ho conosciuto persone e colleghi davvero di grande rilievo.
Agli inizi degli anni ’90 tornai definitivamente nelle Marche all’Università di Ancona nella facoltà di Economia, dove sono rimasto fino al pensionamento. Tornato ad Ancona Massimo Paci ed io avevamo preso ad insegnare Sociologia Economica al primo anno del percorso di laurea. Mi ricordo che utilizzavamo un manuale di storia del pensiero sociologico, “Capitalismo e teoria sociale” di Anthony. Giddens ed il corso era interamente su Marx, Durkheim e Weber. Il libro non era di facile comprensione per gli studenti di economia, pochi dei quali provenienti dai licei, ma molti finivano poi per apprezzarlo.
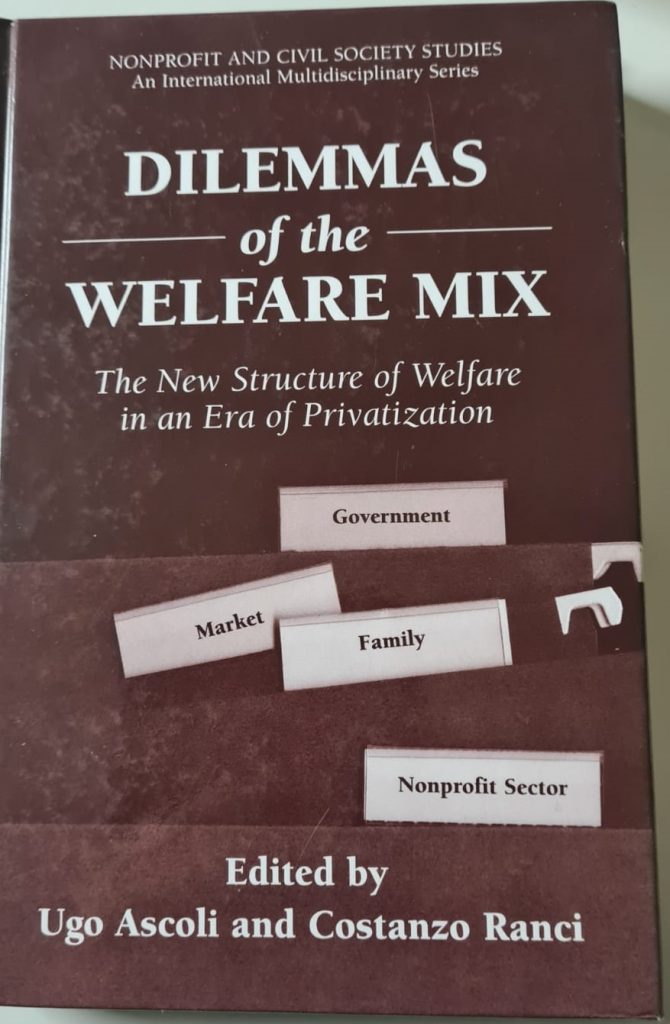 Sotto il profilo della ricerca quelli furono gli anni in cui dedicai gran parte del mio tempo allo studio del ‘welfare mix’ approfondendo in ottica comparata, le questioni riguardanti soprattutto il volontariato e la cooperazione sociale. Dopo alcuni anni curai con Costanzo Ranci un volume sul tema, con molti contributi di studiosi stranieri. Venni successivamente in contatto su tali tematiche con il Centro creato da Lester Salamon presso la Johns Hopkins University a Baltimora e nel 1997 mi trasferii per un semestre presso quel Centro, insegnando e facendo ricerca.
Sotto il profilo della ricerca quelli furono gli anni in cui dedicai gran parte del mio tempo allo studio del ‘welfare mix’ approfondendo in ottica comparata, le questioni riguardanti soprattutto il volontariato e la cooperazione sociale. Dopo alcuni anni curai con Costanzo Ranci un volume sul tema, con molti contributi di studiosi stranieri. Venni successivamente in contatto su tali tematiche con il Centro creato da Lester Salamon presso la Johns Hopkins University a Baltimora e nel 1997 mi trasferii per un semestre presso quel Centro, insegnando e facendo ricerca.
Ritornato in Facoltà, svolsi per un triennio le funzioni di Preside; poi, per quasi un decennio (fino al 2008), ho dedicato il mio impegno soprattutto a compiti istituzionali presso l’Ente Regione, prima in qualità di Consigliere Regionale, quindi come Assessore.
Quindi, se sei stato lontano per quasi un decennio dalla ricerca accademica, una volta tornato all’università nel 2008, a cosa hai deciso di dedicare l’attenzione?
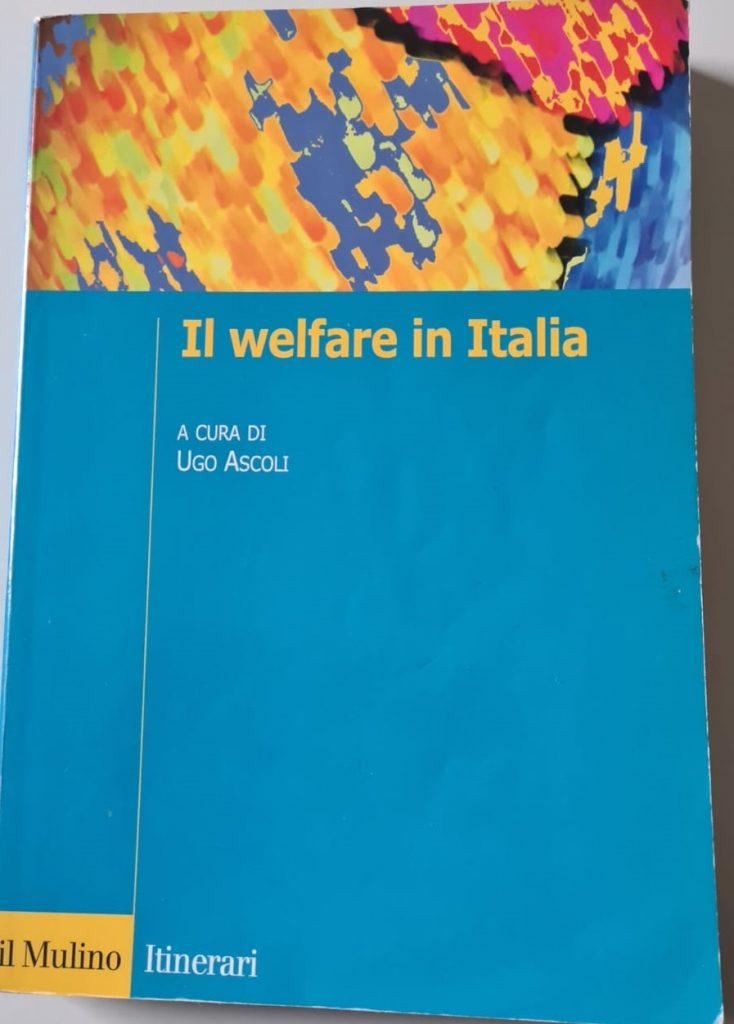 Ho ripreso in mano gli studi di comparazione e ho pensato di poter replicare in qualche modo il modello che avevo messo a punto quando avevo curato “Welfare state all’italiana”. Di conseguenza ho contattato una serie di autori e di studiosi per ricostruire il modello di welfare italiano a trent’anni di distanza e metterne in luce i principali cambiamenti. Da qui è nato il volume pubblicato con Il Mulino, intitolato “Il welfare in Italia”. È stato un lavoro assai interessante: ci ha consentito di evidenziare le principali trasformazioni delle politiche e soprattutto di confrontare il modello italiano con i paesi europei.
Ho ripreso in mano gli studi di comparazione e ho pensato di poter replicare in qualche modo il modello che avevo messo a punto quando avevo curato “Welfare state all’italiana”. Di conseguenza ho contattato una serie di autori e di studiosi per ricostruire il modello di welfare italiano a trent’anni di distanza e metterne in luce i principali cambiamenti. Da qui è nato il volume pubblicato con Il Mulino, intitolato “Il welfare in Italia”. È stato un lavoro assai interessante: ci ha consentito di evidenziare le principali trasformazioni delle politiche e soprattutto di confrontare il modello italiano con i paesi europei.
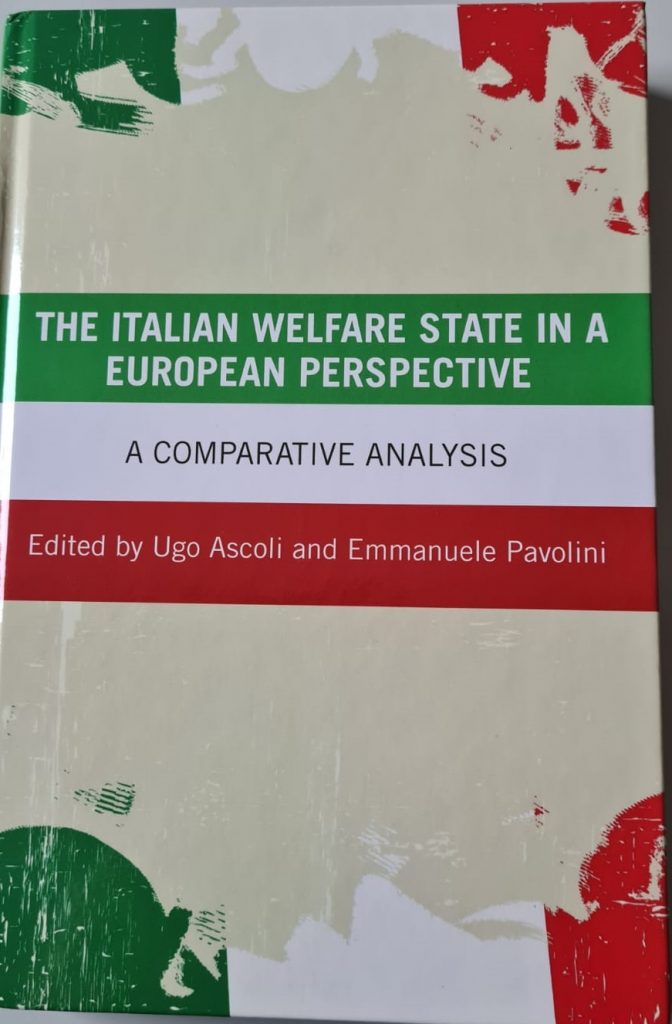 Qualche anno dopo con Emmanuele Pavolini abbiamo rivisto e aggiornato il volume e ne abbiamo curato una edizione in lingua inglese, dove la parte comparativa ha occupato uno spazio ancora più significativo. Il lavoro di ricerca negli anni successivi e praticamente per tutto il decennio passato si è concentrato su quattro temi: il social investment in ottica italiana; il terzo settore; il welfare occupazionale; il welfare fiscale. Per quanto riguarda il primo tema, grazie ad un PRIN, è stato possibile sviluppare un ragionamento sulla possibilità di vedere realizzato un modello di social investment nel nostro paese. Il libro che ne è uscito ci ha permesso di comprendere i punti di forza, ma anche i numerosi limiti di tale approccio, soprattutto una volta applicato ad un contesto socio-economico ed istituzionale come quello italiano: il lavoro di squadra coinvolse molti ricercatori e ricercatrici (da Gianni Sgritta a Dora Gambardella, da Costanzo Ranci a Yuri Kazepov) e giunse a concludere come fosse assai difficile pensare di portarsi in Italia su quella frontiera, viste le numerose problematiche irrisolte sia sul fronte dei “vecchi rischi sociali” che dei “nuovi” , tenuto anche conto della scarsa capacità redistributiva del welfare italiano.
Qualche anno dopo con Emmanuele Pavolini abbiamo rivisto e aggiornato il volume e ne abbiamo curato una edizione in lingua inglese, dove la parte comparativa ha occupato uno spazio ancora più significativo. Il lavoro di ricerca negli anni successivi e praticamente per tutto il decennio passato si è concentrato su quattro temi: il social investment in ottica italiana; il terzo settore; il welfare occupazionale; il welfare fiscale. Per quanto riguarda il primo tema, grazie ad un PRIN, è stato possibile sviluppare un ragionamento sulla possibilità di vedere realizzato un modello di social investment nel nostro paese. Il libro che ne è uscito ci ha permesso di comprendere i punti di forza, ma anche i numerosi limiti di tale approccio, soprattutto una volta applicato ad un contesto socio-economico ed istituzionale come quello italiano: il lavoro di squadra coinvolse molti ricercatori e ricercatrici (da Gianni Sgritta a Dora Gambardella, da Costanzo Ranci a Yuri Kazepov) e giunse a concludere come fosse assai difficile pensare di portarsi in Italia su quella frontiera, viste le numerose problematiche irrisolte sia sul fronte dei “vecchi rischi sociali” che dei “nuovi” , tenuto anche conto della scarsa capacità redistributiva del welfare italiano.
Per l’approfondimento sui temi del terzo settore e del volontariato ci siamo giovati io, Emmanuele Pavolini e altri della possibilità di collaborare con alcune associazioni importanti che facevano parte della CONVOL ((la Conferenza delle organizzazioni di volontariato). Abbiamo così potuto godere di un punto di osservazione privilegiato: abbiamo lavorato fianco a fianco con queste organizzazioni per comprendere come effettivamente esse stessero cambiando rispetto ai decenni precedenti. Abbiamo investigato su come il volontariato si fosse radicato nelle regioni meridionali, come si stesse trasformando assumendo parvenze sempre più ‘ibride’ e come la dimensione ‘politica’ e quella identitaria stessero perdendo terreno rispetto a quella di fornitura di servizi.
Sempre durante il decennio ho riacceso il mio interesse per i lavori e le analisi di Titmuss: ho così dedicato molto tempo a studiare le forme di “welfare occupazionale” e di “welfare fiscale” realizzatesi nel nostro paese. Tali fenomenologie, fino ad allora poco o punto investigate in Italia, appaiono ormai destinate a giocare un ruolo assai significativo nel sistema di welfare nazionale.
Anche al fine di illuminare possibili scenari nazionali ho dedicato il tempo del mio sabbatico del 2015 negli Stati Uniti, presso la City Univesity of New York, a studiare l’evoluzione del welfare occupazionale americano nel settore previdenziale.
Pertanto, accanto alla tua carriera scientifica, hai affiancato anche sia l’impegno dentro l’università in funzione di gestione che quello politico-istituzionale. Ci racconti le tue esperienze in tal senso?
Fra la fine degli anni ‘80 ed il 2008, praticamente quasi un ventennio, sono stato impegnato anche al di fuori della ricerca e della didattica.
Innanzitutto, ho fatto parte della famosa Commissione Gorrieri, istituita da Bettino Craxi quando era Presidente del Consiglio. In quella sede studiammo soprattutto il sistema pensionistico italiano. Poi negli anni ’90 sono stato eletto nell’Osservatorio Nazionale del Volontariato ed ho affiancato i lavori del Ministero guidato da Livia Turco che hanno condotto alla legge 328/00 sul ‘Sistema integrato degli interventi e servizi sociali’.
Nei primi anni ‘90 ho fatto parte per tre anni del Consiglio di Amministrazione dell’INPS: la CGIL mi aveva chiesto di farne parte in quanto studioso del welfare. Lavorare dentro l’INPS rappresentava un’ottima opportunità per affinare le mie conoscenze sull’hardware’ del sistema italiano di protezione sociale ed osservarne le caratteristiche dall’interno. Quando entrai, vigeva ancora la regola per cui nel Consiglio d’amministrazione vi fosse un spazio di maggioranza riservato ai rappresentanti sindacali: in quel periodo la Cgil aveva deciso di modificare i criteri con i quali sceglieva i propri rappresentanti da inviare nel Consiglio, dando spazio non solo a sindacalisti ma anche ad alcuni studiosi. Furono anni interessanti perché mi ritrovai, fra gli altri, a collaborare con personalità di rilievo come Marco D’Alberti e Giulio Tremonti, anche loro nel Consiglio. Il nostro mandato era quello di aiutare la grande macchina dell’Inps ad intraprendere un percorso efficace verso la modernizzazione, investendo di più nelle tecnologie e nel capitale umano. Credo che nell’ultimo trentennio l’INPS abbia fatto grandi passi avanti sotto il profilo strettamente organizzativo e sono contento di aver contribuito a ciò, insieme a tanti altri. L’esperienza in INPS mi ha fatto conoscere da vicino questa macchina straordinaria: ho potuto verificare da vicino come funzionasse l’organizzazione ed ho imparato molto, Nell’ultimo triennio degli anni ’90, come già ricordato, sono stato Preside della Facoltà di Economia e Commercio di Ancona: tre anni impegnativi, anche perché dispiegatisi durante la fase di passaggio dalla sede storica della Facoltà presso il “Palazzo degli Anziani” alla nuova sede presso la ex-caserma “Villarey”. Debbo dire che fare il Preside di Facoltà, come fare il Direttore di Dipartimento, è un passaggio che consiglio ai più giovani. È l’occasione per immergersi nell’università e comprenderne i complessi meccanismi di funzionamento, che magari a molti, anche fra i professori ordinari, sfuggono in quanto assorbiti completamente dalle proprie ricerche e dalla didattica. In tre anni da Preside sono fiero anche di non aver ridotto minimamente il mio carico didattico. Ho continuato a svolgere tutti i miei corsi, correndo fra una riunione in presidenza e una lezione in aula. Alla fine del mio mandato mi sono candidato a Rettore. La campagna ‘elettorale’ che ho svolto presso i colleghi con grande intensità è stata anch’essa una esperienza interessante: mi ha fatto capire ancora meglio la complessità, così come le opacità che possono celarsi dentro un mondo articolato come quello accademico. La corsa a rettore, che purtroppo non vinsi, mi ha permesso di comprendere meglio due cose: la frammentazione degli interessi dei docenti e la delicatezza della posizione di potere del Rettore, specie in una città di piccole e medie dimensioni. Avevo impostato tutta la mia campagna elettorale sul tema della partecipazione e del coinvolgimento dal basso di tutte le componenti dell’università rispetto ad una situazione che era oggettivamente più verticistica. Su questa base avevo raccolto apparentemente molto consenso; tuttavia, con il senno di poi, ho capito come parlare soprattutto di democrazia e partecipazione e meno di carriere, di risorse e di attribuzione di posizioni, non dia necessariamente i risultati sperati! Mi resi poi conto come in molte città italiane, soprattutto in quelle di medie e medio-piccole dimensioni, le università costituiscano importanti poli di sviluppo e quindi rappresentino posizioni di potere molto ambite nel territorio. Le dinamiche che si instaurano in una competizione a rettore si intrecciano con le dinamiche sociali e politiche più ampie di quel territorio, che vedono coinvolte diverse lobbies e gruppi di pressione.
Poco dopo che si era chiusa la corsa a Rettore, si è aperta per me una nuova esperienza di tipo istituzionale. Come già ricordato, avevo contribuito a livello nazionale ai lavori sotto la regia di Livia Turco, che condussero alla L. 328/00 ed avevo curato il primo Piano Sociale della Regione Marche alla fine degli anni novanta. Non avevo mai avuto la tessera di un partito: un giorno si presentò nel mio studio universitario una rappresentante dell’’Asinello’ (il raggruppamento politico dei Democratici di Prodi e Parisi) accompagnata da un collega della Facoltà e mi chiese la disponibilità a candidarmi per le elezioni regionali come ‘indipendente’ con la coalizione di Centro-Sinistra. Sarei entrato a far parte di quello che allora si chiamava il ‘Listino’ del candidato Presidente, un gruppo di persone che sarebbero state elette qualora quel candidato fosse stato scelto dagli elettori come Presidente della Regione. In questa direzione mi spingevano sia alcuni colleghi in facoltà che alcuni amici ed alcune amiche già impegnati in politica, che conoscevano le mie posizioni politiche, sempre a sinistra e con il sindacato. Accettai la proposta anche perché si apriva la prospettiva di poter incidere sull’implementazione del Piano Sociale regionale, che io stesso avevo contribuito largamente a scrivere. La mia idea era quella appunto di dedicarmi, una volta eletto, ai servizi sociali ed al welfare. Erano anni di grandi speranze di cambiamento, e fiorivano le iniziative. Si discuteva in buona parte d’Italia su come realizzare una nuova ‘generazione’ di interventi e prestazioni sociali e su come promuovere una più efficace collaborazione fra le amministrazioni locali ed il terzo settore. Poter lavorare su questi temi in qualità di amministratore regionale rappresentava la sintesi del mio percorso, anche di tipo scientifico, dato che di welfare e di terzo settore mi occupavo da decenni. Quando il centro-sinistra vinse le elezioni, diventai prima Consigliere regionale e poi, dopo due anni, Assessore regionale. Tuttavia, l’insieme delle deleghe che ricevetti come assessore non comprendevano quelle ai servizi sociali, bensì quelle al lavoro e alla gestione del personale della Regione, e quindi, successivamente, anche all’istruzione e alla formazione professionale.
Complessivamente il mio servizio in politica è durato dal 2000 al 2008 e per sei anni ho fatto l’Assessore con grandi soddisfazioni sul piano umano e politico. La Regione Marche è stata la prima Regione – e lo rivendico con orgoglio – che si è dotata di una legge regionale sulle politiche del lavoro: ha fatto da battistrada per molte Regioni. Sono stato impegnato a fondo per tre anni su questo tema, lavorando bene anche con molti altri assessori al lavoro di altre Regioni, soprattutto di centro-sinistra, ma anche di centro-destra. Ero periodicamente a Roma per le riunioni della Conferenza degli Assessori Regionali; di tanto in tanto a Brussels per la partita dei fondi di coesione dell’UE. Altro tema su cui mi sono speso molto come Assessore è stato quello dell’istruzione. Anche qui avevo aperto tavoli di discussione con il mondo della scuola nelle sue variegate forme di rappresentanza ed avevo portato avanti il progetto di una legge regionale sul tema. Purtroppo, non riuscii a completare l’opera, come invece ero riuscito a fare con la legge sulle politiche del lavoro, perché improvvisamente il mio servizio in politica si concluse: il Presidente della Regione dopo tre anni di legislatura decise un rimpasto per motivi che avevano a che fare soprattutto con equilibri politici locali. Nella nuova giunta non era prevista la mia presenza.
Nel 2008 sono quindi tornato all’università e da lì fino alla pensione nel 2019 ho deciso di concentrarmi solo sulle attività di ricerca, di didattica e di quella che oggi chiameremmo “terza missione”.
Per molti ricercatori nelle scienze sociali e politiche si pone il tema di quanto la ricerca possa, debba o non debba essere collegata a un proprio impegno in un’arena politica, al di là delle mura dell’accademia. Alla luce delle numerose e profonde esperienze che hai fatto in tal senso, consiglieresti a una giovane sociologa o a un giovane sociologo bravo a far ricerca di impegnarsi in politica oppure gli suggeriresti che è meglio che continui a far ricerca?
Il mio servizio in politica mi ha messo in contatto con realtà che pensavo di conoscere dall’esterno, magari tramite i miei studi: ho imparato invece come ‘funzionano’ i meccanismi della politica nella pratica, fra gestione del potere e rapporti fra partiti ed ho spesso notato poche differenze a seconda dell’appartenenza partitica. Mi rendo conto di proporre una visione pessimistica. ma ho potuto constatare come spesso prevalga una modalità davvero imbarazzante nella gestione del potere e del sottopotere locale. I meccanismi sovente non si differenziano a seconda dell’appartenenza partitica. Complessivamente, consiglierei ad un giovane sociologo o sociologa di non scegliere una esperienza politica diretta: indubbiamente si impara molto sul concreto funzionamento della politica, si possono approfondire anche tematiche sulle quali si sta facendo ricerca (ad esempio, io ho imparato tanto sulle politiche del lavoro). Allo stesso tempo però il prezzo da pagare è alto: in quel periodo non si riesce più a studiare ed alla fine, a meno che una persona non sia un politico organico ad una formazione politica, in grado di aggregare consenso e voti, e poi uno studioso (ma non il contrario), si è sempre considerati come ‘outsider’ aggregati provvisoriamente, magari stimati, ma mai considerati fino in fondo “parte del gruppo e del partito”. Io stesso raccolsi certamente la stima di alcuni ambienti, ma sono stato sempre visto come un personaggio estraneo ai giochi della politica, capitato quasi per caso in quel campo di gioco.
Per una persona che vuole studiare, fare ricerche e insegnare è meglio stare fuori dalla politica attiva e invece magari cercare di influenzarla con i risultati del proprio lavoro, anche se ciò non accade spesso. Come sosteneva il mio amico Gianni Sgritta, occorre fare ricerca anche per offrire soluzioni e risposte alle domande sociali: poi starà alla politica usare come ritiene opportuno quanto la ricerca produce. In Italia, come è noto, molte volte si è dato il caso di Commissioni composte da ottimi studiosi che hanno raggiunto conclusioni di rilevo nelle materie indagate: ebbene il più delle volte tali risultati sono finiti nei cassetti. Insomma è difficile in Italia influenzare le politiche tramite lo strumento della ricerca scientifica Mi è sempre sorto il dubbio che tale difficoltà sia più accentuata nel nostro paese rispetto ad altri contesti occidentali. Le mie esperienze negli USA e in Australia mi diedero l’impressione che lì gli esperti venissero presi più seriamente in considerazione di quanto avveniva ed avviene da noi. Quindi concludendo, suggerirei ad un giovane studioso che voglia farsi le ossa come studioso di rimanere al di fuori della politica attiva, non della politica come arte ‘nobile’ del governo e della riflessione sulla res publica, cercando di aiutare i decisori con i risultati delle proprie ricerche.
Ultima domanda. Tu hai fatto una brillante bella carriera come studioso, sei stato uno studioso apprezzato e ti sei impegnato in politica in varia maniera. Una parte del tuo tempo lo hai però dedicato anche al rapporto con la società civile e con il sindacato. Quale è la tua valutazione invece del collaborare da studioso insieme al terzo settore e il sindacato?
Su questo aspetto la mia valutazione è più ottimista. Devo dire che lavorando con i soggetti del terzo settore e con il sindacato ho ricavato forti soddisfazioni. Spesso con queste realtà si fa un lavoro di “ricerca-azione”, che consente di fare ricerca giovandosi della collaborazione di chi sta sul campo, o di formazione. Ricordo di aver partecipato anche con responsabilità organizzative a molti corsi di formazione. Abbiamo anche dato vita ad esperimenti innovativi come quello che venne messo in piedi alla Cgil ai tempi di Trentin: si prevedevano corsi residenziali per delegati sindacali, con i quali non si faceva solo un approfondimento sulle tematiche importanti per il sindacato: si organizzavano ragionamenti e riflessioni con un approccio culturale a tutto campo. Accanto alle lezioni ed ai momenti formativi in senso stretto, c’erano spettacoli teatrali, concerti, incontri con scrittori, distribuzione e discussione di libri. Ugualmente ho fatto esperienze assai interessanti di formazione con il volontariato, soprattutto nel Sud Italia, in cui cercavamo di aiutare i quadri delle organizzazioni della società civile a migliorare la propria preparazione su varie tematiche. Consiglierei certamente tali esperienze a chi porta avanti un percorso nelle scienze sociali: ti arricchiscono moltissimo dal punto di vista esperienziale, ti aiutano a comprendere le dinamiche sociali, culturali e politiche delle fenomenologie oggetto dei propri studi.