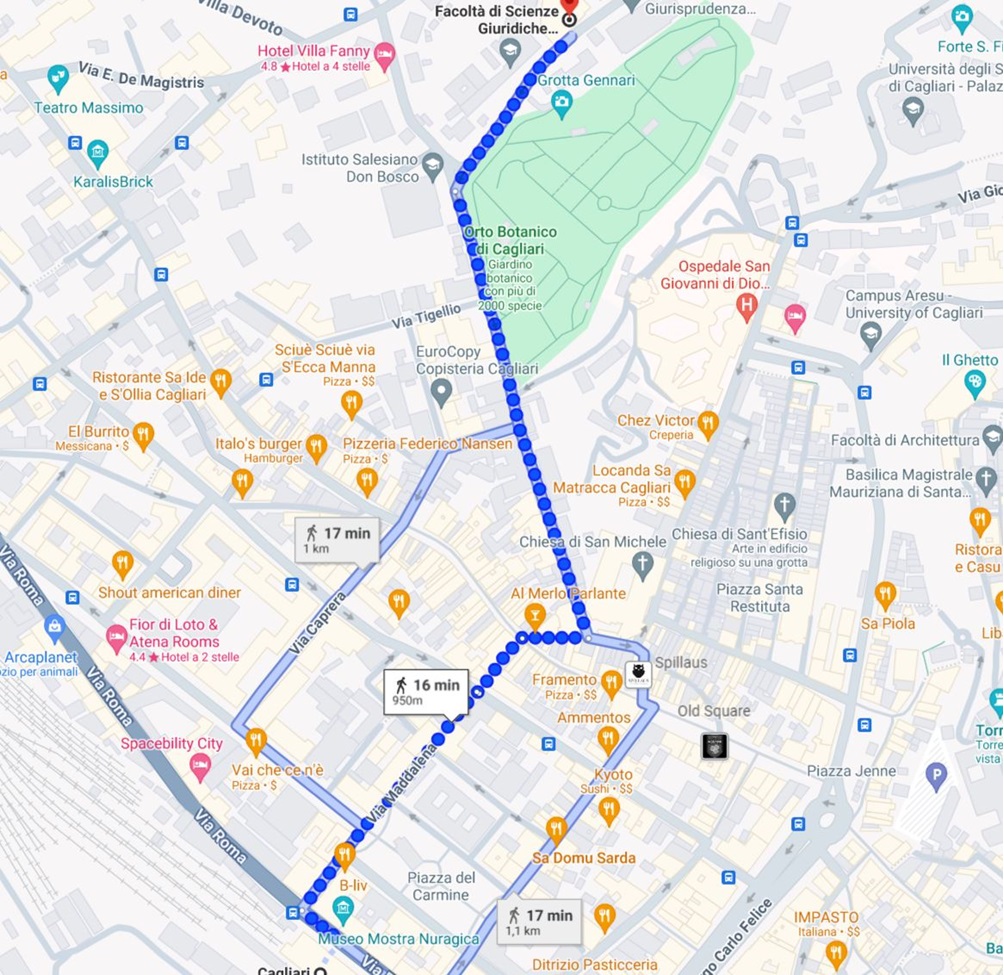VISIBILI E INVISIBILI NEL CAPITALISMO CHE CAMBIA:
IMPRESE, LAVORO, TERRITORI E POLITICHE
Anche quest’anno abbiamo scelto una coppia concettuale su cui riflettere come tema del convegno: visibili e invisibili nel capitalismo che cambia, con riferimento a imprese, lavoro, territori e politiche.
Le transizioni gemelle – digitale e ambientale – stanno rendendo sempre più centrali e visibili nell’economia globale le grandi imprese multinazionali che sviluppano innovazioni radicali, spesso però con modalità di governance e di organizzazione del lavoro poco trasparenti. Tra le recenti innovazioni, la diffusione delle piattaforme digitali e la disponibilità di tecnologie di intelligenza artificiale generativa hanno riproposto il dibattito sui rischi di automazione dei posti di lavoro e sulla possibile creazione di nuovi lavori. Allo stesso tempo, il binomio visibili e invisibili è un’utile chiave di lettura per l’analisi di settori più tradizionali, delle piccole e medie imprese e delle reti che tra esse si creano. Queste trasformazioni possono generare soluzioni innovative orientate alla sostenibilità sociale e ambientale oppure acuire le criticità legate a sfide demografiche, particolarmente evidenti nel mondo del lavoro in termini di invecchiamento della popolazione attiva e incertezza nel rapporto tra giovani e lavoro.
Il dibattito è concentrato su lavori e lavoratori molto visibili, mentre molti altri restano invisibili perché svolgono lavori nascosti, pericolosi, sporchi, in orari non convenzionali, con contratti irregolari o in settori poco regolamentati. Le loro storie e le loro voci restano invisibili anche perché non riescono a esercitare un’azione collettiva efficace e a far valere la loro voce in anni di progressivo indebolimento delle forme tradizionali di rappresentanza degli interessi. Cresce così il ruolo della regolazione di mercato, spesso descritto come una “mano invisibile”, che ha invece delle evidenti e ben visibili conseguenze in termini di disuguaglianza. Le dinamiche di mercato non regolamentate possono portare a squilibri significativi, con impatti profondi anche sui territori.
Le scienze sociali possono utilizzare una pluralità di chiavi di lettura per leggere le trasformazioni del capitalismo contemporaneo attraverso il binomio visibilità/invisibilità, tramite lo studio dei meccanismi di rappresentanza degli interessi e le relazioni industriali, della regolazione formale e informale del lavoro, dei processi e delle forme organizzative, del welfare, delle forme di solidarietà e di conflitto; delle politiche pubbliche in vari campi, tra cui l’istruzione, le politiche industriali e dello sviluppo, le politiche del lavoro; lo studio del rapporto tra tali assetti istituzionali, le diseguaglianze e la stratificazione sociale; la diversità di risorse di potere attivabili da singoli e da gruppi; l’analisi delle varie forme di povertà; delle piattaforme e delle trasformazioni digitali; dell’innovazione; delle migrazioni; delle professioni; dello sviluppo territoriale e dei luoghi; dei settori economici tradizionali come ad esempio la manifattura ma anche dei settori dei servizi a basso e alto valore aggiunto; lo studio della transizione energetica e digitale; il rapporto tra sistema socio-economico e questione ambientale.
Il convegno si propone di essere un luogo di riflessione, approfondimento e contaminazione tra approcci diversi, che utilizza tali chiavi di lettura per comprendere le dinamiche del capitalismo contemporaneo, per rendere visibile ciò che non lo è e per poter poi adottare politiche che vadano verso un sistema economico più equo e orientato alla sostenibilità ambientale e sociale. La call for sessions invita a proporre sessioni tematiche che permettano di presentare le ricerche e le riflessioni delle studiose e degli studiosi di sociologia economica, dell’organizzazione e del lavoro, delle altre sociologie e discipline vicine alla nostra, come ad esempio la demografia, il diritto del lavoro, l’economia e la scienza politica.
Nel proporre una sessione, è importante considerare sia la rilevanza analitica del tema individuato, sia la disponibilità a contribuire di studiose e studiosi attualmente impegnati sul tema e interessati a partecipare al convegno.
Saranno privilegiati temi ampi e potenzialmente in grado di raccogliere al proprio interno numerosi contributi specifici. Questo anche con lo scopo di favorire e incentivare il dialogo, il confronto e la discussione fra le molteplici prospettive che animano la sociologia economica italiana, arricchendo le singole sessioni di apporti culturali e metodologici fra loro differenti, e più in generale valorizzando le differenze interne al convegno stesso.
Le proposte, corredate da un breve abstract di circa 2.000 battute e dal nome dei coordinatori o coordinatrici, sono da inviare entro il 19 luglio all’indirizzo mail: segreteria.sisec@gmail.com.
Ciascuna sessione non può prevedere più di tre coordinatori o coordinatrici e non è possibile proporsi per il coordinamento di più di una sessione.
La comunicazione dell’esito della call for sessions, e la conseguente apertura della call for papers, sarà data lunedì 2 settembre 2024.